|
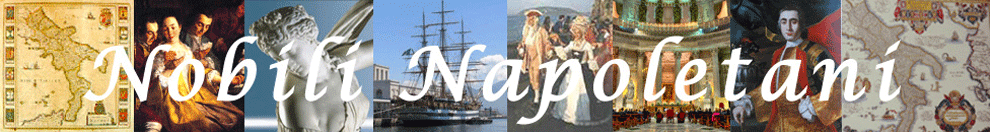
Ovvero delle Famiglie
Nobili e titolate del Napolitano, ascritte ai Sedili
di Napoli, al Libro d'Oro Napolitano, appartenenti
alle Piazze delle città del Napolitano dichiarate
chiuse, all'Elenco Regionale Napolitano o che
abbiano avuto un ruolo nelle vicende del Sud Italia.
|
|
Arma: d'oro, al grifone di rosso, col capo d'oro a quattro
pali di rosso. |
|

Stemma famiglia de Monaco |
|
La nobiltà generosa dei
“de Monaco”
viene accertata nel 1856 in occasione dell’ammissione di
Palmerindo
nella Compagnia delle Reali guardie del corpo a cavallo
di Sua Maestà Francesco II, Re delle due Sicilie. Le
prove presentate dall’aspirante ed i relativi verbali
della specifica Commissione erano riportati a pag. 280
del vol. X ed alle pag. 87 e 246 del vol. XI del Libro
degli atti della Commissione, libri che, come l’intera
documentazione di quel periodo storico, trasferita a San
Paolo Belsito, dalla Sovrintendenza archivistica di
Napoli con l’intento di preservarla da eventuali eventi
bellici, sono stati dati alle fiamme dai tedeschi in
ritirata nel settembre 1943. Purtroppo anche la
documentazione di famiglia, custodita nel palazzo avito
di Cassino, raso al suolo dalle fortezze volanti
alleate, ha subito la stessa sorte. Queste nefaste
circostanze hanno impedito di ricostruire la completa
storia araldico-nobiliare della famiglia. Il nostro
compito è stato quello di cercare di risalire
indirettamente alla conoscenza di quelle prove che
attestano lo status nobiliare riconosciuto a Palmerindo.
Le prime notizie sulla famiglia de Monaco, se pur molto
vaghe, risalgono alla seconda metà del ‘700 e si
riferiscono a Palmerino, figlio di Giovanni,
vissuto in quegli anni a San Germano (1745
†
1823), l’attuale Cassino.
Della sua vita veniva ricordato molto poco; si
tramandava che vivesse agiatamente
“more nobilium”
e che avesse avuto numerosa prole, della moglie non si
conosce, tutt’ora, il nome, tanto meno il casato così
come si ignora il luogo dove sarebbero state riposte le
sue spoglie. Non si è mai saputo, infatti, se la
famiglia avesse avuto o meno un patronato gentilizio su
qualche Cappella con eventuale diritto di sepoltura.
L’unico antico documento in possesso della famiglia è
una planimetria del
territorio (comprensivo di mulini e valcheria) posseduto
da Gennaro de Monaco. Il suo stato di latifondista è
indiscutibile. Certamente ben maggiori dovevano essere i
possedimenti di Palmerino; si tramandava che confinavano
con quelli amministrati dall’Abbazia e si estendevano su
un territorio che spaziava dal fiume Liri al Gari verso
Sant’Angelo in Theodice; da Villa Santa Lucia alla
frazione del Pisciariello. |
|
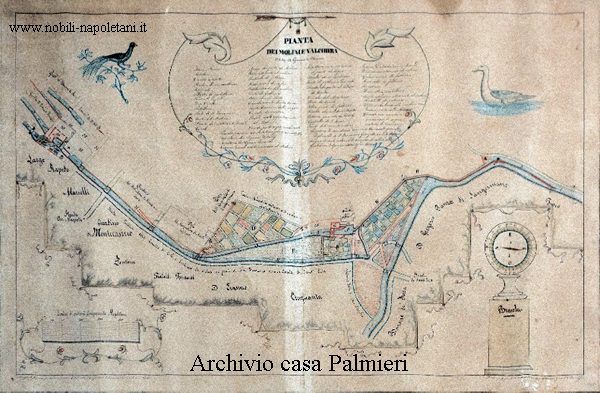
Antica planimetria dei
“mulini e valcherie” di Don Gennaro di Monaco
(Archivio casa Palmieri) |
|
Napoli, Cappella de
Monaco, intitolata al Santissimo Crosifisso. Di seguito:
stemma partito de Monaco e ?, e stemma
inquartato de Monaco con le famiglie imparentate, nel 4°
Buccino Grimaldi |
|
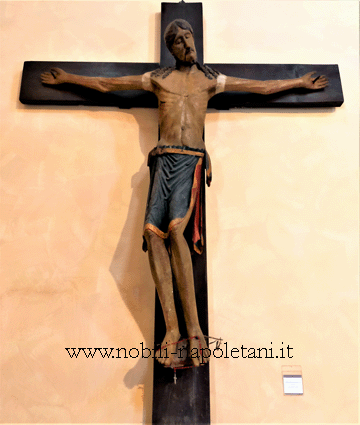
Crocifisso a quattro
chiodi in legno e dipinto del XII secolo proveniente
dalla Cappella de Monaco. A seguire dipinto del
Calvario del 1551
proveniente sempre dalla Cappella de Monaco |
|
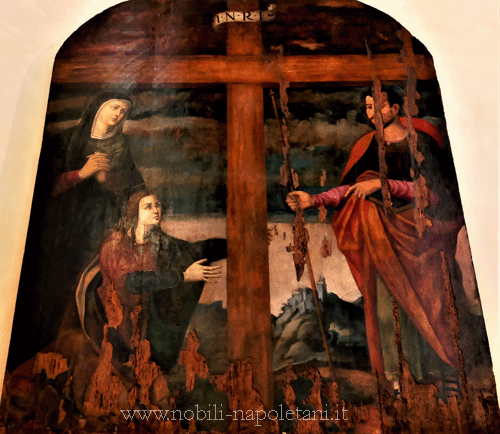 |
|
Il fatto che in famiglia poco o nulla si sapesse del
lontano passato non deve meravigliare. In presenza di un
esclusivo potere esercitato dall’Abate di Montecassino
sul territorio, la struttura delle grandi proprietà
rurali era fondata sulle masserie e non sul feudo la cui
stessa esistenza avrebbe probabilmente potuto offrire
una precipua storia. L’unica cosa che si può dire è che
la famiglia de Monaco non ha origini francesi o
monegasche bensì locali risalenti ai primi anni del
Medioevo quando si appellavano in questo modo coloro che
abitavano nelle vicinanze di un monastero.
Nel 1806, quando i francesi occupano il Regno di Napoli
e sopprimono gli ordini religiosi confiscandone i beni,
anche quelli dell’Abbazia di Montecassino vengono messi
all’asta; ad acquistarli sarà Palmerino Monaco per la
cifra di 70.000 ducati che, a restaurazione avvenuta, li
restituirà al Monastero senza pretendere alcun rimborso
(1).
Non si conosceva lo specifico fatto ma ben noti
erano i rapporti intercorsi nei secoli tra i de Monaco e
l’Abbazia, rapporti che, se pur
formali ed esclusivamente di devoto rispetto verso
l’Abate pro tempore, sono stati
mantenuti fino agli anni 50 del XX secolo.
A sottoscrivere l’atto d’acquisto, il 2 febbraio del
1809, nella sede dell’Intendenza di finanza di Napoli,
dinanzi al notaio Emmanuele
Caputo,
sarà il secondogenito di Palmerino, Giuseppe
Monaco, il primo di cui si avevano notizie certe,
residente a Napoli e
“qualificatosi dottore”,
che sottoscrive, in nome e per conto del padre, l'atto
di acquisto.
Alla morte di Palmerino (1823), sarà questi,
utrusque juris doctor,
a cercare un accordo tra i membri della famiglia per la
divisione dell’asse ereditario. La cosa non dovette
essere stata di facile attuazione e dovette causare non
pochi malcontenti se si tramanda che lo stesso, da anni
trasferitosi a Napoli, una volta portato a termine il
compito, giurò di non tornare più nei luoghi natii.
Del primogenito Benedetto e dei suoi eredi poco o
nulla si sa. Egli, nato nel 1773, fu sindaco nel biennio
1814/1815 e nel quinquennio 1826 /1831. Il figlio di
Benedetto, Domenico, nato nel 1807, fu sindaco di
Pignataro dal 1847 al 21 gennaio 1852, giorno della sua
morte. Giuseppe di Monaco, probabilmente figlio
di Benedetto, fu tra i consiglieri provinciali eletti a
Cassino nel periodo 1861 – 1925
(2).
Di più non si sa.
Se non si ebbero più rapporti con i consanguinei, furono
certamente mantenuti, invece, stretti rapporti con il
territorio e non solo per motivi di interesse. Ciò si
può dedurre dal fatto che dopo due generazioni una de
Monaco (Filomena) sposa Pietro Cacchione di
Sant’Elia Fiumerapido, proprietario ed imprenditore
tessile; Consigliere Comunale del comune di Sant’Elia,
parteciperà alla seduta del 1° agosto 1862, nella quale,
in adesione alla disposizione governativa, si deliberò
di modificare il nome in
“Sant’Elia fiumerapido”.
Una generazione successiva, un’altra de Monaco,
Angelina, sposerà l’avvocato Aurelio Jucci,
appartenente ad una antica famiglia di Cassino. |
|
Giuseppe Monaco (de) sposa Anna Rossi (de), e va
ad abitare nel Palazzo del Principe d’Avellino in Largo
proprio Avellino nella zona del Decumano (tra via dei
Gerolomini e via Duomo) eleggendolo a dimora della
propria famiglia. Qui nasceranno poi tutti i suoi
discendenti (gli ultimi saranno i figli di Palmerindo
jr.).
Il Palazzo, una volta tra i più lussuosi della città,
dopo anni di totale degrado, è stato attualmente
sottoposto a complessi interventi di restauro da parte
della Fondazione
“Morra Greco”
per essere destinato ad attività espositiva museale.
Benedetto Croce in
“Napoli nobilissima”
(così come il Celano ed altri) riferisce che era stato
edificato alla fine del XIV secolo da Giacomo De Santis
per volontà di Jacopo
Gambacorta
per le sue figlie
Lucrezia,
andata in sposa a Giovanni de
Rossi
(che ebbe numerosa prole tra cui Porzia madre di
Torquato Tasso) e Beatrice andata in sposa a
Giambattista
Caracciolo,
capostipite della famiglia Caracciolo d’Avellino. |
|
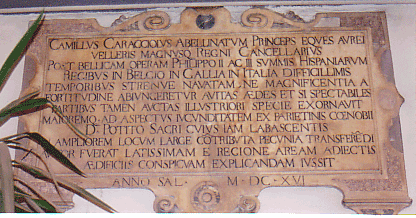
Lapide presente nell’androne del palazzo
Caracciolo-Rossi |
|
Anna Rossi discende dai Rossi di Parma, potentissima
famiglia di antica nobiltà longobarda che scrisse la
storia del settentrione d’Italia (Girolamo Baldinotti di
San Secondo (Parma), arditi condottieri e capitani
d’arme, combatterono tutte le guerre della loro epoca.
Ebbero importanti parentele con le primarie famiglie
nobili e, nella Chiesa, alti prelati. Uno di essi,
Giacomo o Iacopo, fu Podestà di Pistoia nel 1284.
A causa di avvenimenti politici avversi, come si
apprende dall’opera
“Biografia Pistoiese”
di Vittorio Capponi (1878) e da altri scritti, i Rossi
furono costretti a lasciare
Pistoia: un ramo emigrò a Firenze nel 1431, un altro a
Napoli ed un terzo a Cosenza. Il
ramo napoletano, non secondario a quello di Parma,
rimase potente e nobilissimo.
Dai Rossi di Firenze, discende il Cardinale Luigi de
Rossi, figlio di Lionetto e Maria di Piero
dei Medici,
sorella di Lorenzo il Magnifico. Luigi de Rossi era,
quindi, cugino di Papa Leone X (nato Giovanni de'
Medici) figlio di Lorenzo e di Clarice
Orsini, e
del Cardinale Giulio de' Medici (Papa Clemente VII),
figlio di Giuliano dei Medici, ucciso nella congiura dei
Pazzi, fratello di Lorenzo il Magnifico.
Dal ramo napoletano discende Porzia de Rossi, madre di
Torquato Tasso.
“Quasi nel tempo medesimo, fuggendo le discordie della
patria, un altro ramo prendeva domicilio in Napoli, dove
possedè ricche baronie. Di questo ramo un Giovanni De
Rossi fu onorato della Vicaria di Napoli, che tenne con
onore per molti anni; e dìsposatosi a Lucrezia della
nobile famiglia pisana dei Gambacorti, n'ebbe da lei
quella Porzia, che unitasi poi a Bernardo Tasso, fu
madre del gran Torquato”
(3).
Il fratello di Porzia, Fabio, acquistò la baronia di S.
Vincenzo in provincia di Cosenza dando origine al ramo
calabrese
(4). |
|
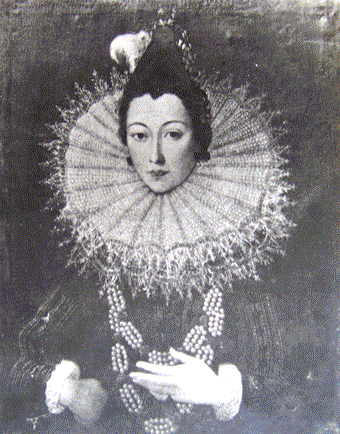
Porzia de Rossi, madre di
Torquato Tasso |
|
Nel 1804 da Giuseppe de Monaco ed Anna Rossi (de) nasce
Gennaro che inizia gli studi di diritto molto
tardi e si laurea il 27 novembre 1848 a 44 anni quando
già erano nati i figli Palmerindo (1837) e Giuseppe
(1841).
Gennaro sposa Angelica
Buccino Grimaldi di nobile ed
antica famiglia.
Se si hanno poche notizie sulla famiglia de Monaco,
moltissime sono quelle sulla famiglia di Angelica
Buccino.
Per non andare troppo indietro nei tempi, possiamo
partire da Alessandro Buccino che, non avendo figli,
istituisce un maggiorasco a favore dei discendenti del
fratello Pietro Antonio.
“…Questi, nato il 27 settembre 1680, fu famoso avvocato
e dal
suo matrimonio con Isabella Preziosi ebbe sei figli
maschi dei quali Biagio fu
sacerdote e dottore in utroque, Giuseppe, parimenti
dottore, fu abate di San Michele,
Marco fu sacerdote e Michele gesuita; Flaviano sposò una
figlia del famoso avvocato
Luca Sergente e Prospero, primogenito nato nel 1713, che
ereditò la casa e successe pure nel vistoso
maggioritario fondato dallo zio. Datosi all’avvocatura
nella quale eccelse, accumulò anche egli grandi
ricchezze (possedeva vari palazzi in Napoli fra cui uno
sontuosissimo tutto contornato da giardini alla montagna
sopra Foria e case di villeggiatura a Mercogliano e
Pollena)”.
Prospero Buccino sposa Orsola
di Palma, figlia di
Domenico Antonio e Camilla Tiberi, nobile di Arezzo, che
porta nella famiglia Buccino anche il patronato
gentilizio (ereditato dalla famiglia Caracciolo Gaetani)
della Cappella di S. Giovanni Battista in S. Gregorio
Armeno.
|
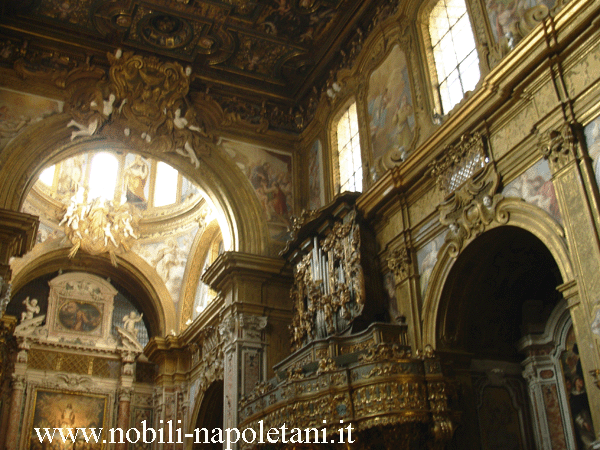
Napoli, Chiesa di
San Gregorio Armeno |
|
Napoli, Cappella
di S. Giovanni Battista |
Dei figli di Prospero Buccino e di Orsola di
Palma sopravvissero due maschi e tre femmine. Di queste
ultime, sappiamo che una sposa il marchese
Confalone ed
un’altra il marchese di Spezzano di casa
Muscettola.
Biagio, il secondogenito, nato il 24 febbraio 1767 e
morto il 26 novembre 1846, sposa nel 1793 Diana Angelica
Grimaldi ed il primogenito Pietro Antonio, nato nel
1747, sposa Porzia
Grimaldi, sorella della precedente,
figlia primogenita del marchese Francesco Antonio
Grimaldi di Seminara dei Principi di Monaco e di Aurora
Barnaba.
Della famiglia Grimaldi, ricorderemo che
“…Francesco Antonio Grimaldi di Seminara dei principi di
Monaco (nato nel 1741 e morto nel 1784), patrizio
genovese, direttore del Ministero di Guerra e Marina,
creato marchese da Re Ferdinando IV fu uno degli uomini
più illustri dell’epoca. Pittore, musicista, avvocato,
storico, filosofo, inventore; ad una grande bontà di
cuore accoppiava tutte le qualità dell’enciclopedico
come stanno a provare le opere di vario argomento da lui
pubblicate a cominciare da quel trattato “de
successionibus” agli “Annali del Regno di Napoli” di cui
videro la luce solo 10 volumi a causa della prematura
scomparsa che lo colse a soli 42 anni, morte forse
causata dal dolore per la perdita della madre e di altre
cinque persone di famiglia (decedute per il terremoto
che interessò gran parte della Calabria) e subito dopo
della moglie Aurora Barnaba figlia del conte Pietro
Barnaba...”(Araldica
–
maggio 1950 pag. 138
“I titoli nobiliari calabresi”
di Carmelo Arnone)
“…I Barnaba erano antichissimi del Regno di Napoli ed
avevano la loro Cappella nel Duomo di Napoli dove sono
sepolti Covello, che fu Presidente della Regia Camera,
ed il fratello Lucio, comandante di cavalleria, e
Sebastiano che fu regio consigliere e Giovanni Camillo
che anch’egli esercitò altissimi uffici. Da questi
discesero Sebastiano che fu Vescovo di Potenza,
Vespasiano, dottore in legge, e Fabrizio che fu ascritto
alla nobiltà di Pisa e fu Cavaliere equestre di S.
Stefano. Questi tre fratelli nel 1580 si rivolsero al re
per aver riconosciuto la loro nobiltà. Con sentenza del
Sovrano Regio Consiglio del 14 luglio 1581 furono
dichiarati nobili col diritto di godere di tutti gli
onori, dignità e privilegio di cui godevano tutti gli
altri nobili fuori seggio...”.
In assenza di figli maschi, dopo la morte di Pietro
Barnaba, il titolo di marchese passa alla figlia
primogenita di Francesco Antonio Grimaldi e di Aurora
Barnaba, Porzia, e, quindi, alla famiglia Buccino nella
quale, poco dopo, per l’estinzione della famiglia
Barnaba, passano anche gli altri titoli della famiglia.
Pietro Antonio Buccino e Porzia Grimaldi avranno 14
figli molti dei quali muoiono in tenera età. Dei figli
maschi solo il primogenito Giuseppe Maria, nato nel
1794, avrà figli. Delle femmine, Maria Luisa sposa in
prime nozze Domenico Capecelatro dei duchi di Morcone ed
in seconde nozze il marchese Achille
Paternò, Aurora
sposa Nicola Bevere,
Angelica sposa il nobile Gennaro de Monaco
e Carolina, già vedova di Luigi
Pinto, sposa il marchese
degli Uberti. |
|
Gennaro de Monaco ed Angelica
Buccino Grimaldi
avranno quattro figli. Delle femmine, Filomena,
sposa Pietro Cacchione di Sant’Elia Fiumerapido; rimasta
presto vedova e senza figli, raggiungerà il fratello
Giuseppe a Napoli; Giulia, sposa de Peruta ed
avrà due figlie, Bianca e Maria che sposano
rispettivamente Giuseppe Gigli e Ragucci. |
|

Don Gennaro de Monaco
(Figlio di don Giuseppe de Monaco e di donna Anna Rossi
di San Secondo)
( Quadreria di casa Modica de Mohac) |
|
Dei figli maschi, il secondogenito Giuseppe, nato
nel 1841, sposa Letizia
Cavalcanti
(1842 † 1871)
dei Marchesi di Verbicaro
figlia di Alessandro ed Elisa Berger
(una cui nipote Antonia,
figlia di Federico Persico e di Barbara Cavalcanti
sposerà lo statista
Francesco Saverio Nitti),
avrà due figli che moriranno in tenerissima età
contagiati dalla madre deceduta per una infezione, forse
puerperale. Fu insigne avvocato del Foro napoletano. Da
agricoltore lungimirante, modernizzò le aziende agricole
possedute nel cassinate (Cassino e Pignataro Interamna)
e nel napoletano (Marano, Madonna dell’Arco,
Sant’Anastasia) ricevendo riconoscimenti e premi. Uomo
integerrimo e molto religioso, dopo la morte della
moglie e dei figli, si prese cura dei nipoti che
ricambieranno l’affetto ricordandolo ed esaltandone la
personalità. Giuseppe de Monaco morirà a Napoli il 21
aprile 1921. |
|

Donna Letizia Cavalcanti dei marchesi di
Verbicaro moglie di don Giuseppe de Monaco
(Quadreria di casa Modica de Mohac) |
|
Il primogenito Palmerindo,
nato il 23 giugno 1837, è ammesso nel 1857 nella
Compagnia delle Reali Guardie del Corpo; sposa Natalia
dei marchesi Anselmi da cui avrà numerosa prole e morirà
ad Alessandria d’Egitto il 7 settembre 1897. |
|
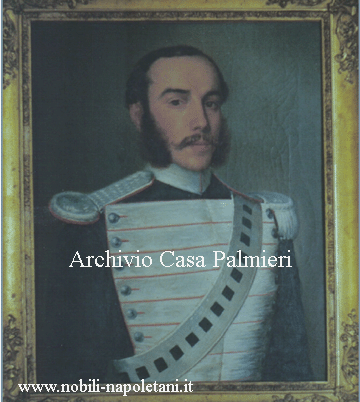
Don Palmerindo de Monaco
(Figlio di don Gennaro e di donna Angelica Buccino
Grimaldi)
(Quadreria casa Palmieri) |
|
La sua, sarà una vita intensa ma sfortunata. Nominato
Alfiere l’11 luglio 1859 della Reale Guardia del Corpo,
sarà fra i 17 alfieri che seguiranno il Re a Gaeta
durante il lungo assedio (12 settembre 1860 – 15
febbraio 1861)
(5).
Raggiungerà, quindi, Roma dove continuerà a prestare
servizio presso il Sovrano ancora per alcuni anni. A
Roma, si unirà a quel folto gruppo gravitante intorno
alla Corte formato da gran parte della nobiltà
legittimista partenopea, da ecclesiastici, da
avventurieri e da militari
“sbraitanti
e spavaldi”,
come li identifica sprezzantemente lo storico De Cesare,
tutti impegnati in piani strategici più o meno
fantasiosi nell’illusione di riconquistare il Regno.
Rientrato a Napoli, cerca di reinserirsi in un contesto
sociale non certo benevolo verso chi aveva dimostrato
fedeltà alla deposta Dinastia. Da banchiere opera
all’ombra dei Rothschild nei territori dei suoi avi,
scelta questa quanto mai avventata che condizionerà
tutta la sua vita; a seguito di operazioni non andate a
buon fine a cui si aggiunse la fiducia mal riposta in
alcuni collaboratori, si troverà coinvolto in un crac
finanziario da cui non si risolleverà più. Per tenere
fede agli impegni assunti e per salvare l’onore della
casata, cercò di ripianare le perdite con interventi
drastici i cui effetti si ripercuoteranno sull’intera
famiglia: del notevole patrimonio non solo immobiliare,
infatti, nulla resterà nella disponibilità dei figli.
Fortunatamente gran parte dello stesso patrimonio sarà
riacquistato dal fratello Giuseppe.
Nel 1877 viene nominato Console Generale del Cile. La
concessione formale dell’Exequatur da parte del Sovrano
viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno di
Italia n. 283 del 4 dicembre 1877). Rappresentare la
Repubblica cilena non era, certamente, di poco conto;
Palmerindo doveva essere in quegli anni all’apice
dell’attività professionale e dobbiamo ritenere che
intrattenesse anche rapporti di notevole rilevanza con
personaggi dei paesi dell’area dell’America
centromeridionale e non solo. A quei tempi Napoli era,
infatti, una delle città europee più attive in campo
culturale, commerciale e finanziario; il porto
movimentava un notevole flusso di uomini e merci verso
il nuovo mondo. (Il Prof. Luigi De Rosa nello studio
“Emigranti,
capitali e banche”
fa risalire proprio a quegli anni l’inizio
dell’emigrazione italiana verso quei paesi).
I figli maschi non lasceranno eredi ed orgogliosamente
le sorelle aggiunsero sempre il loro cognome a quello
dei mariti.
Dei maschi, Gennaro, Avvocato dello Stato e Primo
dirigente del Ministero della Giustizia, fu colto
conferenziere ed autore di racconti e poesie. Morirà
scapolo a Napoli il 28 aprile 1924.
Domenico, ingegnere, lavorerà in Italia ed
all’estero. Sposa Irene Siradinò, cittadina turca nata a
Smirne. Agli inizi del XX secolo è in Sud America dove
collaborerà anche alla progettazione della prima
metropolitana dell’America centromeridionale, quella di
Buenos Aires che, sarà inaugurata nel 1913, ed alla
esecuzione di opere connesse alla apertura del Canale di
Panama. Al rientro in Italia, eleggerà domicilio a Roma
dove lavorerà molto anche nella progettazione di una
linea metropolitana che non vedrà realizzata e rientrerà
a Napoli nel 1927 (quando gli fu diagnosticato un
tumore) dove morirà il 13 gennaio 1929. Sulla presenza
in America centromeridionale e sull’attività
professionale svolta potremmo ritenere che abbia potuto
influire direttamente o indirettamente i rapporti a suo
tempo intrattenuti dal padre.
Delle figlie, Maria Sofia (così battezzata in
omaggio a quella Regina di Napoli che il padre aveva
servito con devozione e lealtà) nata il 26 aprile 1870 e
morta il 30 gennaio 1945, sposa il Cavaliere avvocato
Luigi Giannattasio, nobile famiglia solofrana,
(5-10-1862
†
17/01/1930) dirigente dell’Ufficio legale e Segretario
Generale del Comune di Napoli. Dal matrimonio nasce il
17 dicembre 1913 la figlia Anna che sposa il 3 gennaio
1934 l’ingegnere Giuseppe Alberto Palmieri (ramo dei
Palmieri di Monopoli) figlio del dott. Raffaele,
Direttore di sanità del 7° Corpo d’Armata e di
Pasqualina Massara Suriani.
Angelina sposa l’avvocato Aurelio Jucci di
Cassino ma non avrà figli. Muore in Napoli il 22
novembre 1956.
Emilia, nata il 7/11/1874, sposa il dott. Michele
Landolfi
di nobile famiglia solofrana magistrato. Muore a Palermo
il 12 maggio 1958. Dei figli, Teresa sposa Francesco De
Blasi, Funzionario del Banco di Sicilia; Maria sposa
Marco Modica de Mohac, Professore universitario;
Filomena, rimarrà nubile; Livia sposa il dott. Francesco
Coppola, Dirigente del Banco di Sicilia.
Natalia, nata nel 1878, sposa l’ing. Carlo Forte
e muore in Napoli il 30 dicembre 1962. Dei due figli
maschi, Oreste muore in giovane età in un incidente
automobilistico avvenuto sulla provinciale Cassino –
Formia nei pressi dalla
“Marchesella”,
antica azienda agricola dei de Monaco in tenimento di
Pignataro Interamna; Nicola, ingegnere, sposa Maria
Rosaria Stile. Delle tre figlie, Anna sposa il dott.
Giuseppe Santucci, Ufficiale medico che raggiungerà poi
il grado di generale, Assunta sposa il dott. Francesco
Iervolino, Dirigente del Credito Agrario del Banco di
Napoli, e Maria Antonietta sposa Giuseppe Massarotti,
ufficiale dell’esercito che raggiungerà anch’egli il
grado di generale. |
|
Con la loro morte si estingue questo ramo della famiglia
de Monaco. Il loro sangue continuerà a scorrere nelle
vene dei numerosi discendenti. |
|
_______________
Note:
(1) -
Luigi Serra
“La vendita all’asta dei mulini di
Cassino confiscati all’abbazia di Montecassino”
anno 2012 n. 2 della rivista “Studi
Cassinati, bollettino trimestrale di studi storici del
Lazio Meridionale”.
(2) - Cfr.
“I luoghi
del potere provinciale nell’alta terra di
lavoro tra Repubblica napoletana, regime
borbonico e Unità d’Italia”
del prof. Gaetano De Angelis.
(3) -
“Biografia Pistoiese”
di Vittorio Capponi (1878).
(4) - Cfr.
“Notizie storiche di Montalto di Calabria”
di Carlo Nardi;
“Collana di studi araldici - Famiglie Nobili e titolate
del Napolitano, ascritte ai Sedili di Napoli, al Libro
d'Oro Napolitano, appartenenti alle Piazze delle città
del Napolitano dichiarate chiuse, all'Elenco Regionale
Napolitano o che abbiano avuto un ruolo nelle vicende
del Sud Italia”.
(5) - Cfr.
pag. 15 del
“Ruolo dei
Generali ed Uffizziali Attivi e Sedentari
del Reale Esercito e dell’Armata di mare di
Sua Maestà il Re”
- Reale Tipografia Militare 1860. In
questo volume i nomi degli ufficiali che seguirono il
Sovrano sono indicati in verde. |
|