|
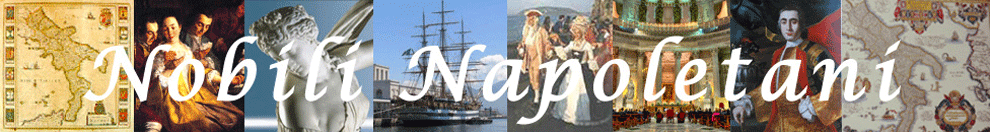
Ovvero delle Famiglie
Nobili e titolate del Napolitano, ascritte ai Sedili
di Napoli, al Libro d'Oro Napolitano, appartenenti
alle Piazze delle città del Napolitano dichiarate
chiuse, all'Elenco Regionale Napolitano o che
abbiano avuto un ruolo nelle vicende del Sud Italia.
|
|
 |
Famiglia Velez di Sicilia |
|
A
cura del Dott. Mario D'Angelo |
|
Arma: inquarto; al 1° e 4° d'oro,
con tre sbarre cucite d'argento caricate da ermellini di nero,
nel 2° e 3° d'argento, con cinque cuori di nero posti in croce
di S. Andrea. |
|
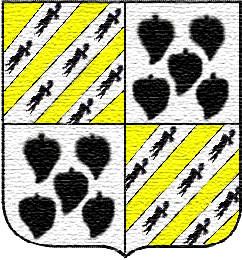
Arma Velez di Sicilia |
|
Antica ed illustre famiglia di origine spagnola che rappresenta
il ramo siciliano di un importante casato spagnolo “Velez de
Guevara conti di Ognate e di Villamediana”, che si è fregiata di
diversi vicerè e molteplici alte cariche alla corte spagnola.
Originaria
della Spagna del nord, Navarra, il ramo principale fiorì in
Spagna (Stirpis Guevarensis Hispanica; un ramo collaterale, (Stirpis
Guevarensis Neapolitana), pervenne nell' Italia Meridionale, nel XV secolo, a seguito della conquista del regno di Napoli ad
opera di
Alfonso V d'Aragona,
1° di Napoli, il Magnanimo, con Inigo Velez de Guevara ed
i suoi fratelli, don Ferrante e don Alfonso
(1435-1442), figli di Pedro Velez de Guevara, signore di
Ognate e di Costanza de Tovar, per poi diramarsi nell'Italia, ed
altri a Malta, e poi in Sicilia (Guevarensis Stirps Hispanica
pariter et Neapolitana Historia Italie ed Hispaniae Genealogica
– J.W.Imhof). |
|

Inigo Velez
de Guevara e Tassis,VIII conte
di Ognate, vicere' di Napoli (1648-1653) |
|
Nel
mentre il ramo maltese si estingue sul finire del XVI secolo (Abela
– descrittione di Malta), in Sicilia, a Siracusa, pervengono dei
collaterali cadetti con Antonio nel 1513, e Giovanni
nel 1560, che ottiene il titolo di regio cavaliere, e
Antonio Velez, maestro notaro tra il 1576 e il 1584, del
caricatore dell’Agnone e della torre di Bruca e del porto di
Augusta.
Si espandono poi in altri luoghi dell’isola e ne vengono fuori
una serie di giurati e capitani di giustizia. |
|
La famiglia si restringe ad Alcamo, ove fissa la sua dimora, tra
il 600 e il 700, edifica un secondo palazzo magnatizio alle
spalle della Cattedrale. |
|
 |
 |
|
Col Mango, il Villabianca, il Palazzolo Gravina e il Di Blasi ed
altri araldisti, si possono menzionare:
- Francesco Velez, capitano di giustizia a Patti
(1645-1646). .
- Angelo ufficiale della Real Conservatoria (1670).
- Didaco
Velez de Guevara fu cavaliere del S.M.O. di Malta (vedi
lapidario).
- Un Marcello provveditore dell’esercito, e poi nominato
maestro razionale e conservatore del Real Patrimonio con Real
cedola datata 9 ottobre ed esecutorio a 20/12/1679) con
giuramento del 15/08/1683.
La nomina non deve stupire perché l’ufficio dei funzionari
addetti ai pagamenti militari , “ufficio di contador”, era
ancora a carico del conservatore del real patrimonio.
- Un Ignazio capitano di giustizia a Cefalù (1695 –
1696). …
- Un Antonio, giurato ad Alcamo (1740-1741), secreto
(1749), giudice delle appellazioni (1750 – 1751), governatore di
Alcamo (1784 - 1785), indicato dal Villabianca come Velez de
Guevara y de la Pegna, barone di Pedagaggi, membro
dell’Accademia dei Geniali fondata a Palermo nel 1717 da Gaetano
Giardina. Il Velez è autore di diversi discorsi e sonetti che si
possono ancora consultare tra i manoscritti della biblioteca
comunale di Palermo. Sposa Eleonora Gerbino di Cannitello figlia
del barone Giovanni Gerbino di Cannitello. |
|
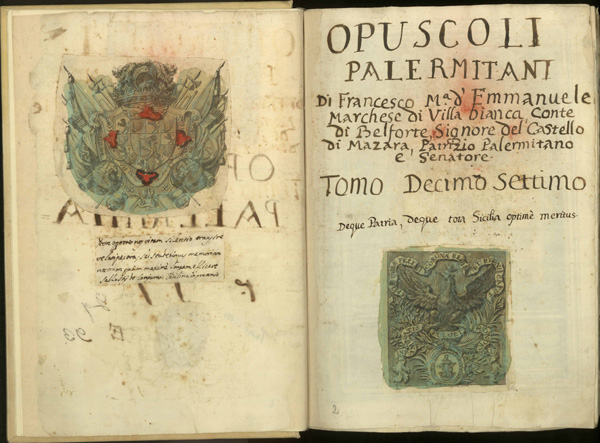
Villabianca, opuscoli palermitani, tomo XVII, nobiliario
genealogico della città di Palermo
Biblioteca palazzo Marchesesi - Palermo |
|
- Giovanni di Antonio, sindaco 1777 - 1778 e giurato
1784, 1785,
- barone Giovanni, giurato ad Alcamo 1812, 1813 (†
1871) II^
indizione del 1812.
- Un Gaetano, barone e sindaco di Alcamo (1826 – 1827),
membro onorario dell’Accademia Pontificia Romana di Belle Arti ,
detta di San Luca. Sant'Apollinare (1817).…
Sul finire dell’Ottocento i Velez si trasferiscono a Palermo
acquistando nella persona del barone Giovanni Battista, all’Albergheria,
il Palazzo che fu di Gaspare Miano, (1788), razionale del real
patrimonio del XVIII secolo, rendendo il palazzo ancora più
confacente ai canoni dell’edilizia nobiliare settecentesca.
Fr. San Martino de Spucches, nella sua storia dei feudi di
Sicilia (1925) dà ulteriori notizie di questa famiglia, sia pure
indirettamente parlando della successione del feudo di Bertolino
a Sciacca, rilevando un barone Alfonso, di Giovanni e Antonina
Coppola, che sposa a Palermo Maria Carolina Arone di
Bertolino nel 1853, e il barone Giovanni Battista, figlio di
Alfonso e di Maria Carolina Arone, che sposa a Palermo Concetta
Arone Tagliavia di Valentino nel 1878. Dona nel 1872 alla chiesa
madre di Alcamo del terreno di sua pertinenza per la cappella
della SS. Madonna della Misericordia.
- Giovanni Battista , barone, notaro in Palermo
(1950). |
|

Palermo - Palazzo Velez
|
|
Il caricatore della torre della Bruca,
dell’Agnone e del porto di Augusta |
|
La torre di
Bruca (odierna Brucoli) fu costruita dalla camera reginale di
Siracusa nel 1467 per la difesa dei territori di Bruca,
dell’Agnone e del porto di Augusta e, soprattutto, per la difesa
del caricatore della torre di Bruca.
Il governatore aragonese, Giovanni Cebastide, per ordine della
regina Giovanna, incamera Bruca e il porto canale nel regio
demanio aragonese, facendo costruire il castello a guardia
dell’emporio e dei regi magazzini, ove si ammassavano e poi si
caricavano le merci da esportare nel Mediterraneo e soprattutto
verso la Spagna.
In età aragonese la torre di Bruca fu molto importante, perché
in quel tempo per la quantità di merci esportate, il caricatore
del Bruca superava nei traffici lo stesso porto di Augusta,
ottenendo così notevoli privilegi. Nel 500 la torre si
ingrandisce con una nuova cinta muraria, che da vita a una vera
e propria fortificazione, ulteriormente potenziata nel 600, con
una torre poligonale e una seconda cinta muraria più bassa. Tale
impianto militare aveva resistito ad un primo assalto saraceno
nel 1585 e poi nel 1594, facendo registrare così il fallimento
degli attacchi saraceni sulle coste meridionali dell’isola e
dell’Italia. Il caricatore del Bruca e dell’Agnone, dunque, nel
XV e XVI secolo, garantiva l’esportazione del grano, dei
formaggi, e del vino di tutta la valle di Noto e ciò dipendeva
anche dal fatto che ancora Catania e Siracusa non erano
abbastanza popolate. Dal 600 in poi, però, la valle di Noto non
sarà più in condizione di esportare grano ed altre derrate
alimentari, così i caricatori, da luoghi di esportazione,
diventarono luoghi di importazione della costa centro
meridionale.
Nell’archivio di stato di Palermo si trova l’archivio dei
Visitatori Generali della Sicilia, ove è possibile rilevare i
carichi notificati ad Antonio Velez, maestro notaro del
caricatore dal 1576 al 1584, formulati dai Visitatori Generali
del tempo, Marcello
Pignone, marchese
di Oriolo e di Gregorio Bravo di Santomajor, ed i relativi
discarichi presentati dallo stesso Velez dal 1579 al 1584.
I Visitatori Generali erano alti funzionari della corte, inviati
periodicamente in tutto il regno, per controllare lo stato della
pubblica amministrazione. La loro autorità era notevole, in
teoria superiore allo stesso vicerè, ma andò sempre più
sminuendo nel tempo per la tenace opposizione della nobiltà
locale coinvolta spesso nelle inchieste e nelle indagini dei
Visitatori.
Questi, accertando dopo accurate indagini, le colpe dei
funzionari della pubblica amministrazione, anche dei funzionari
minori, formulavano i carichi, cioè i capitoli di accusa, che
costituivano in fondo il vero scopo della visita. |
|

Brucoli - la Torre |
|
Il Visitatore aveva, di fatto, in caso soprattutto di atti di
estrema gravità e di nocumento alla corona, la facoltà di
sospendere subito il funzionario dal suo ufficio, ma non poteva
emettere una sentenza definitiva. La causa per così dire, che
Bravo de Satomajor chiama processo, veniva inviata e discussa
nel Supremo Consiglio d’Italia a Madrid, che emetteva un
provvedimento definitivo dopo aver ricevuto e valutati i
relativi discarichi degli indiziati (defenziones).
I contrasti insorti tra i Visitatori ed il Vicerè, soprattutto
nella seconda metà del seicento, non furono pochi, per il fatto
che su quest’ultimo si concentravano le proteste della nobiltà
inquisita, che cercava in tutti i modi di limitare l’opera dei
Visitatori.
Per la completezza della nota, comunque, i discarichi presentati
da Antonio Velez dal 1579 al 1584 e da Salvo Bellomo,
magazziniere del caricatore, furono ritenuti pertinenti dal
Supremo Consiglio d’Italia, ed i due non condannati.
|
|
L'Ufficio
del Razionale e del Conservatore del Real Patrimonio nel XVI e
XVII secolo.
Vecchi vizi e vecchie virtù. |
|
Il Conservatore
del Real Patrimonio era un funzionario di origine spagnola
facente parte degli organi di controllo della complessa macchina
amministrativa spagnola del XVI e VVII secolo. Svolgeva il ruolo
di verifica sugli atti del governo, che, per così dire, dovevano
essere vistati e registrati da questo ufficio per avere validità
nella periferia del Regno; prendevano in carico tutto ciò che
concerneva il patrimonio regio e coordinava la complessa
gestione delle attività fiscali.
La necessità di tenere continuamente aggiornata la contabilità
in uscita, ponendola a confronto e in contrapposizione alle
entrate fiscali, era fondamentale per conoscere la disponibilità
di spesa, atta a garantire lo svolgimento di feste
religiose, cerimonie regali, momenti di rappresentanza,
provvedimenti sulle carestie e sulle epidemie e quant'altro
fosse necessario. Bisognava, poi, essere pronti alle repentine
richieste di donativi che provenivano dalla Corte spagnola
sempre in guerra.
Tali solleciti avevano effetti devastanti per la necessità di
raccogliere in pochi mesi le cifre comandate.
Non infrequentemente la Corte proponeva anticipi di donativi
gettando letteralmente nel panico il vicerè e il senato
palermitano. Come atto conclusivo si permetteva di imporre nuove
gabelle, con disappunto e mugugni da parte del vicerè, assillato
così dalle reiterate richieste della corona, e dagli agitati
malumori di un popolino affamato e pronto alla sommossa.
Il Tribunale del Real Patrimonio era costituito da un presidente
e da sei maestri razionali, di cui la metà erano giureconsulti,
e l'altra metà di "cappa e spada", cioè scelti tra la nobiltà
cittadina o membri selezionati della cosiddetta "aristocrazia
degli uffici".
Il maestro razionale non controllava personalmente i libri
contabili ma di fatto, coordinava i razionali e la molteplicità
dei funzionari del suo ufficio. La durata dell'incarico era
annuale e non rinnovabile nei 5 anni successivi.
Le funzioni, i compiti e le responsabilità dei vari uffici e
delle varie figure, tra cui anche quelle dei razionali, furono
però stigmatizzate dai capitoli del vicerè
Colonna nel 1582,
del vicerè Olivarez 1593 e del vicerè Castro nel 1622.
Il razionale era detentore dei libri contabili, "con
l'obbligo di tenere bilanciati e riscontrati li conti in tutto
l'introito ed esito del patrimonio dell'università"
e veniva
integrato nella sua mansione dopo una lettera di conferma del
tribunale del Real Patrimonio.
La carica col tempo esprime un chiaro peso politico, poichè si
poteva contrattare col Protonotaro, nel cui ufficio a volte
veniva letteralmente messa in vendita, o era sottoposta a
scrutinio dai giurati in carica tra un ristretto numero di
selezionati. Nei decenni a venire la sua funzione si amplia e,
allo stesso tempo, si deteriora.
Perde il senso primitivo di puro efficace meccanismo di
controllo sulla contabilità e gestione del bilancio, per
assumere anche una connotazione politica di impiego consapevole
e attivo del patrimonio cittadino.
La nomina diventò molto ambita e ricercata tra la classe
nobiliare e il ceto emergente borghese, contiguo alla gestione
del potere vicereale; e non solo, nell'evolversi degli
accadimenti, avvenne ben altra e grave cosa, che molti maestri
razionali con la complicità dei razionali a loro sottoposti,
falsando ad arte la gestione dei complessi libri contabili,
finivano per impadronirsi di ingenti somme di denaro, investite
poi all'acquisizione di futuri titoli nobiliari da parte delle
famiglie di quei funzionari che provenivano da una borghesdia
concreta e sgambettante o da un ceto togato ambizioso e
lungimirante.
In un clima di palese disagio, la gravità di tali comportamenti
fu avvertita dalla Corte spagnola, che cercò di affrontare con
risoluzione il problema del controllo degli organi
amministrativi e giudiziari periferici, perfezionando le
funzioni del "Visitas" e rendendo più autorevole la figura del
visitatore che, almeno nei primi tempi, era scelto personalmente
dal Re.
Evidentemente alla Corte Spagnola si ripresentavano vecchi vizi
che si cercava di eliminare riproponendo vecchie virtù.
Difatti l'istituto della "Visitas" era stato introdotto dai Re
Cattolici negli ordinamenti di Toledo (1480) a seguito dei quali
la Corte iniziò ad investigare sui funzionari castigliani.
Nell'archivio di stato di Palermo è possibile rilevare la nota
archivistica "Protocollo del regno, ind. 1682, registro 1020,
foglio indice M, foglio 8 verso", in cui è riportata la Real
Cedola della nomina di Don Marcello Velez a maestro
razionale del Real Patrimonio. Il faldone di presenta in
ottimo stato di consultazione.
|
|
L’Accademia dei Geniali Palermo |
|
Nel febbraio del 1719 a Palermo nel Palazzo del Sant'Uffizio,
altrimenti noto come il palazzo della
Santa Inquisizione,
sorgeva l'Accademia dei Geniali, fondata da Gaetano Giardina,
storico (1683
† 1731).
L'Accademia prendeva il nome da un'opera di Antonio Mongitore
"Divertimenti geniali ed osservazioni giunti alla Sicilia
Inventrice di Vincenzo Auria". Essa era retta da un preside e da
sei consultori, aveva per protettrice Santa Rosalia, ed in onore
della stessa, ogni anno si celebrava a settembre una seduta
particolare; le altre riunioni avvenivano ogni domenica nel mese
di settembre, ed una volta nel restante anno, in un giorno
scelto dal preside.
Le signore accademiche non intervenivano nelle adunanze ma
potevano inviare i loro componimenti.
Il Giardina, per i suoi meriti culturali, appartenne anche ad
altri sodalizi e buon oratore, venne chiamato spesso
all'Accademia del Buon Gusto.
Fu abate di San Nicolò e Protonotaro Apostolico, raccolse le
lodi del giornale dei letterati in Italia.
Nello
stesso periodo, primi decenni del secolo decimo ottavo, non solo
a Palermo, ma in molte altre città siciliane, soprattutto
demaniali, si svilupparono circoli ed accademie, come
l’accademia degli Occulti a Trapani, degli Ardenti di Modica,
dei Vaticinanti a Marsala, dei Curiosi di Castelbuono e a
Palermo, degli Agricoltori Oretei, e poi l’accademia del Buon
Gusto, che fu la più famosa ed ebbe vita più lunga e che nasce
sotto la spinta di contestazione al seicento da parte di
Ludovico Muratori.
Tutte
queste accademie rappresentano uno spaccato della storia
letteraria siciliana e riflettono, in certo senso, le tendenze
dei primi decenni del XVIII secolo ad una maggiore diffusione di
istanze culturali che raggiungono l’isola dal resto dell’Italia
e anche dell’Europa, giacché alcuni di questi circoli sono
la localizzazione di schemi nazionali es. l’Arcadia romana che a
Palermo si chiamerà colonia Oretea. |
|
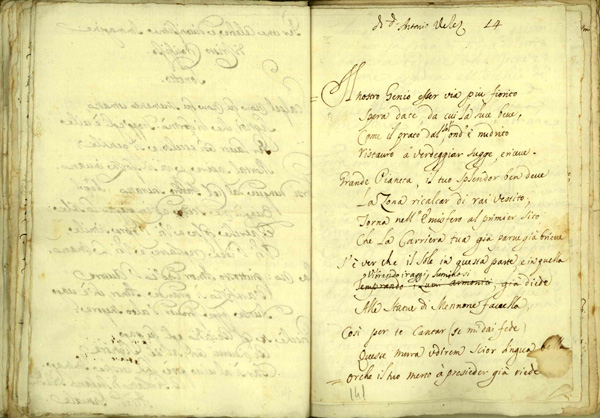
Manoscritto - Sonetto di Antonio Velez |
|
I Geniali pubblicarono, sonetti, canzoni, epigrammi volti a
celebrare l’acclamazione di Carlo VI tutti ridondanti nello
stile e nel contenuto.
Aderirono all’Accademia dei Geniali illustri personaggi: es. la
poetessa Giuliana Lorefice, autrice nel 1723 della “ La dama in
Parnasso” e “Poesie Italiane” e Tommaso Campailla ed altri.
Molti discorsi recitati dal Giardina all’accademia dei Geniali,
insieme alle opere di Antonino Velez, un sonetto e un discorso
sull’origine delle fonti, ( 22 giugno 1721 ) ed una lettera al
canonico Domenico Schiavo, reggitore della cattedrale di
Palermo, sono consultabili tra i manoscritti della Biblioteca
Comunale di Palermo.
L’accademia
dei Geniali ebbe una breve esistenza; legata troppo alla
presenza del suo fondatore, cessò la sua attività, con la
prematura morte del Giardina, avvenuta nel 1731.
|
|
La Cappella della S.S. Madonna dei Miracoli ad
Alcamo |
|
Il
barone Giovanni B. Velez nel 1873 favorì la costruzione,
all’interno della Chiesa Madre, di una Cappella per la S.S,
Madonna dei Miracoli, acconsentendo alla donazione del terreno
necessario alla nuova costruzione.
L’Arciprete
della chiesa Don Giuseppe Virgilio aveva deciso di creare per il
simulacro della patrona di Alcamo, una degna e sontuosa cappella
da porre all’interno della Matrice.
L’immagine
primitiva della Madonna, il cui culto risaliva al 1547, era
stata trovata, dipinta da un pittore sconosciuto, su di un muro
di un antico casale alle falde del Monte Bonifato “stava
questa miracolosa immagine dipinta nel medesimo muro della
volta, o cuba”.
Subito oggetto di devozione da parte di donne fedeli, “con
licenza del vescovo fu detto luogo intorno spianato e fabbricata
una bella chiesa sotto titolo della Madonna dei Miracoli e fonte
di Misericordia a 21 giugno si fa solenne festa con corale
devotione e concorso”.
Ferdinando De Vega et Da Silva, "capitano
di giustizia e castellano di questo castello",
fece costruire sul
luogo una Cappella (1542).
Secondo il Lauria era in nipote di Giovanni De Vega (vicerè di
Sicilia, 1547- 1556), secondo il De Blasi ne era il figliolo.
Allorquando il vicerè fu impegnato con Carlo V in Africa nelle
guerre contro i Turchi (1550), Ferdinando De Vega assunse la
Presidenza del Regno. Il fatto è che , avendo fissato la sua
perenne dimora ad Alcamo, e vivendo nel periodo del ritrovamento
dell'immagine della Madonna S.S. dei Miracoli, partecipò
attivamente alla consacrazione del suo culto. "Fu
principalmente di lei ossequioso veneratore",
tantochè, " volle
prima che la morte il pervenisse spiegare la sua volontà per
testamento, la quale fu di nominare erede quasi di tutto il suo,
la gran Madre di Dio dei Miracoli, destinando alla Chiesa di
lei, moltissimi donativi",
e non solo, ma aggiunse "comandando
che il suo cadavere fosse traslato in questa Chiesa, dove erano
i suoi più teneri amori, per riposare ai piedi della sua
dilettissima Madre".
Nel 1720-1721 fu quindi necessario scolpire una statua, che
venne fatta abilmente in cipresso, per portarla in processione.
Dapprima il simulacro venne portato su di un carro trionfale,
mentre oggi è portato a spalla da sedici devoti, poi la statua
veniva richiusa nel monastero della Badia Grande e nel monastero
della Badia Nuova ove restava per il resto dell’anno; in tal
modo il simulacro veniva sottratto al culto dei devoti, anche
perché, in tale luogo si poteva osservare solo attraverso uno
spioncino. |
|
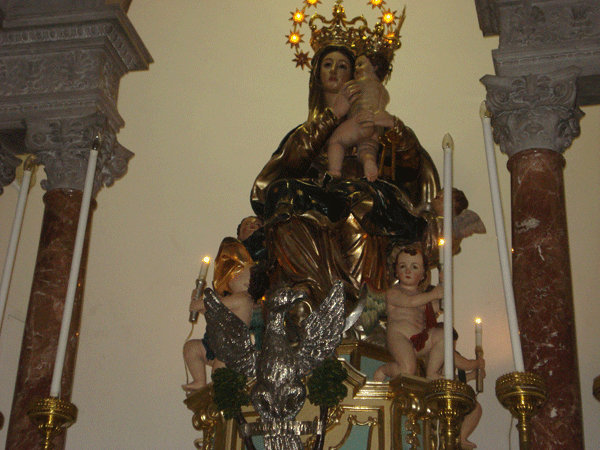
Statua in legno -cipresso, realizzata nel 1720 della Madonna
S.S. dei Miracoli e poi posta all'interno
della cappelletta costruita nel 1845
|
|
L’Arciprete Virgilio, che governò la Matrice per 25 anni, intuì
la necessità di una collocazione definitiva della statua in un
posto più accessibile per i fedeli, che identificò in una
preesistente cappella, di S. Lucia, in fondo, a sinistra, della
navata centrale.
Per la
costruzione della stessa, l'Arciprete commissionò
l'opera a
Giuseppe Damiani Almeyda, il famoso architetto progettista del
Teatro Politeama di Palermo, remunerandolo con un premio di
mille lire.
Ma per garantire la completezza del progetto monumentale, ben
più grande della cappella preesistente, l’Almeyda ebbe bisogno
di un nuovo ed altro spazio che poté trovare solo nel limitrofo
giardino del Palazzo Velez. La famiglia del barone Velez
acconsentì felice alla donazione.
|
|

L'icona di Maria S.S.dei
Miracoli,dipinta sul muro, e rinvenuta nel 1544 |

Alcamo - Esterno
della Cappella della Madonna dei Miracoli
|
|
La morte improvvisa del can. Virgilio avvenuta nel 1876 ed altre
vicende storiche, fermarono il progetto che poté riprendere solo
nel 1920 ad opera dell’arciprete Ignazio Manno, per giungere a
completamento solo nel 1922, quando il simulacro venne collocato
ove si trova tutt’ora.
Una lapide
posta sul muro esterno della cappella, nell’atrio del palazzo,
testimonia la donazione e recita: |
|
Lo stemma che si scorge in alto al centro, con bandiere e
trofei, rappresenta quattro quarti di alleanze matrimoniali:
Gerbino di Cannitello, Rossotti di Pietralonga, Arone di
Valentino, Bellarotto marchesi Mendoza.
Nulla fu posto all’interno della chiesa. |
|

Alcamo - interno Chiesa Madre |
|
Poi negli anni successivi, furono completati i marmi bianchi
dell’altare, gli abbellimenti della cappella, la delicata novità
pittorica all’interno della cupola “ degli Angeli Oranti”, i
decori della colonna, il pavimento e l’organo fino alla visione
attuale.
Sul frontone della nicchia, a caratteri d’oro, si legge il
versetto biblico: |
|
“
Tu honorifecentia populi nostri”.
|
|
Famiglie imparentate con Casa
Velez |
|
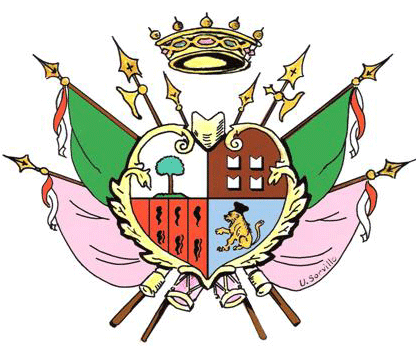
Arma dei Baroni Velez di
Pedagaggi |
|
ARONE
Famiglia
che ha origine milanese e che si trasferisce primariamente a
Palermo e poi a Sciacca dove occupano le molteplici cariche di
capitano di giustizia e senatore. |
|

Arma famiglia Arone |
|
Possedette i
feudi di Mezzo Catuso o Bertolini e di Bonfiglio (1679), posti
nel territorio di Sciacca e Val di Mazzara.
Dopo lunga successione dei signori investiti del feudo di
Bertolino dal 1679 al 1837 si pervenne a: |
|
1)
Maria Carlina Arone,
Figlia di Francesco Arone barone di Bertolino e di Giovanna
Ingrassia, ( seconde nozze 30.1.1838) e che sposa a Palermo (30
luglio 1853) Don Alfonso Velez,
barone di Pedagaggi, di Giovanni e Antonina Coppola.
Maria Carolina muore a Palermo, ad anni 76, il 15.2.1905, con
discendenza.
2) Concetta Arone Tagliavia.
(nata 1° maggio 1855 e morta il 26 luglio 1945), figlia di
Pietro Arone Tagliavia di Bertolino e di Maria Ognibene da
Menfi, che sposa il 4 maggio 1878 a Palermo, Don Giovanni
Battista Velez barone di Pedagaggi, figlio di Alfonso
e di Maria Carolina Arone con 5 figli maschi e 3 femmine cui
segue numerosa discendenza. |
|
GERBINO
Famiglia che godette di nobiltà a Castelvetrano, Mazzara e
Palermo.
|
|
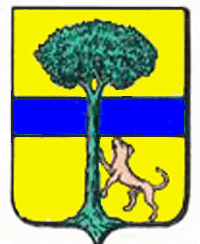
Arma famiglia Gerbino |
|
Nel 1623
Nicolò Antonio Gerbino da Castelvetrano, acquistò i feudi di
Cannitello e Gulfotta a seguito dello smembramento della baronia
del "Milisindino". Tale baronia, gravata da debiti ed ipoteche,
era pervenuta all'ultima erede dei Corbera, Margherita. Per la
sua prematura morte e per disposizione dei giudici delegati
della Gran Corte, il "Milisindino" o "Miserendino", venne
suddiviso in 10 feudi e posto all'asta. Due feudi furono
aggiudicati a Nicolò Antonio Gerbino, senza investitura, e così
giunse da Castelvetrano a Santa Margherita Belice.
La famiglia di divise in due rami: |
|
1)
Giovanni, s'investì del Cannitello il 4 giugno 1646, come
primogenito alla morte del padre, e si perviene dopo alcune
successioni ad Isidora, figlia di Giovanni Gerbino e Franca
Cirafaci, (secondo matrimonio) che sposa il dottore in legge,
barone Antonio Velez de la Pegna di Pedagaggi di Alcamo: ne
seguono:
a) Ignazio, nato il 1737, barone di Pedagaggi, che muore
a Palrmo il 26.3.1794, senza prole, sepolto al monastero dei
Cappuccini a Palermo.
b) Giovanni, che sposa due volte. Ne seguono Antonino
ed Isidora.
2) Fabiano che fu barone di Gulfotta, con mero e misto
imperio, dal 4 giugno 1646. Tale ramo si estingue nel XIX secolo
con Alessandro Gerbino e Carnevale, che investito nell'ottobre
1795, morì in Palermo ad anni 66 (12 novembre 1823) senza
discendenza. |
|
ROSSOTTI
Gaspare Maria Rossotti da Alcamo, con privilegio del 20
settembre 1755, ottenne la concessione del titolo del barone di
Pietralonga; il figlio Matteo sposa Rosalia Velez, da cui
discende un Giuseppa Rossotti, morta il 2 ottobre 1866, che
sposa Stefano Chiarelli, protomedico di Alcamo., da cui discende
Stefano Chiarelli La Lomia, morto il 17.12.1956, figlio unico e
senza successione, con cui si estingue il casato Chiarelli
Rossotti.
Per volontà testamentaria il patrimonio venne suddiviso tra enti
pubblici ed opere religiose.
|
|
BALLAROTO
Famiglia per cui il 20.3.1763 un Benedetto Bellaroto e Marino,
dottore in legge, comprò, presso gli atti del notaio Lomeo e
Salamone di Palermo, dal signore Ignazio Mendoza e Sandoval, il
titolo di marchese di Mendoza, mentre dalla moglie, Caterina
Scamacca, conseguì le baronie di Campoallegro e Castelluzzo,
indi fu padre di Pietro, nato a Palermo il 1753, che si maritò
in Partinico il 21.1.1793 con Isidora Rossotti e Velez di
Alcamo, dalla quale ebbe Benedetto senza prole, e Ferdinando.
Quest'ultimo fu padre di Pietro, riconosciuto nei titolo di
Marchese di Bellaroto e barone di Campoallegro.
|
|
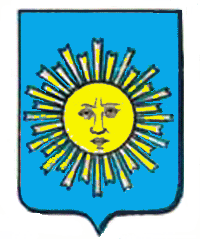
Arma famiglia Ballaroto o
Bellaroto
|
|
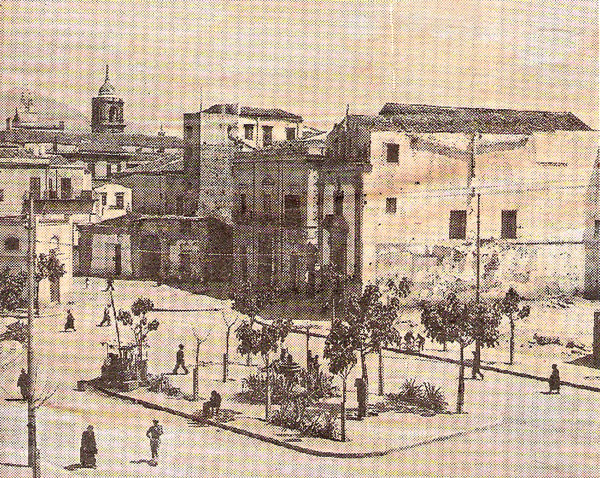
Palermo, Palazzo Miano-Velez -
Anni Trenta |
|
Sullo sfondo
si scorge il Palazzo Miano- Velez con accanto l'oratorio di
Sant'Alberto (1653). Lo spazio vuoto è ciò che risulta dalla
demolizione del contiguo palazzo del principe di Militello. La
foto mostra la piazza integra, chiamata anche Piano del Carmine,
e non ancora invasa dal mercato di Ballarò.
|
|

Barone Alfonso Velez fu Giovanni
(†1871)
|
|

Il Barone Giovanni Battista Velez |

La Baronessa Concetta Velez nata Arone Tagliavia |
|
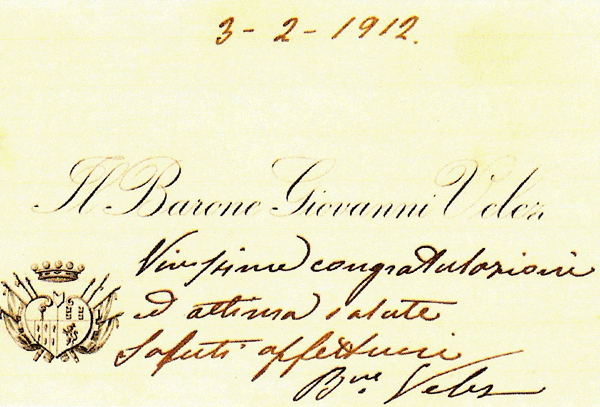
Biglietto da visita del Barone
Giovanni Velez
|
|

Donna Maria Concetta Velez di Pietro |
|
Bibliografia:
Archivio di Satato. Archivio dei visitatori generali della Sicilia.
BURGARELLA P. e G. FALLICO, Roma, 1977.
ABELA F., Descrizione di Malta, 1647.
ALESSI L., Le accademie di Sicilia nel '700, Trovì, Palermo, 1925.
AMMIRATO SCIPIONE, Delle famiglie nobili napoletane, parte II, Firenze,
1661.
ANSELMI A., I ritratti di Inigo Velez di Guevara, VIII conte di Onate,
Università della Calabria, 2002, Cosenza.
Biblioteca Comunale di Palermo, I manoscritti indicati dal canonico
Rossi, 1873.
ALDIMARI B., Memorie storiche di diverse famiglie nobili così napoletane
come forestieri, Napoli, 1691.
CALIA R., I palazzi dell'aristocrazia di Alcamo, edizione Carrubba.
CEDRINI R., TORTORICI G., MONTAPERTO, Repertorio delle dimore nobili e
notabili in Sicilia, Grafil, 2008.
DE BLASI I., Discorso storico della opulenta città di Alcamo, Alcamo,
1989.
DE LELLIS C., Discorso sulle famiglie nobili del Regno di Napoli,
Napoli, 1654-1671.
DELLA MONICA N., Le grandi famiglie di Napoli, Newton Compton, 1998.
DE SPUCCHES F., La storia dei feudi e titoli nobiliari in Sicilia,
Palermo, 1941.
MANGO, Nobiliario di Sicilia, 1912.
MACRI' G., Efficienza amministrativa ed innovazioni contabili.
Ricerche storiche mediterranee, Palermo, 2007.
REGINA V., Alcamo e le sue opere d'arti. La Chiesa Madre di Alcamo.
SCINA' D., Prospetto sulla storia letteraria di Sicilia, edizione
Regione Siciliana.
VILLABIANCA, Opuscoli palermitani e in Sicilia nobile, vol. III e vol.
V.
RICCA E., La nobiltà del Regno delle due Sicilie, Napoli, 1859.
GIANNONE P., Dell'Istoria civile del Regno di Napoli, Tomo III, Napoli,
1723.
IMHOFF J.W., Historie Italie ed Hispanie genealogica. |
|
|