|
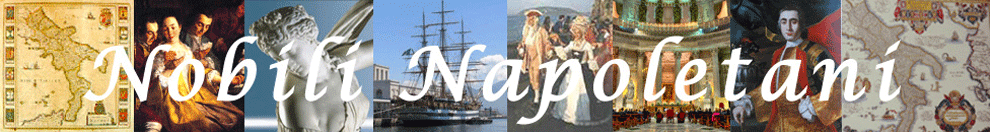
Ovvero delle Famiglie
Nobili e titolate del Napolitano, ascritte ai Sedili
di Napoli, al Libro d'Oro Napolitano, appartenenti
alle Piazze delle città del Napolitano dichiarate
chiuse, all'Elenco Regionale Napolitano o che
abbiano avuto un ruolo nelle vicende del Sud Italia.
|
|
 |
Samo olim SAMA' |
|
A
cura dell'avv. Rosario Migliaccio di Sanfelice |
|
Arma:
di rosso a tre torri d’oro merlate alla guelfa di tre merli
visibili, poste due e una, la prima aperta, la seconda e terza
aperte e finestrate di due.
Motto: Vis in
sanguine
Titolo: Nobile
Dimore: Napoli, San Giovanni a Teduccio, San Giorgio a
Cremano, Santa Caterina dello Jonio, Sant’Andrea dello Jonio,
Badolato, Salerno. |
|
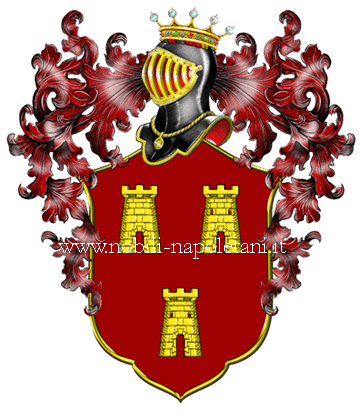
Stemma famiglia Samo |
|
Un’antica stirpe che affonda le proprie radici nella
Magna Grecia, individuando nel proprio nome la sua
radice dal greco samaìos, che significa abitante
dell’isola di Samo,(1)
ubicata nell’egeo orientale, nota nel mondo ellenico per
la produzione ed esportazione di vasellame domestico per
tutto il periodo antico. Il ceppo originario dei Samà è
individuato nelle colonie della locride ionica greca, ed
in particolare in Sant’Andrea Apostolo Jonio dove le
origine del luogo si fanno risalire al III sec. a.C. |
|
Re Samo mostrato
negli affreschi di Santa Caterina rotonda a Znojmo , XII
secolo |
|
La vulgata classica non esita a legare questa famiglia,
con un tocco di leggenda, alle gesta del mercante
franco, poi Re Samo ed il Regno breve che da lui prese
il nome, esistito tra il 631 al 658 d.C.
(2),
che riuscì a liberare con la propria forza bellica gli
slavi dal dominio degli Avari e degli stessi Franchi;
benché dalla fuliggine del tempo in assenza di
documenti nulla potremmo escludere, visti i flussi degli
scambi commerciali dopo la caduta dell’Impero Romano
operata dai Franchi. |
|
A questa breve nota, si premette la difficoltà di dare
una stesura esauriente sugli antichi personaggi di
questa casa e di non voler enfatizzare sulle vicende
poco documentabili, in particolare per il periodo che va
dal periodo angioino a quello vicereale del Regno di
Napoli, non essendo del resto, esplorato tutto il
materiale archivistico monastico basiliano. Così come
lamentò lo stesso Alfredo Badolato nel suo Santa
Caterina Jonio dal ‘600(3),
di cui la sua famiglia ha avuto un ruolo di rilievo
nella storia di Santa Caterina Ionio, così esprimendosi:
“…Ma di tutto questo ne io, ne i miei parenti abbiamo
saputo mai nulla…Non ho gli elementi concreti….per
suffragare quanto fu potente la famiglia Badolato..”.
Lo stesso è per tute le famiglie di quell’area per il
periodo antico, facendo da principali agenti due
fattori: i due catastrofici sismi del 6 novembre 1659(4)
e del febbraio 1783(5),
che rasero al suolo diversi centri abitati, e le
continue incursioni saracene per tutto il sec. XVIII.
Su questi eventi oltre quelli naturali, la realtà del
danno è tradotto sulle popolazioni locali tra
deportazioni, saccheggi e distruttivi assedi che trovano
relativamente pace nel 1050 con l’avvento del periodo
normanno, dando la certezza solo di un territorio, ma
non una stabilità politica atta a frenare
l’espansionismo militare musulmana(6).
|
|
Pertanto il periodo altomedievale calabrese, registra
attraverso cronache, relazioni ad limina ed atti
ufficiali, nomi, fatti avvenimenti e famiglie legate a
vicende di alto spessore politico militare e poco
riscontriamo per penetrare il tessuto sociale ed urbano
in continua mutazione e in lotta o antagonismo tra le
varie realtà religiose che gareggiavano a conservare il
loro predominio sulle anime ed il loro potere
giurisdizionale, tra gli stessi ortodossi, cattolici,
ebrei e musulmani stessi, essendo la parte ionica un
crogiolo di razze miscelate durante il periodo bizantino
non tralasciando arabi ed armeni. Fortunatamente tra
alti e bassi, ripopolamento e spopolamento, inurbazione
e flussi migratori, normanni, angioini ed aragonesi ha
la meglio la Chiesa che con il
Concilio di Trento(7),
al solo fine di preservare e controllare la morale dei
propri fedeli da eretici, conversi, spergiuri, streghe,
bigami, figli illegittimi, figli di prete e matrimoni
clandestini, nonché la elargizione dei sacramenti e la
riscossione delle decime, istituisce la parrocchia e i
libri parrocchiali per annotare i nuovi nati con il
battesimo, i matrimoni e quelli nati al cielo. Da qui,
abbiamo il prezioso tesoro delle genealogie per poter
con certezza ricostruire la presenza dei nostri antichi,
non perché prima non c’erano, ma forse perché non c’era
la necessità per alcuni, di ricorrere al notaio. |
|
Su queste premesse, iniziamo a tracciare un breve
profilo dei Samo, in antico Samà, o meglio la stessa
famiglia e stesso ceppo dei Samà di Santa Caterina
Ionio, translitterato nel napoletano il proprio nome ad
un singolare maschile, trovando questa famiglia in alto
stato, così come gli atti notarili attestano e gli
stessi atti ecclesiastici. Ad univoca testimonianza
evidenziamo Donna Caterina Samà che contrasse
nozze con il Barone Antonio
Badolato,
patrizio di Moneteleone Calabro, atto per notar Paolino
De Marco del 25 febbraio 1704. Donna Caterina e figlia
di Don Jacobo Samà e di Donna Elisabetta Gullà, e
presenti all’atto troviamo lo zio paterno parroco della
Parrocchia di S. Pantaleone Rev. Don Filippo Samà,
nonché il futuro sposo, il patrizio Antonio accompagnato
dal padre, il barone Francesco Badolato. Essendo un
matrimonio piuttosto importante al tempo rileviamo le
firme dei testimoni, tra i magnifici di S. Caterina
Ionio: Dott. Fisico Nicola Scoppa (un secolo dopo questa
famiglia ricchissima sarà insignita del titolo
baronale), Dott. Fisico Giovan Battista Mandarani, Dott.
in Utroque Iure Don Giuseppe Tropiano, Magnifico
Francesco Favilla, Magnifico Antonio Monteleone. E’
lodevole altresì ricordare che da questa unione sono
nati sei figli(8), di cui
Nicola che impalmerà Donna Antonia
Marzano,
figlia del Magnifico Don Federico Marzano, figlio del
Duca
di Ardore e feudatario di Santa Caterina, Don Erasmo
Marzano. Il Cugino di Donna Caterina, Don Stefano
Samà, figlio di Don Francesco e nipote di Don
Pietro, uomo d’armi al servizio
di Don Carlo
Pignatelli
e di altri cavalieri, verrà a Napoli dove contrasse
nozze il 9 agosto 1679 con Donna Candida Buonincontro del casale di San
Giovanni a Teduccio, (regio casale franco di tasse
per i privilegi concessi ai casali del napoletano),
così come testimoniano i verbali del processetto
matrimoniale depositato presso l’Archivio Storico
Diocesano
di Napoli. |
|

...alli
servitiy dell’Illustrissimo Don Carlo
Pignatelli ed altri
Cavalieri miei amici… |
|
E’ chiaro che se non volessimo considerare la famiglia
di un estratto nobile, ma non potrebbe essere visto la
cugina Donna Caterina Samà che sposa il patrizio e
barone Antonio Badolato, ed il di lui figlio Nicola
impalmerà Antonia Marzano, nipote del Duca di Ardore,
uno dei più potenti feudatari del tempo, di certo è di
una condizione more nobilium.
Effettivamente nel tempo, tra beni burgensatici, fondi
enfiteutici e successioni(9),
il reddito era molto alto, tenuto conto che nel
napoletano Don Pascale Samà (n. 16-4-1751
† 21-11-1816),
figlio di Don Nicola, disponeva di quaranta
ducati per pagare il proprio sarto per pregiati e fini
abiti di velluto alla data del 15 aprile 1785, così come
testimoniano le fedi del Banco di Napoli notarizzate per
notar Vincenzo Cipro di Napoli, come si può leggere
dall’estratto sotto riportato.
Ed è da evidenziare che 40 ducati di quel tempo,
erano pari ad una rendita annuale di una piccola feudo.
È sempre attraverso alleanze matrimoniali che si
evidenzia un alto stato dei Samà, ravvivando la
memoria di altra Donna: Caterina Samà, madre
di Don Ivan Cutierrez capitano spagnolo, ricordato
dalla lastra tombale sita nella chiesa del Monte dei
Morti a Salerno eretta nel 1530. È menzionato per
essere stato tra i fondatori del Monte dei morti
dove per una convenzione del 27 febbraio 1617
redatta dal notaio Gio Pandolfo di Salerno, fra il
Monte dei Morti ed il Regio esercito per la
sepoltura di capitani e soldati del
Principato Citra,
le parti furono rappresentate da: «Gennaro
Mauro
canonico e Cardinale della chiesa di S. Matteo di
Salerno e i tenenti della compagnia della Regia
Udienza di Salerno e Principato Citra»(10).
|
 |
|
 |
|
È peculiare per la Calabria, specie tra il ‘500
e il ‘600, in particolare nei piccoli centri
come predominio sociale in mancanza di altre
carriere, l’avere dei sacerdoti e delle suore in
famiglia garantendo ampi benefici spirituali.
Così per la famiglia Samà troviamo una schiera
di sacerdoti e suore, come ci viene elencato da
S. Tropiano nel suo “patrimonio ecclesiastico”(11),
da cui: nel 1770 Rev. Don Nicola Samà;
nel 1739 Rev. Don Filippo Samà Parroco di
San Michele Arcangelo; nel 1794 Rev. Don Giuseppe Samà,
Arciprete di Striniano e sempre nel medesimo
anno altro Rev. Don Stefano Samà; Don Francesco Samà
“chierico coniugato” (diacono). Nonché
nel 1714 Suor Antonia Samà, nel 1765
Suor Maria Samà, nel 1794 Suor Maria
Benedetta Samà, nel 1805 Suor Maria Samà,
nel 1825 Suor Lucia Samà. Tutti dello
stesso ceppo.
Ed infine al nostro tempo, una Serva di dio
Beata Mariantonia Samà
(Sant’Andrea
Jonio, 2 marzo 1875
†
27 maggio 1953).
|
 |
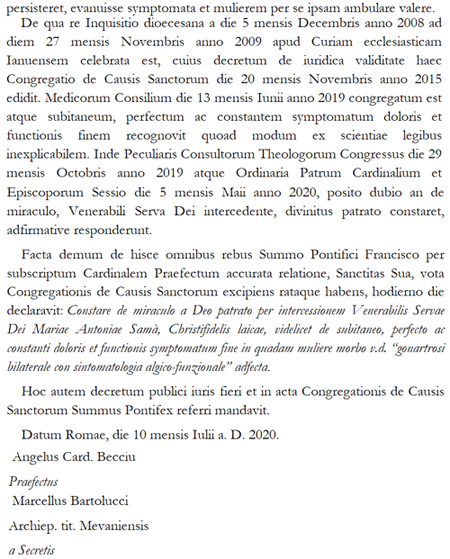
|
Così come anche nel territorio salernitano
ritroviamo Don Graziano Samo
(11 bis)
e il Rev. Don Andrea Samo
(11 ter).
Da Don Stefano Samà sopra citato, che si
stabilì nel napoletano in San Giovanni a
Teduccio e precisamente a palazzo Samo, questi
illustrato nella parte dell’arma di questa casa,
troviamo per questa linea una notevole quantità
di atti di acquisti, vendite, permute agrarie,
tant’è degno di nota, così come possiamo
rilevare dall’ampia bibliografia sulla
costruzione della prima ferrovia al mondo, la Napoli - Portici,
dove Don Giuseppe Samo, figlio di Don
Pascale e nipote di Don Nicola, elargì alcuni
appezzi di terra per facilitare la realizzazione
della novella strada ferrata.
|

Inaugurazione della linea ferroviaria
Napoli-Portici |
A seguire come
dalle memorie storiche di Casa Samo, da Don
Giuseppe
(n. 10 aprile 1793
†
29 dicembre 1870) e Donna Raffaella Buccino si avrà Don
Pasquale
(n. 23 giugno1825
†
28 settembre 1909) che
il 2 luglio 1853
rimpinguò di molto le
sostanze di famiglia, impalmando Donna Rosa
Gallo, di distintissima famiglia di Teano. Non
possiamo tacere che questi prese parte come
volontario all’assedio di
Gaeta, rimanendo ferito gravemente ad un
braccio.
|

Assedio
di Gaeta |
Da questi si avrà Don Salvatore
Samo
(n. 18 ottobre 1865
†
17 luglio 1943), funzionario dell’Arsenale Marittimo e
Presidente, nello stile liberale
dell’epoca del locale “Circolo San Luigi”.
|
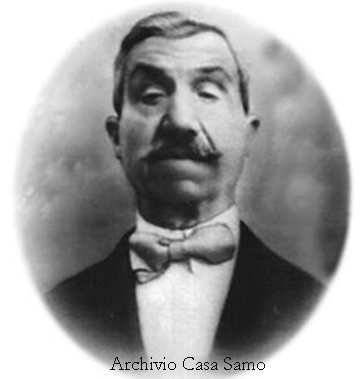
Don
Salvatore Samo - Foto 1930 circa |
Questi impalò
il 16 giugno 1892
Donna Gelsomina Russo, dello borghesia locale,
sorella del medico Matteo Russo
e dell’Arciprete della Chiesa Madre di San
Giovanni a Teduccio, Rev. Don Giovanni Russo,
non mancando di citare il fratello
di Don Salvatore, don Giuseppe, decorato al valore, immolatosi per la
Patria nel I Conflitto Mondiale. Don Salvatore
Perì nel proprio palazzo raso al suolo, durante
il violento bombardamento che colpì Napoli dagli
“alleati” il 17 luglio 1943. Dalla coppia Samo
Russo, si ebbe Don Giovanni Samo
(n. 30 marzo1902
†
23 agosto 1959),
che
impalmò Donna Rosa Testa
nel luglio del 1926, che nel suo parentado
annoverava diversi togati ed è ricordata quale
fervente operatrice di opere pie.
|
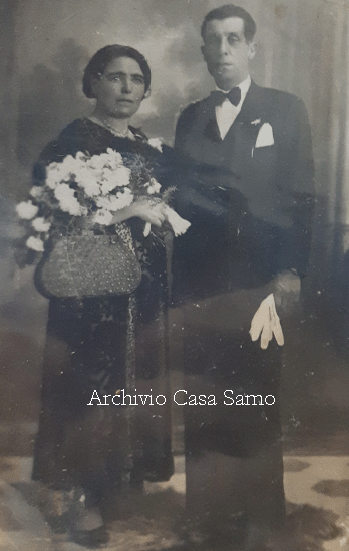
Giovanni
Samo e la moglie Rosa Testa |
|

Don Giovanni Samo, foto
1920 circa |
Don Giovanni
fu imprenditore e fondò la Società SAMO-ALTOMISI,
che ebbe un importante e florido ruolo nel dopo
guerra, sia per la ricostruzione e sia perché
inserito nell’indotto delle acciaierie della Italsider di Bagoli
e la Società Siderurgica italiana.
Il figlio di Don Giovanni, Don Salvatore
Samo (n. 1928
†
1993)
impalmò
il 24 aprile 1958 la Nobildonna Laura Sorrentino, il cui
casato vantava l’ammissione alla “Compagnia
delle Regie Guardie del Corpo” nel 1835;
fu
funzionario presso la Società Sidercomit sede di
Napoli. Cavaliere del Comitato Diocesano San
Gennaro nominato con decreto Arcivescovile dal
Venerato Cardinale Corrado Ursi. Presidente
dell’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani
Sidercomit fino al decesso, avvenuto nel 1993.
|

Don
Salvatore Samo, foto 1960 circa |
Da cui
Don Giovanni Samo, Commendatore nel
Sacro
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio,
funzionario presso la Provincia di Napoli,
nonché Cavaliere del Comitato Diocesano San
Gennaro, Guardia d’onore alla tomba del martire
e Patrono San Gennaro nella Cappella
Carafa
del Duomo di Napoli; Cavaliere
co-fondatore della Guardia d’Onore alle Reali
Tombe dei Sovrani Borbone in Santa Chiara di
Napoli.
|
Don Giovanni Samo con
S.A.R. Carlo di Borbone - Anno 2016. A
destra: le
Reali Tombe dei Sovrani
Borbone |
Sposa
Donna Patrizia Giannetti, da cui Don Salvatore,
dottore in Giurisprudenza presso l’università
degli studi di Napoli Federico II, nonché
iscritto al foro di Napoli come praticante
avvocato,
già decorato della croce costantiniana per
volere delle LL. AA. RR. i Principi Don Carlo e
Donna Beatrice di
Borbone De
Sicilie, Don Antonio e Donna Laura,
laureando il primo in Giurisprudenza e la
seconda diplomanda.
Entrambi questi ultimi sono Volontari della
Guardia d’Onore alle Reali Tombe dei sovrani
Borbone in Santa Chiara in Napoli.
|
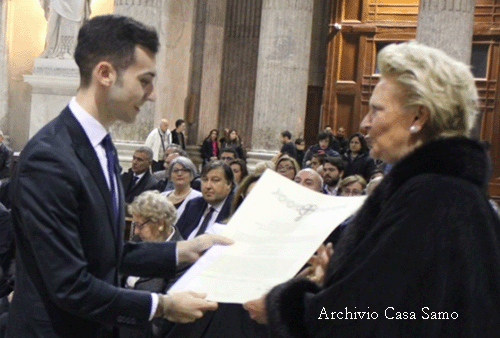
Salvatore Samo con S.A:R. Beatrice di
Borbone |
Fa corona nel tempo odierno, S. E. Rev.ma
Amando Samo, Vescovo di Caroline Islands,
dimessosi di recente per motivi di salute, il 2
febbraio 2020
e morto il 7 agosto 2021. |
|

S. E. Rev.ma
Amando Samo |
|
Portici (Napoli),
targhe in ricordo dei caduti della Seconda
Guerra Mondiale |
|
L’Arma della famiglia Samo olim Samà |
|
Un riscontro di carattere pubblico, è offerto
dallo stemmario settecentesco del Gaetano
Montefuscoli(12),
una raccolta araldica custodita presso la
Biblioteca Universitaria di Napoli del 1780,
collocata precisamente al MSS121, dal titolo: “Imprese
ovvero stemma delle Famiglie italiane raccolte
da Gaetano Montefuscoli”, in sei volumi.
L’arma Samà è vergata al tomo III a tergo della
pagine 33. Da riscontri e memorie di famiglia,
l’uso dell’arma è da rilevarsi già a Don
Stefano Samà e visibile all’interno del
portico di accesso del Palazzo Samo in Via Regia
San Giovanni a Teduccio, dove ad oggi dopo i
bombardamenti del 1943 che lo rasero al suolo, è
ricordato dalla toponomastica locale: vicoletto
Samo.
|
 |
Tale toponimo è annotato nella stesura della
toponomastica storica napoletana da accreditato
e pregevole saggista storico, quale Gianni
Infusino(13)
che “annota” e scrive: “Nome rimasto ad
una piccola stradina di San Giovanni a Teduccio,
nonostante i Samo non vi abbiano più interessi
dalla seconda guerra mondiale che distrusse le
loro residue proprietà”. Effettivamente gli
interessi dei Sama’, translitterato al singolare
maschile Samo, sono presenti in San Giovanni a
Teduccio con Don Stefano Samà di Santa Caterina
Ionio per il matrimonio che avvenne nel 1626 con
la gentildonna Candida Buonincontro.
È interessante descrivere anche l’origine ed il
significato dell’arma dei Samo che tecnicamente
è così blasonata: di rosso a tre torri d’oro
merlate alla guelfa di tre merli visibili, poste
due e una, la prima aperta, la seconda e terza
aperte e finestrate di due.
Le torri, sono il richiamo alla propria terra
d’origine in riferimento al sistema difensivo di
torri costiere della Locride ionica(14),
dove nella prima torre in alto a destra, quella
non finestrata è ricordata proprio l’Universitas
di Badolato, e non a caso è da menzionare la
“somiglianza” con l’odierna arma civica del
Comune di Badolato: d’azzurro a tre torri non
finestrate merlate alla guelfa, di oro, poste in
fascia. Le altre due torri finestrate dello
scudo, indicano per la seconda a sinistra, l’Universitas
di Santa Andrea Apostolo, nucleo primordiale da
dove si diramarono tutti gli altri ceppi dei
Samà o Samo, compreso Samo Calabro posteriore al
precedente, dove i Samoiti li stabiliti non
producevano stoviglie di vasellame, ma erano
dediti alla produzione metallurgica di preziosi.
Infine, alla punta dello scudo, vi è la torre S.
Antonio simbolo ab immemorabili dell’Universitas
di Santa Caterina Ionico, oggi come da circa due
secoli, è di proprietà della famiglia baronale
Badolato(15)
da cui il primo capostipite di questa, il
patrizio di Monteleone Calabro, barone Don
Antonio Badolato impalmò nel 1706 in Santa
Caterina Ionico, Donna Caterina Samà. |
|
La costa ionica fu scenario di devastanti
incursioni saracene, e sottoposta ad incendi e
saccheggi ripetutamente fino sul finire del
‘700, lamentando una cospicua distruzione del
patrimonio storico monumentale e documentale con
pochi precedenti, dovendo di fatto rinnovare nel
tempo l’intero tessuto urbano. È noto alle
cronache le realtà civiche di Cariati,
Pietrapaola e Trebisacce ricordando che per
quest’ultimo il più efferato attacco, fu quello
del 1544, deportando ad Algeri oltre la
popolazione civile, anche il vescovo Giovanni
Carnuti(16). |
|
Tralasciando le antiche gesta, l’arma dei Samo
scolpita in pietra, così come da testimonianze
ancora oggi in loco e memorie, poteva osservarsi
insieme a materiali archeologici provenienti
dalla Locride, sotto l’androne d’ingresso del
Palazzo Samo ubicato a destra della così detta
“Strada Regia delle Calabrie” andando verso la
Reggia di Portici, molto più avanti del “Ponte
dei Francesi”. Uno stabile di origine
cinquecentesca che si ingrandì notevolmente sul
finire dell’800, così come viene indicato nelle
stesure delle varie successioni ereditarie della
famiglia Samo, ricordando che la strada andando
verso portici era sede di sontuose ville
dell’aristocrazia napoletana, tratto di strada
meglio conosciuto come il miglio d’oro. |
|
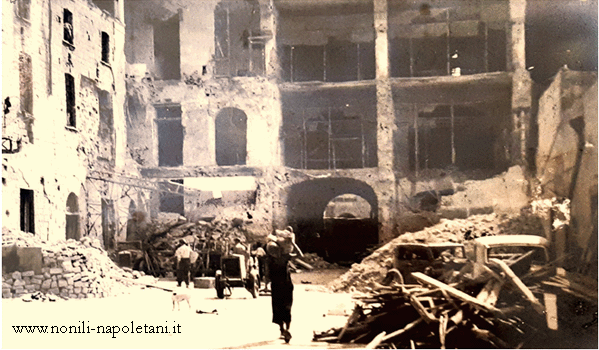 |
|
Archivio famiglia Samo, fot.
delle macerie dell’interno di palazzo Samo. Sul
fondo è visibile quello che resta dell’androne
dell’ingresso principale dopo il bombardamento
del 17 luglio 1943.
Le fotografie furono scattate dai
fotografi de “IL MATTINO”, per documentare
la violenza del bombardamento in tutto il
napoletano. |
|
|
_________________
Note:
(1) -
P. Kosmàs, docente di filologia, monaco
del Monte Athos, cfr. G. Rohlfs, Scavi linguistici
nella Magna Grecia, Nuova edizione interamente
rielaborata ed aggiornata, Congedo Editore, Galatina,
1974, pp. 235-241 e G. Roholfs, Dizionario dei
cognomi e dei soprannomi in Calabria, Ravenna
1979M. Tasso, Tracce culturali bizantine nelle
distribuzioni dei cognomi di etimologia greca in
Calabria, Lucania e Puglia-Terra d’Otranto, tesi di
laurea Università Cà Foscari di Venezia, anno accademico
2017-2018, p. 105.
(2) - L. Leciejewicz, Gli
slavi occidentali: origini delle società e delle culture
feudali. Spoleto:
Centro italiano di studi sull'alto
medioevo,
1991.
(3) -
A. Badolato, S. Caterina Jonio dal
‘600, ovvero dal 1632 al 1855 sulla scorta soprattutto
di quanto tramandato dai Notai, (nda) il pdf manca
della data, v. parte III pp da 12 a 25.
(4) -
Archivo General de Simancas, Secretarías
Provinciales, Nápoles, legajo 30 (1659-60), Consultas
originales, Lettera del viceré di Napoli conte di
Peñaranda al Re di Spagna relativa ai danni causati
nella provincia di Calabria Ultra dal terremoto del 5
novembre 1659, Napoli 29 novembre 1659; Tra le fonti
inedite va infine ricordata una lettera scritta da un
anonimo ecclesiastico di Terranova pochi giorni dopo il
terremoto, conservata in un codice miscellaneo della
Biblioteca Apostolica Vaticana (Vaticani Latini, 10444)
(13). La principale fonte edita, a cui fa riferimento
direttamente o indirettamente tutta la tradizione della
sismologia storica, è la relazione ufficiale di De
Marinis (1660) (14). Questo documento, presentato al
viceré al ritorno di De Marinis dalla Calabria nel marzo
1660 e pubblicato nell’aprile successivo, fornisce
informazioni dettagliate sulle vittime e sui danni alle
costruzioni: non solo case ed edifici di rilievo
(chiese, monasteri, conventi, castelli, palazzi
baronali), ma anche strutture produttive come mulini, "trappeti"
(frantoi), "battendieri" (gualchiere). Il testo è
inoltre corredato dai dati precisi sulla numerazione dei
fuochi di tutte le località visitate e sulla situazione
fiscale di ogni università, sia nei confronti
dell’erario statale, sia nei confronti degli
assegnatari; D. A. De Marinis, Relatione fatta a S.E.
sopra li danni che hanno patito molte Città, Terre, &
Casali nella Provincia di Calabria ultra, per cagion del
terremoto, che seguì la notte delli 5 di Novembre 1659,
Napoli 1660; cfr. Archivio Segreto Vaticano, Segreteria
di Stato, Napoli, vol.61 D, "Relatione delle notizie che
sin’hora si hanno de’ danni del terremoto succeduto
nella Calabria a dì 5 novembre 1659" allegata al
dispaccio del nunzio apostolico Giulio Spinola
arcivescovo di Laodicea al segretario di Stato cardinale
Giulio Rospigliosi del 13 dicembre 1659.
(5) -
G. Mercalli, I Terremoti della
Calabria Meridionale e del Messinese. Accademia dei
Lincei, Roma, 1897.
(6) -
A. ACCONCIA LONGO, San Giovanni
Terista nell’agiografia e nell’innografia, in Calabria
bizantina. Civiltà bizantina nei territori di Gerace e
Stilo, Soveria Mannelli, 1998.
(7) - XIX Concilio Ecumenico
della Chiesa Cattolica, per rispondere alle dottrine del
Calvinismo e Luteranesimo, celebrato in più sessioni in
Bologna e Trento dal 1545 al 1563.
(8) - Archivio di Stato di
Napoli – Riveli del Catasto Onciario di S. Caterina del
1741.
(9) - Archivio di
Stato di Napoli – Real Camera della Sommaria, Segreteria
Partium, inventario, 1468-1688, f. 221.
(10) - G.
BERGAMO, Ricostruzione delle chiese della città di
Salerno e del suo comune, Battipaglia, 1971; Alfonso
Gambardella, ììUn inedito episodio tardo-rinascimentale
a Salerno: la chiesa del Monte dei Morti, in
«Rassegna Storica Salernitana», XXIX-XLIII (1968-1983),
pp. 163 ss.
(11) -
S.
Tropiano, Santa Caterina dello Ionio: patrimonio
ecclesiastico ed archivistico, ed. dell’Autore.
Catanzaro 1997.
(11 bis) -
Nel caso di specie Rev. Don Graziano Samo,
produce un parere in diritto ecclesiastico, prevalendo
sul parere precedentemente reso dal defunto Vescovo di
Capaccio. Archivio di Stato di Napoli, in Registro dei
dispacci n. 526, febbraio 04. 1796, reg. 526, carta. 34.
(11 ter) -
Nel caso di specie Rev. Don Andrea Samo,
parroco della Chiesa di San Giuseppe di Polla, presenta richiesta
al Vescovo RE per fondare una Congregazione a Galdo.
Archivio di Stato di Napoli, in Registro dei dispacci,
n. 206, 25 nov. 1756, reg. 206, carta 33v.
(12) - Gaetano di
Montefuscoli nacque a Napoli nel 1748, cartografo,
calligrafo e disegnatore prima nel laboratorio
Zannoniano e poi nel Burò tipografico del Re. Morì nel
1815 e dedicò gran parte della sua vita alla
compilazione di un manuale di araldica che oggi,
rappresenta per gli specialisti, una fonte di
eccezionale interesse: “Imprese ovvero Stemmi delle
Famiglie italiane”, un blasonario manoscritto in sei
tomi (di cui uno contenente solo disegni acquerellati)
contando ben circa 22.000 stemmi, prevalentemente
meridionali. L’opera fu completata nel 1780.
(13) - G. Infusino, Le
nuove strade di Napoli, Adriano Gallina Editore,
1987; Cfr. Stradario della Città di Napoli, nuova
edizione aggiornata, allegato a “La Voce di Napoli”,
diretto da Marino Turchi, 1940.
(14) - Il Troyli, nel solo
‘500, conta circa 366 torri di guardia di cui 36 nella
Calabria Citra e 60 nella Calabria Ultra, v. P. Troyli,
Istoria generale del Regno di Napoli, 1747.
(15) - Cfr. Genealogia
famiglia Badolato per la linea di Santa Caterina Ionio,
fonte pubblica da famiglie nobili del Mediterraneo:
http://www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/letterab/badolato.htm;
M. Pellicano Castagna, La Storia del Feudi e dei
Titoli Nobiliari della Calabria, Editrice C.B.C.,
1996, Vol. II, pp 191 a 192, ed. 1999, Vol. III pp 22 a
23; L. Palmieri, Cosenza e le sue famiglie attraverso
testi, atti e manoscritti, ed. Pellegrini, 1999, pp.
273 a 274; L. Galasso, Economia e Società della
Calabria del 500, ed. L’Arte Tipografica, 1967, p.
57; G. B. di Crollalanza, Dizionario Storico
Blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane,
1886, p. 78; A. Piromalli, La letteratura calabrese, ed.
Pellegrini, 1996, p. 228 e sg.
(16) - Per tutti, L.
Renzo, Spazzi di Calabria: società storia e cultura, ed.
Pellegrini, 1994, p. 57; v. anche:
O. Pasanisi, La costruzione generale
delle torri marittime ordinata dalla R. Corte di Napoli
nel XVI secolo, in Studi di storia napoletana in
onore di Michelangelo Schipa, I.T.E.A, Napoli 1926,
pp. 423 a 442; V. Faglia, La difesa anticorsara in
Italia dal XVI secolo: le torri costiere, gli edifici
rurali fortificati, Istituto Italiano dei Castelli,
Roma 1974; V. Stefano, Calabria. Torri e castelli tra
mare e cielo. Conquiste saracene e difesa dell'identità,
Regione Calabria, Camigliatello Silano 2004.
|
|