|
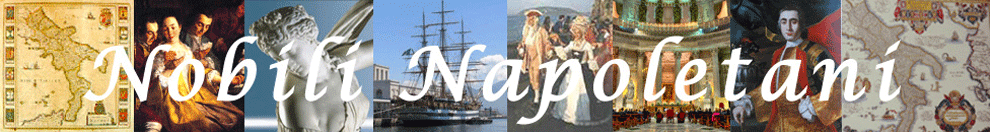
Ovvero delle Famiglie
Nobili e titolate del Napolitano, ascritte ai Sedili
di Napoli, al Libro d'Oro Napolitano, appartenenti
alle Piazze delle città del Napolitano dichiarate
chiuse, all'Elenco Regionale Napolitano o che
abbiano avuto un ruolo nelle vicende del Sud Italia.
|
|

 |
Spadafora o Spatafora |
|
Arma: di rosso al braccio destro armato, movente dal fianco
sinistro dello scudo, tenente una spada d’argento posta in
sbarra.
Altra: di rosso al braccio destro armato, movente dal
fianco sinistro dello scudo, tenente con la
mano di carnagione una spada d'argento posta in palo.
Motto: PRODES IN BELLO |
|

© Messina, stemma famiglia Spadafora con
le insegne melitense. |
|
Capostipite della famiglia Spadafora o Spatafora fu
Basilio Spataforius, di origine greca,
capitano delle guardie dell'Imperatore Isacco Commeno;
fu inviato, nel 1058, in Sicilia con l'incarico di
esarca.
Notizie certe si hanno di
Giovanni
Spadafora, il quale, nel 1230 fu segretario
dell'Imperatore
Federico II di Svevia.
Inizialmente si diramarono in Sicilia, radicati
principalmente a Palermo e Messina; successivamente
fiorirono anche a Lucera, Benevento e Venezia; in
Calabria si radicarono nelle province Citra ed Ultra.
Nel corso dei secoli il casato ebbe numerosi feudi tra i
quali: Acquaviva, Albona, Buonalbergo, Castellamare del
Golfo, Cutò, Magnavacca; e fu investito di vari titoli,
tra i quali: conti di Andria e Sclafani, marchesi di
Carletto, Policastrello, Roccella di Randazzo e
Sanmartino, duchi di Sanpietro e Spadafora, principi di
Miletto (1602), Mazzara (1653) e Spadafora (1723).
Colella,
feudatario di Albona o Alvona e Drama e Mulino Feudale
di Feroleto, in territorio di Feroleto (oggi comune
omonimo in provincia di Catanzaro), per essersi
ribellato fu privato del feudo che tornò alla Regia
Corte, con privilegio della
regina Giovanna II
del 7 maggio 1423 venne assegnato a Tarantino
de Ponte
da Sorrento, milite, Castellano di Feroleto.
Gli Spatafora di Messima vestirono l’abito del
S.M.O. di Malta
più volte: nel 1485 con
Corrado,
nel 1586 con
Antonio,
nel 1589 con
Orazio
(o Ottavio), nel 1599 con
Scipione,
nel 1650 con
Francesco
Damiano, nel 1658 con
Tommaso.
Federico Spadafora di Messina, barone
della Gabella del Biscotto, Canape e Sale, avendo reso
molti favori a re
Alfonso I d’Aragona,
fu creato Maestro Razionale e
Gran Camerlengo
del Regno.
Nel 1522
Sebastiano
Spadafora accolse in Messina, insieme a Ettore
Pignatelli,
duca di Monteleone e vicerè di Sicilia, la flotta dei
cavalieri gerosolimitani guidata dal Gran Maestro Fra
Filippo Villiers, fuggita dall’isola di Rodi conquistata
dai Maomettani.
Eleonora Spadafora nobile messinese
acquistò da Alfonso
d'Aragona de Ayerbe conti di Simeri
(Catanzaro) la terra di Brancaleone e il casale di
Staiti (oggi comuni ricadenti nella provincia di Reggio
Calabria) con Regio Assenso del 7 giugno 1572; sposò
Federico Stayti nobile di Messina con il quale ebbero
Andrea, quest'ultimo sposò Ippolita, figlia del citato
conte di Simeri Alfonso d'Aragona de Ayerbe; Adrea
premorì alla madre di conseguenza Eleonora refutò
Brancaleone al figlio di Andrea e suo nipote Federico
juniore con atto del 1590; quest'ultimo fu il 1°
marchese di Brancaleone, privilegio concessogli da re
Filippo III nel 1607.
I rami degli Spadafora di Benevento, di Lucera e dei
principi di Maletto e di Venetico, e marchesi di
Sanmatino sono estinti; quest’ultimo ramo in casa
Ascenso.
La famiglia Spadafora ha goduto di nobiltà in Cosenza
dalla seconda metà del Cinquecento; sono stati
possessori di feudo e vassalli.
Approdarono nella città di Cosenza con
Antonio
di Guglielmo (in quanto originariamente erano detti
anche “di Guglielmo”), proveniente da Rose (oggi comune
poco distante da Cosenza) perchè possedevano quelle
terre, lo si evince da un documento: il citato Antonio
intervenne come testimonio all'atto di fondazione dei
PP. Minori Osservanti di San Francesco d'Assisi di
Cosenza “Ego Antonius de Guglielmo de Rosis civitatis
Consentiae testor anno 1449”.
|
|

© Rose (CS), in alto il palazzo
baronale |
|
Bernardino di Guglielmo, di Rose e cittadino di Cosenza è citato in un atto
di notaio nel 1476.
Martino Guglielmo per
la prima volta appare col cognome Spadafora, come
risulta da una procura del 1555 redatta da Marco Antonio
Piscitello.
Giovan
Battista Spadafora o de Guglielmo
Spadafora, sposato a Bernardina de
Gaeta, hanno avuto per figlia Dianora che
sposò Cesare Cavalcanti,
patrizio di Cosenza, il loro figlio, Coriolano
Cavalcanti, fu ammesso nell'Ordine
di Malta nel 1591. In un atto del 2 dicembre
1598, stipulato a Cropani, notaio Pietro
Giovine di Cropani, si
rilasciava garanzia da parte della citata Dianora sui
suoi beni dotali, vedova di Cesare Cavalcanti, e dal
figlio Fabrizio a favore di Antonino e Diana
Firrao, per la dote di
detta Diana, andata sposa a Carlo Cavalcanti, fratello
di detto Fabrizio.
Marcello Spadafora, dottore in legge, fu
aggregato al
sedile dei nobili di Cosenza nel 1558, come attestato
dal notaio Sergio nei libri parlamentari di quell'anno.
Marcello juniore,
nel 1594 comprò per 21.500 ducati col patto di
retrovendita, la terra di Rose e di Luzzi
da Lelio Orsini,
curatore del patrimonio del principe di Bisignano,
Nicolò Bernardino Sanseverino, per ripianare i suoi debiti, seguì il Regio Assenso il 14
settembre dello stesso anno, la vendita non ebbe seguito
per l'esercizio, da parte del venditore, del patto di
ricompra, il quale procedette ad una nuova vendita in
favore di Giovanbernardino
Bernaudo
di Acri per 38.000 ducati; dagli atti a partire dal 1605, risultava
un processo di espropriazione dei beni di Marcello,
Claudio e Fulvio Spadafora, acquistati da
Cesare Firrao principe di Sant'Agata (1610); un
privilegio, dato a Napoli il 3 aprile 1614, dal
vicerè conte di
Lemos, di assenso alla vendita della terra di Luzzi e del feudo di Noci,
nonchè di altri beni particolarmente elencati, eseguita
ad istanza dei creditori di Marcello Spadafora, a favore
di Marcello Firrao, con gli stessi diritti che aveva
goduto il principe di Bisignano, dal quale il detto
Marcello li aveva comprati. Marcello Spadafora aveva
sposato Lavinia Pescara dei baroni di Saracena.
Sveva,
figlia di Marcello e Lavinia, sposò Bartolo Sambiase,
fratello di Scipione, Pompeo e Paolo.
Ministero dell'Interno, pubblicazione degli Archivi di
Stato XI, Archivio di Stato di Napoli, Archivi Privati,
Vol. I seconda edizione, Roma 1967, Archivio Sanseverino
di Bisignano: 187-228-266.
|
|

© Cosenza, Palazzo Spadafora |

© Cosenza, Palazzo Spadafora,
portale |
|
La famiglia ha posseduto vasti territori anche nella
Presila cosentina; è tuttora visibile il palazzo ubicato
a Flavetto, frazione ricadente nel comune di Rovito. |
|

© Flavetto, Palazzo Spadafora,
portale |

© Flavetto, Palazzo Spadafora |
|

© Flavetto, Palazzo Spadafora,
retro |

© Flavetto, Palazzo Spadafora,
stemma |
|
Adriano Guglielmo Spadafora (morto a Napoli nel 1589),
archeologo, lavorò negli scavi di Cuma e Pozzuoli,
catalogò i reperti rinvenuti; fu nominato giovanissimo
Prefetto del Regio Archivio di Napoli. Fu raffinato
antiquario, la sua casa, nella vicinanze della chiesa
San Giovanni Maggiore, dove la famiglia possedeva una
cappella dedicata al Santo martire Adriano
(1), era
meta di molti stranieri. |
|
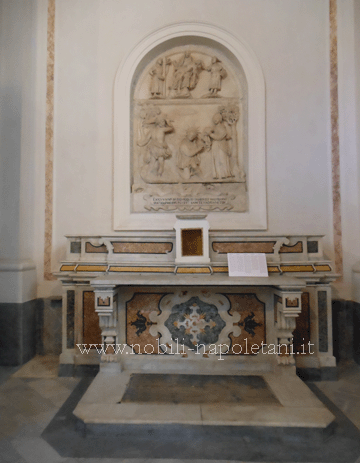
© Napoli, Cappella Spadafora
dedicata a Sant'Adriano, poi passata ai
Folliero. |
|
Una
Spadafora fu la madre di Giovanni Battista
della Porta.
Giovanni-Jacopo, fu elevato alla cattedra “del Supremo
Dottorato” da papa Clemente VIII con bolla del 17 marzo
1632; morì giovane.
Mario Spadafora fu medico; pubblicò, a Napoli nel
1654, un “Trattato” di medicina in latino sulla
patologia e la terapeutica.
Nei primi anni del XVIII secolo il feudo di Acquaformosa fu dato in dote a Flaminia
Mollo in occasione del matrimonio con
Muzio Spadafora.
Gaetano (morto a 56 anni nel 1848) del Flavetto fu
parroco zelante.
Francesco Maria, nella seconda metà dell'Ottocento, fu
uno dei migliori parroci dell'Arcidiocesi di Cosenza.
Nel 1907, fu richiesta una perizia giudiziaria per la
stima e quotizzazione dell'eredità Spadafora: casa nel
Comune di Rovito rione Flavetto, fondo Orto sopra
le case e fondo Andreaggi. Causa tra Spadafora
Carlo contro Carmela Rosina, Saveria,
e Francesco Saverio Spadafora.
Archivio di Stato di Cosenza, anno 1907, B. 76, perizia
32.
Carlo
Marigliano (Napoli, 1867
† ivi,
1934), figlio del duca Francesco Saverio (1831 † 1883), sposò a
Napoli nel 1905 Evelina Spadafora, figlia del principe Pietro. |
|
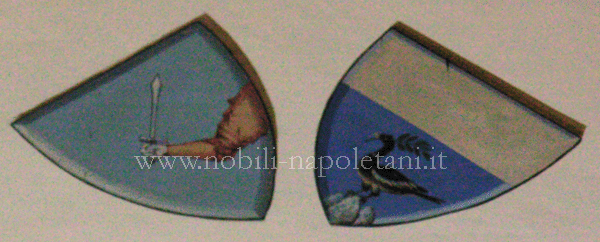
© Napoli - Palazzo Marigliano, Stemmi delle famiglie Spadafora e Marigliano, imparentate |
|
Napoli, Altare Spafadora
e stemma |
|
_____________
Note:
(1) - Eugenio Arnone riporta la data
della morte nel 1586; nel libro “Memorie della Regale
Accademia Ercolanense di Archeologia” vol. V, 1846; a
pag. 99 è scritto “dal registro dei feudi risulta morto
nel 1589, pare che sia sepolto nella chiesa di San Gio.
Maggiore, ove tuttavia si vede la sua cappella
gentilizia dedicata al santo martire Adriano. Sotto la
tavola di marmo dell'altare, che rappresenta la
decollazione del santo, leggesi ancora il distico
seguente: Exguum munus quioquid tames est Hadrianus
Spathaforus posuit, sancte Hadriane, tibi.”.
_____________
Fonti bibliografiche:
- Luigi Palmieri “Cosenza e le sue famiglie attraverso
testi atti e manoscritti”, Tomo II. Pellegrini Editore,
1999.
- Eugenio Arnoni “La Calabria Illustrata, vol. IV, Il
Circondario di Cosenza”. Edizioni Orizzonti -
--Meridionali, ristampa del 1995.
- Bernardo Candida Gonzaga “Memorie delle famiglie
nobili delle province meridionali d’Italia”, Napoli
1875.
- Ivan Pucci "Gli stemmi araldici nel contesto urbano di
Cosenza e dei suoi casali", pag.81. Edizioni Orizzonti
meridionali 2011.
- Mario Pellicano Castagna “La Storia dei Feudi e dei
Titoli Nobiliari della Calabria” Vol.I pag.287; Frama
Sud 1984. |
|