|
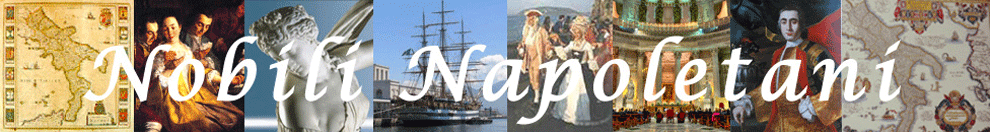
Ovvero delle Famiglie
Nobili e titolate del Napolitano, ascritte ai Sedili
di Napoli, al Libro d'Oro Napolitano, appartenenti
alle Piazze delle città del Napolitano dichiarate
chiuse, all'Elenco Regionale Napolitano o che
abbiano avuto un ruolo nelle vicende del Sud Italia.
|
|
 |
Famiglia
Cavalcanti |
|
Arma: d'argento disseminato di crocette rosse(1).
Cimiero: una zampa di cavallo di nero e ferrata di oro
con sette chiodi di nero. |
|
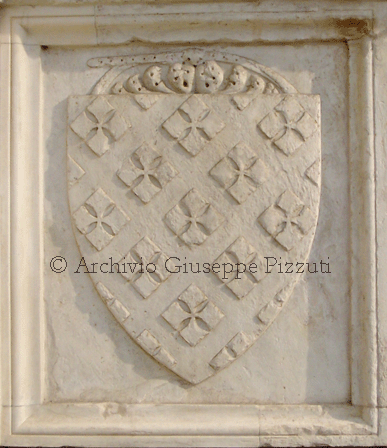
Firenze, Chiesa di Santa Maria
Novella, Sagrato, stemma Cavalcanti |
|

Santa Croce, stemma Cavalcanti |
|

Cosenza, Stemma Famiglia
Cavalcanti |
|
I cavalcanti
hanno goduto di nobiltà in Firenze dove parteggiavano per la
fazione Guelfa; nel 1309 Tommaso, Teghiajo e
Donato furono decapitati. Nel 1311 le loro case furono
incendiate dal popolo, sollevato da messer Pazzino dei Pazzi, e
furono costretti a fuggire in Calabria, si stabilirono in
Cosenza e poi si diramarono in Sicilia, Udine Gaeta e Napoli
dove furono ascritti al Patriziato napoletano del
Seggio di Portanova
e, dopo l'abolizione dei Sedili, nel Libro d'Oro Napoletano. |
|
Cosenza, Palazzo Cavalcanti. A destra il portale |
|
I CAVALCANTI A COSENZA E PROVINCIA |
|
Luigi Cavalcanti (detto Loysio), sindaco dei nobili di
Cosenza, nel 1481 venne inviato dall'Università di Cosenza
presso la corte napoletana di
Ferrante d'Aragona, per chiedere che i privilegi concessi
dalla corona alla città siano rispettati e che le cariche
pubbliche statali siano assegnate a persone non della stessa
provincia.
Bernardino Cavalcanti nel 1511 e vicario generale
dell'arcivescovo Ruffo-Teodoli in missione permanente presso al
corte spagnola.
Il 10 febbraio pone la prima pietra della chiesa (di San
Francesco di Paola) del convento dei Minimi di Cosenza; nel
1512, è nominato da papa Giulio II, con breve del 13 maggio,
Delegato Apostolico del processo di canonizzazione di Francesco
di Paola.
Vincenzo, nel 1540 prende in fitto il feudo di Santa
Maria della Rota e di Mangalavita (oggi Rota Greca) dalla
comunità monastica di San Benedetto della SS. Trinità di Cava
de' Tirreni e abitato da molti
profughi albanesi; nel 1542 lo
acquista per 3.300 ducati. Successivamente acquista un fondo di
castagni a Lattarico, confinante con Rota Greca. Nel 1550 inizia
la costruzione del palazzo di Santa Maria della Rota sulla
struttura dell'ex convento. Nel 1576, successore del citato
Vincenzo fu suo figlio Francesco Maria; a quest'ultimo,
nel 1591, gli successe suo figlio Muzio, diventando il
3° barone di Santa Maria della Rota e di
Mangalavita. Alla sua morte, nel 1621 lo eredita sua
figlia Violante la quale sposa suo cugino Pietro Paolo
in seguito alla dispensa dell'impedimento per consanguineità.
Nel 1659 il feudo fu venduto a Filippo Cavalcanti
chiedendo il regio assenso al possesso, e gli venne imposto di
farsi giurare fedeltà dai vassalli e insieme a loro giurare
fedeltà al re Filippo IV d'Austria. Il nuovo barone inizia i
lavori di ampliamento del palazzo di Santa Maria della Rota
(oggi denominato palazzo Ricci). Nel 1760 troviamo Vincenzo
come 5° barone di Santa Maria della Rota e di Mangalavita e
barone di Cerzeto, quest'ultimo
ereditato anni prima. |
|
.gif)
Cerzeto (CS), Palazzo Andreotti
già Cavalcanti - tratto da Google Earth |
|
Pompeo Cavalcanti nel 1543 acquista il feudo di Gazzella
(già appartenuto ai Cavalcanti).
Curzio suo ultimo figlio protagonista di una triste
vicenda: si invaghisce di Flavia
de Gaeta
e, consigliato dalla fattucchiera Laudomia Mauro, la rapisce, il
padre della ragazza don Ferrante de Gaeta riesce a farlo
catturare e viene imprigionato nell'arcivescovado; Curzio
sostiene di essere stato istigato dalla Mauro, la quale viene
portata al rogo. Successivamente i due si sposarono e, nel 1629,
Curzio riesce ad acquistare il feudo di Verbicaro e San Biagio
(tramite il prestanome Angelo
de Matera)
da Antonio Castellar (italianizzato Castiglione) per 40.500
ducati; 2° barone di Verbicaro e San
Biagio fu suo figlio Giovanni, sposato con
Beatrice
Carafa figlia del barone di Tortorella, Francesco; morto
senza prole prematuramente gli successe suo zio Angelo,
3° barone di Verbicaro e San Biagio, sposato con Francesca
Cavalcanti; il loro figlio Ludovico (nato nel 1650) fu il
4° barone di Verbicaro e San Biagio, patrizio
Napoletano e cavaliere dell'Ordine
di Malta; sposato con Ippolita Cavalcanti. |
|
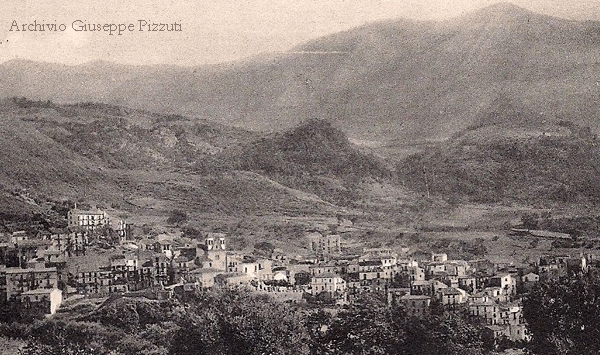
Verbicaro (CS) |
|
Antonio († 1768), 5° barone di Verbicaro e San Biagio, nipote del citato
Ludovico, sposato con Rosa Pascale,
patrizia di Cosenza, ha avuto come figlio
Francesco (1738 † 1795), 6°
barone di Verbicaro e San Biagio e dal 1789 marchese, sposato a Maria Vincenza
Caracciolo,
figlia di Nicola, 6° duca
di Vietri, e di Maria Giuseppa da
Ponte dei duchi di
Casamassima; suo successore fu il marchese Michelangelo Cavalcati (1736 † 1836), con l'abolizione
della feudalità il predicato "di Verbicaro" fu parte integrante
del cognome, patrizio
di Napoletano, patrizio
di Cosenza (titolo
che non verrà successivamente registrato),
barone
di Verbicaro e San Biagio, sposato a Maria
Caterina de'
Medici dei principi di
Ottajano, ha avuto come figlio il marchese Angelo (1801
† 1866), sposato con donna Chiara Adelaide Saluzzo
dei duchi di Corigliano, ha avuto come figli: Giacomo,
sposato a Vittoria Kernot, ha avuto come figli Vincenzo
(n. 9 marzo 1873), Alfredo (n. 13 giugno 1876),
Eugenio registrato nell'Elenco U(n. 3 marzo 1878); ed il
primogenito marchese Michelangelo (1831 † 1896),
patrizio Napoletano, registrato nell'Elenco Ufficiale della
Nobiltà Italiana con il titolo di marchese (mpr.), nobile dei
marchesi di Verbicaro
(m.f.), patrizio Napoletano (m.).
Sposato in prime nozze il 18 dicembre 1858 a Caterina Steinach,
ha avuto come figli Francesco (n. 15 aprile 1861), e
Leopoldo (n. 8 settembre 1866); in seconde nozze sposato il
22 luglio 1872 ad Elisa Mohr, vedova di Filippo Caracciolo di
Torchiarolo. |
|

© Arma partita con le insegne delle
famiglie Mollo e Cavalcanti, posta sulla lastra tombale di
Maria
Carmela Cavalcanti († 1841),
moglie del barone Vincenzo
Maria Mollo. |
|
Antonello nel 1549 è intestatario del feudo di Cammicelle
nella bagliva di Tarsia.
Luigi, già vescovo di Nusco, è nominato vescovo di
Bisignano.
Bernardino Cavalcanti nel 1565 è sindaco dei nobili di
Cosenza.
Dal 1567 al 1577 sono feudatari di Cleto.
Giulio Cavalcanti, Accademico Cosentitino, nel 1588
scrive " La vita e i miracoli di San Francesco di Paola".
Diana Cavalcanti, dal 1593 badessa del monastero di Santa
Croce di Gerusalemme dell' Ordine delle Cappuccinelle di
Cosenza.
Marzio Cavalcanti nel 1599 è sindaco dei nobili di
Cosenza.
Nel 1612 venne completata la chiesa di San Domenico, con annesso
convento dei Domenicani, il portone fu fatto realizzare dalla
famiglia Cavalcanti, all'interno di essa vi è la cappella
gentilizia di famiglia. Luigi nel 1623 è arcidiacono del
Capitolo Cosentino; Lorenzo e Giuseppe sono
letterati e canonici della cattedrale. |
|
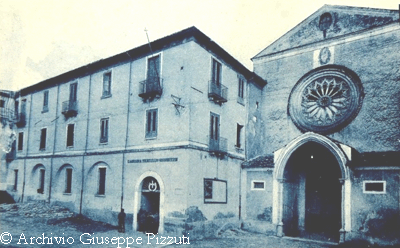 |
|
Cosenza, complesso monumentale di San Domenico

Cosenza, Portone Chiesa di San
Domenico, stemma Cavalcanti |
|

Cosenza, Cattedrale, stemma
Cavalcanti |
|
Nel 1629 Francesco di Tommaso,
barone di Torano, ottenne il titolo
di duca; inoltre acquistò da Ippolito Cavalcanti,
barone di Sartano (frazione di
Torano) i feudi di Castiglioncello e Peritano.
|
|

Sartano (frazione di Torano
Castello), Palazzo Baronale - tratto da Google Earth |
|
Il citato Ippolito e sua madre, fecero erigere l'Altare di San
Domenico nella chiesa matrice di Sartano; nel 1641 Ippolito trasferisce
il feudo a suo figlio Lucio; quest'ultimo sposando la
baronessa di Buonvicino Laudomia De Paola acquisisce anche
questo feudo; Laudomia morirà di parto nel 1652 alla nascita di
Ippolito; il figlio di quest'ultimo, Lucio Cavalcanti nel
1714 è barone di Buonvicino, nel
1720 ottiene da
Carlo VI il titolo ducale sul feudo; il duca Lucio nel 1727
intraprende una causa per entrare in possesso dei beni del ramo
dei Cavalcanti di Firenze che nello stesso anno con la morte di
Alessandro si estinsero. Ippolito, suo figlio diventerà
2° duca di Buonvicino. Nel 1782
Lucio Vincenzo è il 3° duca di Buonvicino. Guido
Cavalcanti, cadetto del ramo di Buonvicino nel 1785 è
governatore regio di cappa e spada a Napoli; nel 1787 è
trasferito ad Afragola per amministrare la giustizia; nel 1797
gli viene conferito il titolo di duca; sposa la nobile Anna
Carapelli con la quale dà alla luce il primogenito Ippolito che
eredita il titolo di duca, (da non confondere col titolo di duca
del feudo di Buonvicino del ramo principale); nel 1837 pubblica
il "Trattato di Cucina
teorico - pratica", in lingua italiana per gli aristocratici e
in lingua napoletana per la borghesia, che resta ancora
tutt'oggi un punto di riferimento per gli chef.
|
|
Fu il primo a far bollire la carne nel sugo di pomodoro e,
con le aggiunte introdotte da altri valenti cuochi napoletani, fu
inventato il ragù.
Il primo Istituto Professionale
Alberghiero d'Italia nasce a Napoli nella Villa delle Ortensie,
intitolato ad Ippolito Cavalcanti.
La cucina napoletana, dai classici
sapori mediterranei, nel corso dei secoli è stata influenzata dalle
varie dominazioni, dai greci ai francesi ma, in particolar modo
dagli spagnoli che importarono dalle Americhe nuovi prodotti quali i
pomodori, le patate, il granoturco e il caffè.
Gli aristocratici vantavano di avere ai loro servizi i migliori
cuochi campani, veri artisti culinari, inventori di tante delizie.
Ogni famiglia aveva la sua pietanza particolare con i propri segreti
e, a tal proposito, si consiglia la lettura del libro "La cucina
aristocratica napoletana" di Franco Santasilia di Torpino - Mario
Guida editore. |
|
© Napoli - Via Toledo - Palazzo
Cavalcanti |
|

La dimora di via Toledo fu fatta
costruire nel 1762 dal marchese Angelo Cavalcanti, come si evince dalla
scritta marmorea posta
sul portale d'ingresso: "ANGELUS DE
CAVALCANTIBUS MARCHIO SIBI SUISQUE FECIT A. DOMINI MDCCLXXII". |
|
Angelo nel 1638 è provveditore speciale per la
costruzione della cappella della Beata Vergine nella chiesa di
San Francesco d'Assisi di Cosenza.
Pompeo nel 1650 è sindaco dei nobili di Cosenza.
Domenico nel 1754 è sindaco dei nobili di Cosenza.
Nel 1763 Domenico Gaetano, padre teatino, del ramo di
Sartano e confessore della regina Maria Amalia, pubblica "La
Sacra Liturgia della Chiesa".
Nel 1770 Daniele, patrizio di Cosenza, figlio di
Carmine; sposato in prime nozze con Cecilia
Castiglione
Morelli, patrizia cosentina e in seconde nozze con Gaetana
Cavalcanti di Roberto, patrizio cosentino e Saveria
Cavalcanti; restaura e sopraeleva il palazzo di Cosenza in via
Giostra Nuova. |
|
Caccuri paese della presila in provincia di Crotone, fu feudo
all'interno del quale si susseguirono diverse famiglie: il conte
Carlo Ruffo
di Montalto lasciò il feudo a sua figlia Polissena, la quale
sposò Francesco Sforza gran duca di Milano, seguirono gli
Spinelli,
Sersale
e Cimino. |
|
,%20CASTELLO.gif)
Caccuri (Crotone), il Castello |
|
Alla morte di Francesco Cimino nel 1608 gli successe suo figlio
Paolo, quest'ultimo, essendo morto senza prole, il feudo passò a
suo fratello Giovan Battista, il quale essendo travolto dai
debiti il feudo venne posto all'asta; ad acquistarlo, nel 1651,
fu il patrizio cosentino Antonio Cavalcanti,
4° barone di Gazzella e
1° barone di Caccuri; sposato con Beatrice
Cavalcanti; ristrutturò il castello, impreziosì la cappella;
alla sua morte nel 1676 gli successe suo figlio Marzio al
quale fu concesso il titolo di duca di
Caccuri con privilegio del 1683 da re
Carlo II, titolo trasmissibile per maschi primogeniti;
sposato con Cleria Cavalcanti (del ramo dei
baroni di Rota e Mangalavita), la
quale portò in dote il feudo di Cerzeto. Nel 1690 iniziarono i
lavori per la nuova cappella del SS. Rosario all'interno del
convento dei Domenicani su iniziativa di alcuni cittadini di
Caccuri, per la realizzazione contribuì anche la famiglia
ducale. |
|
Nel 1694, successe al citato
Marzio suo figlio
Antonio
(† 1709) 2° duca di Caccuri;
sposato con Laudomia
de Gaeta, figlia di Antonio, patrizio di Cosenza, Reggente
del Collaterale, e di Vittoria Astorga, ebbero per figli:
Cleria,
sposata a Felice Nicola
Sambiase, principe di Campana;
Francesco Antonio,
fu Preposito generale dell'Ordine dei Teatini nel 1740 e dal
1743 al 1748 arcivescovo di Cosenza, in questo periodo
Giacomo Casanova è a Cosenza in cerca di un impiego da
segretario, viene aiutato economicamente dall'arcivescovo
affinchè possa recarsi a Napoli, fornendogli anche delle lettere
credenziali (verrà ricordato nelle sue "Memorie" come "uomo
di spirito e danaroso"); |
|
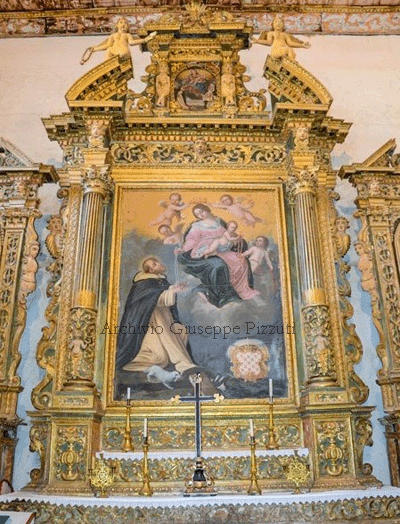
Caccuri (Crotone),
Chiesa della Congregazione e del Santissimo Rosario,
tela raffigurante la Vergine del Rosario
e San Domenico, in basso a destra si può ammirare lo stemma dei
duchi Cavalcanti. |
|
Domenico Andrea,
anch'esso Teatino, fu arcivescovo di Trani dal 1755 al 1769;
Rosalbo,
Gran Priore dell'Ordine
di Malta,
Balì Gran Croce e ricevitaore in Napoli; e
Marzio
(†
1752) 3° duca di Caccuri, come erede per la morte di suo padre,
duca Antonio, sposato a
Serafina
Cavalcanti, figlia di
Camillo,
barone di Sartano, ebbero come figlio primogenito
Antonio,
che rinunziò alla successione per vestire l'abito
gerosolimitano; e
Rosalbo,
4° duca di Caccuri, come erede per la morte di suo padre, duca
Marzio e stante la rinunzia del fratello, frà Antonio, sposò
Marianna
Zurlo dei nobili
di Crotone.
Gaetano Maria
(†
1793) 5° duca di Caccuri, come erede per la morte di suo padre,
duca Rosalbo, in rappresentanza dei diritti della sua ava
Serafina, rivendicò, contro il barone Gaetano
Campagna
la terra di Sartano, posseduta dalla famiglia Cavalcanti sin dal
1363, con le seconde e terze cause civili, criminali e miste, il
22 luglio 1785 ottenne il Regio Assenso e l'intestò il 21 luglio
1787, sposò in prime nozze Teresa
Passalacqua, figlia di Giuseppe, patrizio di Cosenza e
barone di Pittarella, in seconde nozze, nel 1787, Vincenza
Folgore dei marchesi di Ducenta. |
|

Caccuri (Crotone), Cappella Palatina, stemma partito del
duca Gaetano Maria
Cavalcanti
e della consorte Teresa Passalacqua,
patrizia di Cosenza, sposati nel 1783 |
|
Marianna,
6^ duchessa di Caccuri, baronessa di Sartano, come erede
per la morte di suo padre, duca Gaetano Maria, nel 1797
ebbe l'ultima intestazione, sposò il marchese Giuseppe
Ceva Grimaldi,
marchese di Pietracatella, duca delle Pesche.
Rachela Ceva Grimaldi
(†
1853), 7^ duchessa di Caccuri come erede per la morte di
sua madre, duchessa Marianna, titolo riconosciuto con
R.R. del 24 febbraio 1851, sposò in prime nozze
Francesco
Petra
(1800
†
1832) dei duchi di Vastogirardi, in seconde nozze suo
cognato Raffaele Petra, marchese di Caccavone.
Carlo Petra
(1830 m. 1889), 8° duca di Caccuri, successe nel titolo,
come figlio di primo letto, a sua madre, duchessa
Rachele.
Nel 1830, Rachele, aveva venduto l'ex feudo (a seguito
dell'abolizione della feudalità nel 1806) al barone
Luigi
Barracco, il castello fu stabile dimora di uno dei
suoi figli, Guglielmo; all'inizio del Novecento il
castello fu venduto alla famiglia Fauci di Isola Capo
Rizzuto ed attuali proprietari, i quali hanno eseguito
un attento restauro conservativo creando degli ambienti
anche per gli ospiti. |
|
I vari rami si sono tutti
estinti ad eccezione di quello di Napoli. Più volte vestirono
l'abito di Malta (vedi
Lapidario).
Giovanni
Cavalcanti fu Reggente della Vicaria nel 1335.
Riccardo
fu
Gran Contestabile del Regno di Napoli.
Americo
fu Giustiziere di
Principato Citra e governatore di Capua.
Mainardo
fu Maresciallo e Capitano di Amalfi.
Angelo
fu Luogotenente della
Regia Camera della Sommaria.
Coriolano,
ammesso nel 1591 nei Cavalieri di
Malta, figlio di
Cesare,
patrizio di Cosenza (di
Pietro Cola,
cadetto di
Alfonso, primogenito premorto di
Aloisio,
4° barone di
Sartano, e di Covella
Cicala dei
patrizi di Cosenza) e di Dianora
Spadafora figlia di Giovan Battista e di
Bernardina de Gaeta.
Francesco,
barone di Cannicella, sposò
Elena
Falangola (1590 † 1657), baronessa di Fagnano, Malvito e
Pietrapiccola.
Don Pietro
Luigi Cavalcanti, tenente colonnello graduato,
con Real Decreto del 7 ottobre 1816, fu nominato cavaliere di
diritto del
Real Ordine di S. Giorgio della Riunione. |
|

Napoli - ciò che resta della
distrutta Chiesa Cavalcanti a Materdei, poi trasportato in altra
chiesa:
una porta in bronzo (a sinistra) e
una tela raffigurante
"Cristo morto" di Andrea Vaccaro (1598-1670). |
|
_________________
Note:
1)
- Libro d'Oro Napoletano - Archivio di Stato di Napoli -
Sezione Diplomatica.
_________________
Bibliografia:
-
"Si chiamavano Cavalcanti" a cura di
Silvio Umberto Cavalcanti.
- "Storia dei Cosentini" a cura di Davide Andreotti.
- Sito web
http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/829.
- Vincenzo
di Sangro,
conte di Rodiano "Genealogia di tutte le famiglie
patrizie napoletane e delle nobili fuori seggio
aggregate come montiste al
Real Monte di Manso",
Napoli 1895.
|
|
Continua
nel sesto
volume in preparazione di "LA STORIA DIETRO
GLI SCUDI"
Copyright © 2007 www.nobili-napoletani.it
-
All rights reserved
|
|