|
La famiglia Spiriti,
originaria della Germania, giunse in Italia per stabilirsi a
Viterbo, successivamente a Gaeta e nel Trecento giunse a
Cosenza.
Dal libro dei parlamenti di Cosenza del 1493 e nei privilegi
della città, la famiglia Spiriti figura inclusa nella seconda
piazza degli onorati cittadini.
Andrea,
fu membro della Camera Apostolica di papa Innocenzo VIII e
generale di papa Alessandro VI.
Giovanni
Battista, fu ambasciatore per la città di
Viterbo al papa Giulio II, duce dell'esercito dell'imperatore
Massimiliano, dal quale ottenne d'inserire nello scudo l'aquila
imperiale.
Cristoforo,
creato vescovo di Cesena nel 1510 da papa Giulio II, nel 1550 da
papa Giulio III fu creato patriarca di Gerusalemme, morì nel
1556.
Andrea
è menzionato in un contratto del 1443 con Galeazzo
di Tarsia, barone di Belmonte, e Guido di Sorrento, signore
di Mottafollone.
Pietro,
figlio di Andrea, parteggiò per gli aragonesi, nel 1493 fu
sindaco del popolo di Cosenza nel mentre era sindaco dei nobili
Rao
Firrao; nel 1498 fu inserito nell'elenco dei popolari civili
e mandato al re con le seguenti parole: “Item
vi è Pietro di Spirito, di anni 70, sindaco del populo da
cinque anni.”
Giovanni,
figlio di Pietro, da un atto del notaio
Donato di Cosenza risulta che: nel 1498 vendette venti canne
di panno di lana nobile di vario colore a Nicola Carolei a
credito di diciotto ducati, a Francesco
Migliarese diede a credito altre dodici canne di panno
rosso, di palmi tre, al prezzo di dodici carlini ciascuna.
Giacomo,
nel 1501, fu affittatore della bagliva
di Cosenza.
Giovanni
juniore,
nel 1515, dopo aver goduto la seconda piazza, fu aggregato a
quella del nobile sedile con altre famiglie, tra di esse i
Bombini ed i
Caputo.
Antonio
(† 1594), sposato a Lucrezia
Ciaccio,
il suo testamento è datato 18 novembre 1594, stipulato per mano
del notaio Orazio Migliorelli da Cosenza, fu aperto il 22
novembre dello stesso mese e pubblicato nella Corte dei Regi
Baglivi della Città di Cosenza, ad istanza di don Muzio
Gaeta
da
Cosenza: erede universale la moglie Lucrezia Ciaccio. Lascia una
bottega al nipote
Cesare
Spiriti del fu
Giovanni Battista.
Lascia una rendita annua di tredici carlini alla sua Cappella di
S. Giacomo nel Monastero di S. Domenico, ed un'altra rendita
annua di venticinque carlini all'altare privilegiato della
Cattedrale di Cosenza, per la celebrazione di una messa cantata
di requie ogni anno, gravando queste due rendite sulla bottega
lasciata al nipote Cesare
(1).
Giovanni
Battista, di
Cesare
e Caterina Favaro, sposò Vittoria
Barracco, figlia di Alfonso, barone di Lattarico, e
di Chiara
Lucifero.
Giovan Alfonso, patrizio di Cosenza, sposò
in prime nozze Cornelia Pisciotta († 1652),
marchesa del
feudo di Casabona con annesso il casale di San Nicola
(oggi comune di San Nicola dell'Alto).
Giovan
Battista († 1658), marchese di Casabona per
successione a sua madre, marchesa Cornelia, in qualità di
figlio primogenito, ebbe per figli:
Domenico Antonio
e Diego,
che ereditò il titolo di marchese di Casabona, nel 1694
vendette, per la somma di ducati 55.250 il feudo di Casabona col
casale di San Nicola a Partenio Rossi dei duchi di Castelluccia,
con Regio Assenso del 6 ottobre dello stesso anno; sposò
Antonia
Spiriti figlia di
Giuseppe.
Salvatore,
acquistò il feudo rustico di Schito
(o Ischito; oggi bene del comune di San Pietro in Guarano nel
quale ricade, ottenuto con sentenza del 16 maggio del 1889 del
Collegio arbitrale per gli affari della Sila) nella Sila Grande,
dal barone Pietro Fulvio Greco, con Regio Assenso del 1705
(2).
Giuseppe
(† 1751), figlio di Salvatore, nel 1717 successe nel feudo di
Schito; sposò donna Ippolita
Cavalcante dei duchi di Buonvicino, ed ebbero per
figli: Giovan
Battista,
Antonio,
ed il primogenito
Salvatore,
il quale ereditò il feudo di Schito.
|
.gif)
Casabona (Crotone) |
Salvatore
(1713 † 1776), figlio di Giuseppe ed Ippolita, in giovane età fu
mandato a Napoli a studiare presso il Seminario dei Nobili,
conseguì gli studi giuridici; avvocato di successo in Napoli,
ricoprì cariche pubbliche al servizio di
Carlo di Borbone, nel 1751 fu nominato governatore di Amalfi
e, successivamente di Sorrento e Pozzuoli, fu consigliere del
Supremo Magistrato del Commercio e Giudice della
Gran Corte della Vicaria; fu membro della Camera di Santa
Chiara, il più alto organo giurisdizionale napoletano. Salvatore
è ricordato come scrittore e poeta, scrisse sin dalla giovane
età, nonostante le sue cariche pubbliche che lo trattenevano
fuori Cosenza restò molto legato alla città, sposò Anna
Giannuzzi Savelli dei baroni di Pietramala, non ebbero
discendenza; fu Accademico Cosentino dando nuova vitalità all'
Accademia denominata de' Costanti (in quanto rilanciata da
Giovan Battista Costanzo,
arcivescovo di Cosenza); in quest'ambito decise di
realizzare l'opera “Memorie
degli Scrittori Cosentini”, pubblicata nel 1750,
molti dei quali erano stati membri dell'Accademia; nel 1758
pubblicò una nuova edizione de “Le
Rime” di Galeazzo di Tarsia dedicandola alla giovane
poetessa Giacinta
Orsini,
ammessa nell'Accademia dell'Arcadia di Roma(3)
all'età di quattordici anni, paragonandola alla poetessa del
Cinquecento
Vittoria Colonna alla quale fu dedicata l'opera da Galeazzo.
A Napoli frequentava il suo conterraneo Gaetano
Argento col quale condivideva l'dea di laicità dello stato
ovvero di contrastare le ingerenze della chiesa, in questo
contesto pubblicò “Trimerone”.
|
 |
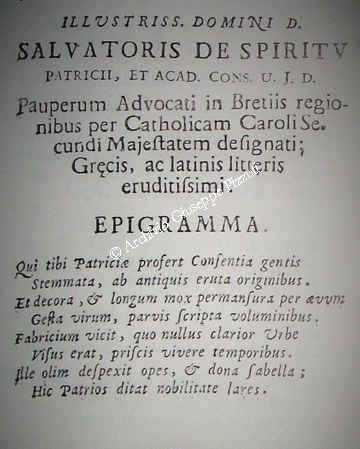 |
|
Opera di Salvatore Spiriti. A destra: elogio a Fabrizio Castiglione Morelli |
Nicola
Spiriti, patrizio di Cosenza, il 6 marzo del 1766 di ritorno da
Napoli consegnava alla venerabile Congregazione dei Nobili di
Cosenza due statuette in avorio come atto di donazione per conto
del Padre Don Antonio Caputo, dell'Oratorio di San Filippo Neri
in Napoli, di origine cosentina del ramo dei duchi Caputo di
Torano “per sua
divotione d'amore, e per la venerazione,
e stima che conserva
verso la suddetta Nobile Congregazione”, le opere
raffigurano: Cristo alla colonna, e San Sebastiano (4),
di scuola Michelangiolesca, si possono ammirare nel museo
diocesano di Cosenza. Erano destinate per l'Altare della
Cappella che usava la Congregazione dei Nobili già Congregazione
sotto il titolo di Santa Maria della Misericordia come scrisse
Davide Andreotti nelle pagg. 236-237 del Vol.II della sua opera
"Storia dei Cosentini", pagine nelle quali descrisse
la storia della Congregazione e che quì riportiamo in sintesi:
... eretta sotto Carlo V nel 1531 ed aveva il pietoso fine di
servire ed accompagnare coloro che dovevano giustiziarsi, e nel
mentre erano nella Cappella di provvederli di ciò che loro
occorresse e di fornirgli la sepoltura nella loro Chiesa,
comprarono le case che Girolamo Migliarese possedeva
dirimpetto il Convento de' Padri Domenicani; e perchè
l'assistenza spirituale venisse scrupolosamente prodigata agli
infelici, si offerivano dodici sacerdoti tra i confratelli, che
vestivano l'abito bianco, e portavano la croce al petto in segno
di nobiltà. La congregazione venne successivamente sostituita
dalla Congregazione dei Nobili che aveva sede nel monastero dei
Gesuiti; soppresso l'ordine dei Gesuiti nel 1767 i confratelli
si riunivano in luoghi diversi e principalmente nella Chiesa dei
Teatini; nel 1793 ebbero da Monsignor Mormile il
possesso della Chiesa dedicata a San Filippo e Giacomo, siccome
essa sorgeva nel vecchio cimitero della Cattedrale si rese
officiabile nell'anno 1800; nel 1826 si abbellì con un sedile in
noce, vi si dipinsero i quadri della soffitta, i due quadri
accanto alla porta e posteriormente vi si allogarono le due
statuette di avorio, dono di un signore di Casa
Majo, esprimente l'una un S. Sebastiano martire, e l'altra
un Cristo alla colonna, opera del Buonarroti, di un pregio e di
un valore inestimabile.
|
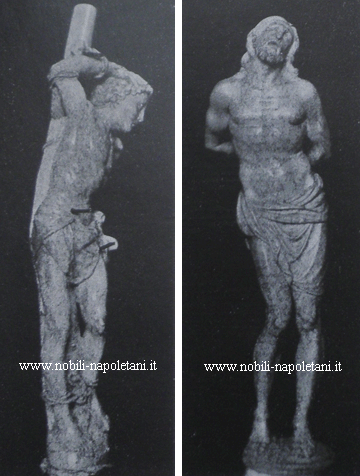 |
Possiamo ragionevolmente desumere che: le statuette fossero
custodite in casa de Majo in quanto la Congregazione dei Nobili
non aveva una cappella stabile dove prestare l'opera pietosa;
con la concessione della cappella ovvero della chiesa dei Santi
Filippo e Giacomo la famiglia de Majo ritenne opportuno dotarne
la medesima come aveva previsto in origine il suo donatore.
|
Cosenza, Cappella dei Nobili. A destra: stemma Spiriti (dall' opera di Fabrizio Castiglione
Morelli) |
Giuseppe
(1757 † 1796), figlio
di Antonio
e Benedetta Caviola, nipote del poeta e scrittore Salvatore, dal
quale aveva ereditato il feudo di Schito, insigne per dottrina
ed autore di diverse opere, il primo maggio del 1792 indirizzava
al capo del governo John Francis Edward
Acton
le sue
"Riflessioni economiche politiche d'un cittadino relative alle
due provincie di Calabria" per denunciare al governo
la grave situazione di miseria della sua patria che si erano
aggravate dopo il terremoto del 1783; morì assassinato a Napoli,
i suoi compatrioti accusarono l'Acton in quanto era suo
personale nemico. Altri suoi scritti furono:
"De' Mali politici ed economici che
affliggono le Calabrie,
e progetto come provvedervi",
"Brevi ricerche sulla
natura e numero
degli eserciti che
convengono in tempo di pace a' Regni di Napoli e Sicilia",
"Esposizione delle
Teogonie e
Cosmogonie antiche",
" Elocubrazioni
scientifiche naturali",
"Memoria della città
di
Nicastro",
" Compendio della
storia del Tiraboschi",
"Saggio sulle virtù
morali",
"Memoria sulle
seti in Calabria",
volume di
"Cantate, sonetti e poesie varie".
Salvatore,
figlio di Giuseppe, ereditò il feudo di Schito e
ne fu l'ultimo intestatario.
|
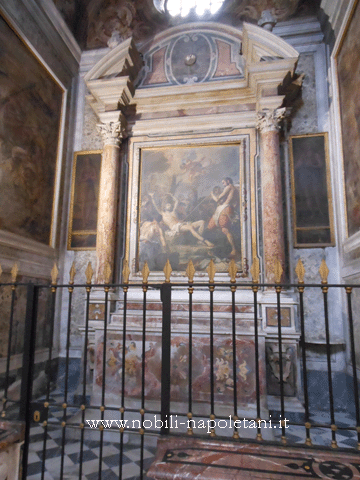 |
 |
|
Napoli, Cappella famiglia
Spiriti, dedicata a Sant'Eligio. A destra: lastra tombale di Nicola
Spiriti - Anno 1792 |
|

Napoli, stemma famiglia
Spiriti, marchesi di Montorio |
Salvatore (1785 † 1840),
barone di Schito, Consigliere d'Intendenza, sposò Rosa Spiriti
(† Cosenza, 14 settembre 1858 all'età di 73 anni), ha avuto come
figli: Giovanni Battista Maria Francesco (n. Cosenza, 7
maggio 1810); Maria Gabriella (n. Cosenza, 5 febbraio
1812); Benedetto
Maria Baldassarre Gaspare (n. Cosenza, 26 maggio
1814);
Francesco Nicola (n. Cosenza, 27 gennaio
1824), sposato nel 1842 a Maria Castiglione, ha
avuto come figlio Salvatore (n.
Napoli, 2 marzo 1843), il 7 agosto 1869 sposò la contessa Luisa Ricciardi ed
ha avuto come figli Francesco (n.
29 giugno 1871), e Maria;
Giuseppe Maria (n. Cosenza, 27 gennaio 1824),
sposato a Cosenza il 7 maggio 1843 con Carolina Antonia Tirelli (n.
Cosenza, 25 marzo 1821), figlia di Antonio e di Rachele Marsico, ha
avuto come figli: Francesca
Immacolata Anna Tommasina
(n. Cosenza, 22 dicembre 1846 †1916), sposata a Cosenza il 21
maggio 1865 con Giovanni Masci di Santa Sofia (1840 † 1887),
figlio di Giuseppe e di Faustina Cosentino (sposati
ad Aprigliano il 25 ottobre 1835); Enrica Giralda Maria
Pilerio (n. Cosenza, 29 dicembre 1850), sposata ad Enrico
Aloe.
|

Cosenza, stemma Aloe, famiglia originaria
di Dipignano; la tela raffigura San Francesco di Sales e
San Francesco da Paola, commissionata dal canonico
Luigi e da Eugenio, quest'ultimo sposato nel
1802 a Tommasina del Gaudio |
|
Nel 1858 fu richiesta una perizia giudiziaria per la
verifica della servitù di passaggio delle acque del
fondo Campagnano nel territorio di Rende, venduto
a Raffaello Conti dalla marchesa Rosa Spiriti di
Cosenza. Altra perizia fu richiesta nel 1860 per la
valutazione e divisione dei beni ereditari della
marchesa Rosa Spiriti, Maria Castiglione, Nicola Spiriti,
e Luigi Ferrari
d'Epaminonda. Archivio di Stato di Cosenza, anno
1858, B. 24, perizia 19; anno 1860, B. 28, perizia 67.
Il ramo secondogenito dei marchesi di Casabona, con Nicola (Cosenza,
20 gennaio 1792 † Napoli, 16 agosto 1875), patrizio di
Cosenza, figlio di Gaetano, con Regio Decreto del
3 agosto 1855 acquisì il titolo di duca
di Castelnuovo (5) come
erede di sua zia Rosa Marotta; socio corrispondente
della Società
Economica di Calabria
Citra,
sviluppò nella città di Cosenza la lavorazione della
seta, meritandosi una medaglia all'esposizione di Napoli
nel 1853; sposato il 19 luglio 1814 a Teresa dei baroni Passalacqua (Cosenza,
6 luglio 1800 † Napoli, 15 luglio 1875), ha avuto come
figli: Gabriella (n.
Cosenza, 2 marzo 1824), sposata a Salvatore dei marchesi Nunziante;
Gaetano Francesco Maria (n. Cosenza, 4
maggio 1822 † ivi, 24 settembre 1822); Gaetano Luigi
(n. Cosenza, 28 maggio 1826); Vincenza,
sposata ad Edoardo Cianciulli; e Luigi (Napoli,
8 gennaio 1833 † 1896), patrizio di Cosenza, duca di
Castelnuovo, sposato il 14 febbraio 1857 ad Emilia
Cianciulli (n. 31 marzo 1836), ha avuto come figli: Teresa (n.
Napoli, 1° giugno 1876); Maria (n.
Napoli, 8 aprile 1875); Giuseppe (n.
Parigi, 8 maggio 1861); e Nicola (n.
Napoli, 12 febbraio 1858). |
|
.gif)
Castelnuovo al Volturno
(Isernia) |
Alla famiglia fu riconosciuta la
nobiltà generosa
nel 1850 in occasione della prova di Regia Guardia del Corpo
dalla Regia Commissione dei titoli (Verbali, Vol. VI, pag. 232).
La famiglia è iscritta nell'Elenco Ufficiale della Nobiltà
Italiana col titolo di patrizio di Cosenza (m.) (del ramo dei
marchesi di Casabona) per i discendenti di Salvatore
Spiriti (n. Napoli 1843) figlio di Francesco
(1824 † 1846) e di Maria Castiglione
Morelli;
sposato con Luisa Ricciardi.
E' iscritta con i titoli di
patrizio di Cosenza
(m.) e di
duca di Castelnuovo
(mpr.) per i discendenti di Nicola (n. nel 1732), e
rappresentato alla fine dell'Ottocento da Nicola (n.1858)
figlio di Luigi (1833 † 1896) e di Emilia Cianciulli;
sposato con Zilia Catalano Gonzaga dei duchi di Cirella.
I fratelli Erasmo Spiriti (1762 † 1843), frate olivetano,
Paolo (1759 † 1851),
Cavaliere Melitense
di giustizia dal 19-VI-1779, Priorato di Capua (avendone fatta
la prova Giovanni, capostipite, nel 1515, potrebbe essere
identificano in Giovanni Battista, ambasciatore per il papa
Giulio II a Viterbo), e Girolamo Spiriti (1758 † 1838),
marchese
di Montorio,
della famiglia patrizia di Cosenza, poi
aggregati anche alla nobiltà di Gaeta,
ereditò il titolo marchionale dalla famiglia Balsamo nel 1729
con anzianità dal 1674, poi appoggiato sul feudo di Montorio al
Vomano in
Abruzzo Ultra,
con ultima intestazione del 16-III-1793; i tre fratelli erano
iscritti nel registro delle famiglie dei Cavalieri di Malta di
giustizia. Questo ramo si è estinto nella linea primogenita con
la marchesa Maria Francesca Spiriti (1803 † 1871), figlia
del marchese Girolamo (1758 † 1838), sposata a Francesco
Vasaturo
(famiglia dichiarata nobile nel 1614 ed
insignita nel 1728 del titolo di duca). La linea
secondogenita si estinse all'inizio del XX secolo con i figli,
morti tutti scapoli, di Erasmo Spiriti (1799 † 1872),
figlio di Paolo (1759 † 1851).
|

Napoli, stemma Vasaturo |
Il ramo dei patrizi di Cosenza,
baroni
di Schito
e
marchesi di Casabona
(in realtà aveva il solo titolo di baroni di Schito, ultima
intestazione 9-VIII-1797, pretendevano il titolo di marchese di
Casabona per successione alla famiglia Pisciotta, ma non
possedevano più il feudo dal 1694 ed il titolo non fu trasferito
su altro feudo come prevedevano le leggi del tempo) è iscritto
nel registro delle famiglie dei Cavalieri di Malta di giustizia
per i discendenti di Salvatore Spiriti (1785 † 1840), suo
prozio Giovan Battista (n. 1718), i suoi cugini
Gaetano (n. 1753), e Benedetto (1763 † 1841), figlio
di Nicola Salvatore (1716 † 1787), e Nicola (1792
† 1875), figlio di Gaetano (n. 1753)
(6).
Il ramo dei patrizi di Cosenza, in persona del Cav.
Antonio, ammesso nel 1548, come riporta E. Amato e ripreso
da Gustavo Valente (potrebbe essere identificato in quell'Antonio
morto nel 1594 e sposato a Lucrezia Ciaccio); e successivamente
con il Cav. Antonio (Cosenza, 29 aprile 1592), figlio di
Giovanni Battista e di Vittoria Barracco, ammesso nel
1617; e nel 1774 in persona del Cav. Luigi, patrizio di
Cosenza, per prova di consanguineità col citato Cav. Giovanni.
La chiesa di San Giovanni Gerosolimitano, poi data in Commenda,
risalente all'alto Medioevo, fu ristrutturata nella seconda metà
del Cinquecento e, a fine Ottocento una seconda volta per volere
del Cav. Luigi Spiriti (1833 † 1896), patrizio di Cosenza
e duca di Castelnuovo, in qualità di proprietario.
|
 |

|
|
Cosenza, Chiesa di San
Giovanni Gerosolimitano, porta
laterale, scritta battuta sul metallo: Anno 1882 Luigi
Spiriti
duca di Castelnuovo.
A destra:
Cosenza, Chiesa di San
Giovanni Gerosolimitano,
facciata con stemma Spiriti nel timpano |
|

Cosenza, Chiesa di San
Giovanni Gerosolimitano |
|
La famiglia aveva costruito un Casino in contrada
Fontanesi di Castrolibero (già Castelfranco che con
Cerisano formava un feudo appartenuto alla famiglia
Telesio
e poi passato alla
Sersale).
Di seguito alcune immagini del Casino tratte dal sito https://www.adaimmobili.it/web. |
Parentele:
Cavalcanti,
Cianciulli,
Collice,
Colonna, Giannuzzi
Savelli, Marotta, Masci,
Nunziante,
Orsini,
Passalacqua,
Pisciotta, Ricciardi,
Sambiase,
Spina,
Telesio, Vasaturo. |