|
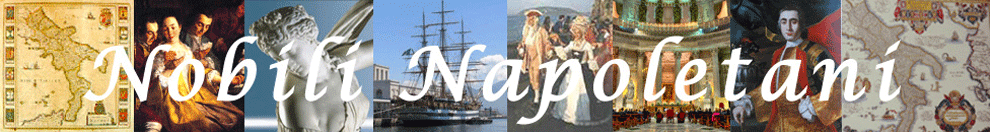
Ovvero delle Famiglie
Nobili e titolate del Napolitano, ascritte ai Sedili
di Napoli, al Libro d'Oro Napolitano, appartenenti
alle Piazze delle città del Napolitano dichiarate
chiuse, all'Elenco Regionale Napolitano o che
abbiano avuto un ruolo nelle vicende del Sud Italia.
|
|
 |
Famiglia Telesio |
|
A cura del dr. Giuseppe Pizzuti |
|
Arma: d’azzurro alla
fascia d’oro.
Dimore: Cosenza, Bonifati, Napoli e Trani.
Titoli:
patrizi di Cosenza, baroni di Castelfranco e Cerisano, baroni di
Malvito, baroni di Mottafollone e San Sosti, duchi di Toritto,
principi di Bonifati. |
|
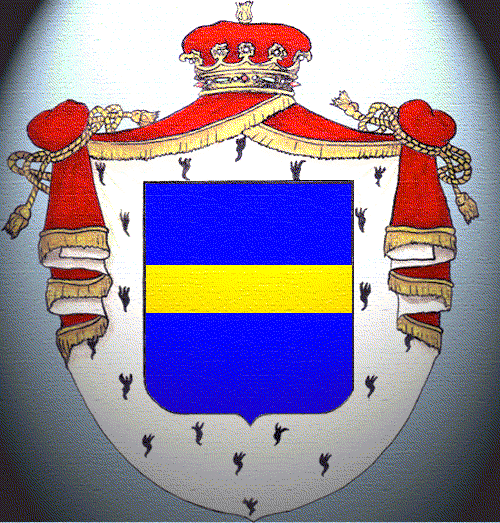
© Stemma famiglia Telesio |
|
Dalla semplicità dell’arma si evince che la famiglia Telesio ha
origini antichissime; le sue radici sono nell’antica città di Telese,
oggi denominata Aiello Calabro in provincia di Cosenza
(1),
più volte distrutta e ricostruita, dove possedevano terre da cui
presero il cognome. Si trasferì in Cosenza ove godette la nobiltà da
tempi remoti;
Telesino, ovvero
Ponzio
Telesio si mise a capo dei suoi concittadini cosentini e, con altri
valorosi Bruzii e Lucani mossero contro i romani per ottenere "il
civis romanus", ovvero la cittadinanza romana della quale erano
stati esclusi i popoli italici e denominata guerra sociale che si
svolse tra il 91 e l'88 a.C.; erano ormai alle porte di Roma quando
sopraggiunse Silla e li sconfisse, morirono in cinquantamila, tra di
essi il comandante Telesino
(2).
Cajo
Tilesio, si portò a Roma nel 37 d.C. nel mentre regnava Caligola,
acquistò reputazione nella capitale, nel 41 partecipò alla congiura
ordita da Cassio Cherea, tribuno de' pretoriani, contro Caligola
(3).
Da un privilegio di Federico I re di Sicilia (poi imperatore come
Federico II di Svevia,
eletto nel 1211) del gennaio 1201, con il quale si concede
all'Abbazia di S. Adriano un territorio per pascolo, vi è nominato
Pietro Telesio
da Cosenza,
Ciambellano o Camerario del re
(4).
Guglielmo,
cavaliere, fu
signore di
Sant'Angelo e Seminara, a
confermarlo è un istrumento del 9 settembre 1259 stipulato a
Seminara, notaio Palmerio de Ugone da Seminara, con il quale
Guglielmo, signore di Seminara, concede al Monastero di S. Caterina
un terreno nel casale di Palmi in territorio di Seminara.
Roberto,
che fu creato milite da re
Carlo I d'Angiò, con istrumento del 12 novembre 1254, notaio
Giovanni de Cancello, compra un grande territorio in località
Arvicello
(situato a Donnici Inferiore , oggi frazione del comune di Cosenza).
Rinaldo (o Raniero),
fu
feudatario di Pittarella (oggi frazione di
Pedivigliano in provincia di Cosenza).
Benedetto,
fu seguace di
re Corradino di Svevia.
Nicolò,
letterato, giureconsulto, giudice a contratto nel 1376, Consigliere
della
regina Giovanna I,
sposò donna Isolda
Carolei, ebbero per
figli: Adriano
Antonio, nel 1437 sposò Diamante De Copularis;
Filippo;
Pietro,
arcidiacono di Cassano nel 1419; ed
Antonio,
U. J. D., con privilegio della città di Cosenza del 1414 lo inviò
quale suo Ambasciatore e Sindaco a
re
Ladislao,
con privilegio del 1425 della
regina Giovanna II
d'Angiò-Durazzo e di
Luigi III d'Angiò-Valois [(1403 †
Cosenza, 15 novembre 1434), re titolare di Sicilia e successore
designato della regina di Napoli Giovanna
II che lo aveva investito del titolo di erede al trono, 9°
duca di Calabria, alla quale premorì] venne concesso al nobile
Antonio Telesio il
feudo Greca
(situato nella Sila Greca tra Acri e Rossano in provincia di
Cosenza), fu Consigliere di Luigi III d'Angiò-Valois, sposò Isolda
Relitta nel 1434 circa, ebbero per figli
Diana, ed
Adriano
(n. 1436), U. J. D., con privilegio di
re Alfonso I d'Aragona
venne confermato nel possesso del feudo di La Greca, sposato a Danta
Tignoso ebbero per figlio
Berardino
(† ante 1519), Capitano delle terre
di Laino e Orsomarso nel 1488, sposò Giovanna
Quattromani (poi suora) ed ebbero per figli
Giovanni,
Andreano,
ed Antonio
(Cosenza, 1482 † 1533)
(4 bis),
poeta e letterato, zio del filosofo Bernardino; eccelse come
latinista; dopo i primi rudimenti in Cosenza, volle accrescere i
suoi studi a Milano, probabilmente sulla scia del celebre latinista
cosentino
Aulo Giano Parrasio
(nome latinizzato
di Giovan Paolo Parisio) il quale aveva insegnato eloquenza nella
scuola palatina e da poco ritornato a Cosenza dove fonderà la
gloriosa Accademia Cosentina. |
|
 |
 |
|

Monografia su Antonio Telesio |
|
A Milano fu raggiunto dal giovinetto suo nipote Bernardino che lo
istruisce. Negli anni venti del Cinquecento lo troviamo a Roma
presso Clemente VII, successivamente fu chiamato a Venezia e Napoli,
nel 1533 fece ritorno a Cosenza. Le sue opere furono pubblicate dopo
molto tempo, nel 1772, da Francesco Daniele, sulla base dei
manoscritti conservati presso la biblioteca del nobile cosentino
Emilio
Giannuzzi Savelli, famiglia imparentata con i Telesio.
|

Tela raffigurante San Francesco di Paola; in basso gli
stemmi della famiglia Telesio e Maria Greco; commissionata
per la chiesa
dello Spirito Santo in Cosenza nella quale attualmente vi è
una copia, l'originale che quì presentiamo è esposta nella
sacrestia
della cattedrale di Cosenza.
Arma dei Maria Greco: d'azzurro al leone sostenente
con le branche anteriori un calice ed accompagnato in capo
da tre stelle
d'oro; alla fascia di rosso caricata da tre stelle d'oro
(5). |
Andreano (o Adriano),
sposò Gerolama (Stocco?)
con la quale generarono
Giulia,
sposata a Giulio Arduini nel 1517 circa, e
Giovanni Battista
(† ante 1565), nel 1518 sposò Gerolama Bufardo ed ebbero per figli:
Ascanio;
Giovannella,
sposata in prime nozze ad Andrea de Malito, in seconde nozze a
Giacomo Jannoccaro;
Francesco
(† 1598), sposato nel 1565 a Lucrezia
Arnoni,
eletto nobile di Cosenza nel 1590;
Lucrezia;
e
Marzio o Bernabò
(† 1586), sposato ad Olimpia
Caputo ebbero per
figli:
Girolama
(n. 1578);
Gio: Battista
(n. 1579);
Fulvio
(n. 1581);
Cesare Agostino
(n. 1581);
Lucrezia
(n. 1583);
Isabella
(† 1637), monaca;
Eliadora,
sposata nel 1593 a Muzio
Bombini.
Giovanni,
fratello dei citati Antonio ed Andreano, nel 1508 sposò la
nobildonna cosentina Vincenza
Garofalo, da questo matrimonio nacquero otto figli al primo dei
quali, nato l'anno seguente, fu imposto il nome del nonno paterno
Bernardino,
gli altri fratelli furono:
Girolamo,
chierico, dal 1537 rettore della chiesa di S. Giorgio di Zumpano;
Tommaso;
Giovanni
Andrea,
chierico, probabilmente si trasferì a Taverna in quanto da un atto
notarile dell'11 maggio 1556 risulta che lo stesso da Taverna nomina
suo procuratore il magnifico Giovanni
Monaco da Cosenza,
dimorante in Napoli, per rappresentarlo in un processo devoluto
della Regia Udienza di Cosenza alla Gran Corte della Vicaria (ASCS,
Not. 45, 4, 473);
Paolo;
e Valerio;
le sorelle furono:
Francesca,
nel 1536 sposò Gio. Battista Caputo;
Giovannella
(†
1570),
sposò in prime nozze Mario
di Gaeta ed ebbero per figlio Filippo, in seconde nozze,
nel 1560, sposò Scipione
Spadafora.
Bernardino
(1509 † 1588), Sindaco dei Nobili di Cosenza nel 1554, come risulta
dall'istrumento del 25 novembre dello stesso anno per il giuramento
di
ligio omaggio
prestato a
re Filippo II d'Asburgo-Spagna
da tutti i Baroni, Città, Castelli e luoghi demaniali e dai regi
Castellani della provincia di
Calabria Citra (ASCS,
Not. 28, 14, 598), per la città di Cosenza figurano Bernardino
Telesio ed Alfonso della Valle come Sindaci ordinari per l'anno
corrente della XIII indizione. Fu un grande filosofo e matematico,
studiò prima a Padova e poi a Napoli dove si stabilì e pubblicò, nel
1565, i primi due volumi dell'opera
De rerum natura iuxta propria
principia
e nel 1586 i restanti sette libri; sposò Diana
Sersale, vedova con due figli di Antonio
de Matera, dalla loro unione nacquero quattro figli:
Prospero
(n. 1553), venne ucciso all'età di 23 anni tra febbraio e marzo del
1576 per mano di Nicola Maria Carnevale;
Anna
(1555 † 1598),
sposò Geronimo
Scaglione;
Vincenza
(1556 † ante
1561); ed
Antonio
(1554 † 1592),
sposato a Cinzia
Firrao ebbero per figli:
Zenobia
(n. 1590);
Maria
(n.1588);
Tommaso
(1585), chierico;
Diana;
Maria
(n. 1582); e
Bernardino
(n. 1591), sposato a
Barbara
Telesio generarono
Giustina
(n. 1635);
Antonio Tommaso
(n. 1634); e
Giovanni Antonio
(1623 † 1633) (4ter).
Bernardino fu ospite di Alfonso
Carafa della Stadera 3° duca di Nocera e di sua moglie Giovanna
Castriota, marchesa di Città Sant'Angelo; vi soggiornò per
lunghi periodi, fu precettore del loro primogenito e futuro 4° duca
di Nocera Ferdinando (o Ferrante); i duchi amavano la letteratura e
l'arte e in questo clima Bernardino trovò la giusta concentrazione
nella stesura della sua grande opera che dedicò a Ferrante, scrisse
un carme lirico eroico dedicato alla duchessa Giovanna Castriota in
lingua latina composto in esametri. Regalò la sua opera
all’Accademia Cosentina che, dopo la sua morte, prese il nome
Telesiana. Il lavoro di Bernardino ha un grande valore storico
perché diede l’avvio a considerare la scienza della natura come
conoscenza autonoma.
|
|
 |
 |
|
In una cartolina commemorativa,
realizzata nel 1910 in occasione del IV centenario dalla sua
nascita, si nota al centro la scritta in latino che riprende la
definizione del filosofo Francesco Bacone (1561
†
1626), con la quale
afferma che Bernardino è da considerarsi il “Primo dei Nuovi”ovvero
il primo pensatore moderno; in basso è ripreso il suo autografo
apposto nei capitoli matrimoniali in vista delle nozze di sua
figlia, donna Anna con Geronimo (o Girolamo)
Scaglione,
nobile dei baroni di Pittarella, avvenute nel 1579. |
|
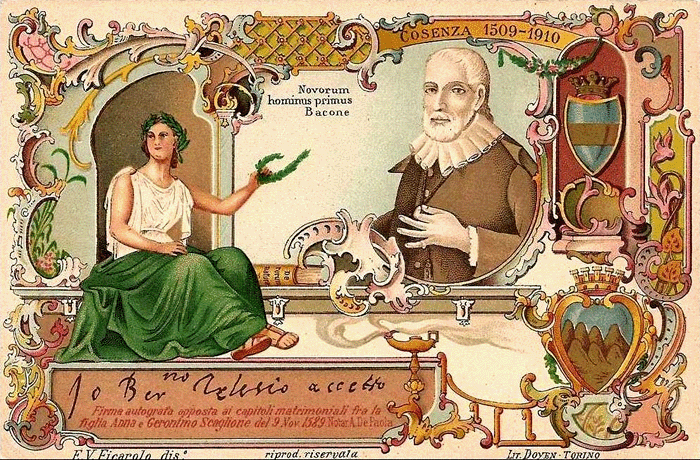
Cartolina commemorativa realizzata
nel 1910 - Per gentile concessione del dr. Giuseppe Pizzuti |
|
 |

Rivista stampata a Cosenza dal
tipografo Raffaele Riccio
nel 1914 per celebrare la nascita del filosofo Bernardino |
|
Tommaso,
fratello del citato Bernardino, fu Arcivescovo di Cosenza dal 1565
al 1568; carica proposta inizialmente da papa Pio IV a Bernardino,
il quale preso dai suoi studi indicò il fratello affermando che ne
fosse più meritevole; il fratello
Paolo, fu
vicario generale della curia durante il vescovato di Tommaso.
Valerio,
Iuris Utriusque Doctor,
signore di Varapodio, comprò da Eleonora
Sanseverino il
feudo di
Cerisano e Castelfranco (oggi Castrolibero) comuni
limitrofi a Cosenza; fu ucciso il 10 agosto del 1579 nella chiesa di
San Giovanni di Castelfranco per una rivolta dei propri vassalli;
aveva sposato Giulia
Ruffo figlia di Antonino da Terranova di
Calabria Ultra, dei
conti di Sinopoli, i capitoli matrimoniali furono stipulati il 6
dicembre 1548 per notaio Salvatore Gallo da Terranova, con una dote
di 2.400 ducati, ebbero per figli:
Vittoria,
sposata in prime nozze a Pietro
Cavalcanti nel 1586,
in seconde nozze, nel 1593, a Lucio Cavalcanti;
Clarice, sposata in prime nozze a Scipione Barone,
in seconde nozze ad Orazio
Sersale;
Urania,
monaca in Santa Maria delle Vergini;
Fabrizio, sacerdote, decano del Capitolo cosentino;
Marco Antonio,
letterato, Rettore della Confraternita della Concezione della B.
Maria della città di Cosenza;
Maurizio o Marzio,
Mastro Giurato nel 1578-1579, elevato a Cavaliere di Malta;
Orazio, (il suo ramo sarà descritto successivamente
dal quale discendono i Telesio odierni); e |
|
 |
 |
|
Cosenza, Chiesa del
Santissimo Salvatore, costruita dall'Arcivescovo Tommaso
Telesio nel 1567, esterno ed interno. |
|
Roberto
(† 1614), alla morte del padre Valerio ereditò il feudo di
Castelfranco e Cerisano, a causa delle persistenti ostilità in
Castelfranco decise di vendere il feudo ad Orazio
Sersale per ducati 33.600 con Regio
Assenso del 1580. Comprò la
terra di Mottafollone e San Sosti lo stesso anno
della sua morte da Lelio Caputo divenendone il
1° barone,
il Regio Assenso fu emesso dopo la sua morte nel 1616. Nel 1584
aveva sposato Genua Cavalcanti
figlia di Ippolito barone di Castiglioncello e Peritano, ebbero per
figli: Antonia
(1586 † 1642), sposata a Camillo Cavalcanti;
Giulia (n. 1589), monaca, dal 1618 badessa di Santa
Maria delle Vergini di Cosenza;
Valerio
(n. 1599);
Giovannella;
Urania
(1594 † 1675), sposata a Francesco
Passalacqua;
Lucrezia,
monaca; e
Muzio
(1599 † 1672), patrizio di Cosenza, 2° barone di Mottafollone, sposò
Isabella de Gregorio († 1676) figlia di Giovan Giacomo, la quale gli
portò in dote il
feudo di
Bonifati (acquistato dal nonno Valerio de Gregorio
per 18.000 ducati dal curatore del patrimonio del principe di
Bisignano) sul quale, nel 1640, ottenne il titolo di principe dal
re
Filippo IV; nel 1643 c.a comprò il feudo di Sant'Agata
(acquistato precedentemente dai Firrao da Tommaso Maiorana, marchese
di Sangineto, a questo evento seguì un provvedimento regio col
quale si dichiarava estinto il titolo di principe su questa terra in
quanto legato ai Firrao); nel 1647 lo vendette a Tommaso
Firrao il quale riotterrà il titolo di principe da Filippo IV.
Muzio ed Isabella ebbero per figli:
Valerio,
Commendatore del S.M.O. di Malta, ammesso nel 1651;
Bernardino; e |
|
.gif) |
.gif) |
|
Bonifati (CS). A destra:Sant'Agata d'Esaro (CS) |
|
Roberto (1631 † 1677), patrizio di Cosenza, 3° barone di Mottafollone, 2°
principe di Bonifati, figlio di Muzio, ereditò da sua madre Isabella
de Gregorio Telesio la terra di Bonifati con bagliva, mastrodattia,
dogana e scannaggio; sposò Giulia Cavalcanti dei baroni di Verbicaro,
ebbero per figli: Muzio; Domenico; Francesco,
Cavaliere di Malta, ammesso nel 1662; Giovan
Battista; Antonio; Nicola; Saverio e Giacomo,
patrizio di Cosenza, 4° barone di Mottafollone e San Sosti, 3°
principe di Bonifati, ebbe significatoria di relevio per le terre il
24 ottobre 1680, sposò Anna Ametrano figlia
di Antonio, duca di San Donato (oggi San Donato di Ninea), ebbero
per figli: Giulia, sposata il 6 gennaio 1710 a Francesco
Saverio
Sambiase, figlio di Paolo, 1° duca di Malvito e di Anna
Dattilo; e
Roberto (†
Cosenza, 26 luglio 1757), 4° principe di Bonifati etc..., si intesto
le terre il 14 gennaio 1707, sposò Lavinia
Tranfo, figlia di
Domenico e di Laura Tranfo, 2^ principessa di Cosoleto, non ebbero
prole.
Il feudo di Bonifati fu acquistato da Cosma Antonia
Caracciolo, duchessa di Celenza, con le seconde e terze cause, portulania e
zecca, per vendita fatta all'asta nel
Sacro Regio Consiglio, contro il patrimonio del
principe di Bonifati Roberto Telesio, e successiva rinuncia in
favore di Elisabetta Van Den Eynden, vedova di Carlo
Carafa, principe di Belvedere, con Regio Assenso del 31 maggio 1740,
registrato nel Quinternione 268, f. 1; e con la clausola che il
titolo di principe esistente sulla terra di Bonifati dovesse
rimanere estinto. Con Regio Rescritto del 16 maggio 1853 il titolo
di principe di Bonifati fu riconosciuto a Giuseppe Sambiase, 6° duca
di Malvito.
Ritornando ad
Orazio
(figlio di Valerio e di Giulia Ruffo), nel mese di novembre del 1601
inviò assieme ai rappresentanti della città di Cosenza al cardinale
Agostino Valier, prefetto della Congregazione dell'Indice, affinchè
si facesse promotore presso la Congregazione per istituire una
commissione con lo scopo di operare una revisione dei libri
incriminati a suo zio, il filosofo Bernardino (alcuni scritti erano
stati inseriti nell'edizione dell'Index del 1596 a pagina 26) ma,
nonostante l'istituzione della commissione gli scritti non furono
tolti dall'indice nel quale vennero reinseriti in tutte le edizioni
successive, solo nell'edizione pubblicata nell'anno 1900 sotto il
pontificato di Leone XIII non saranno presenti nonostante non ci
fosse un decreto di riabilitazione, la quale, fu tacita da parte
della Chiesa.
Aveva sposato in prime nozze Auria
Ciaccio con la quale
generarono
Lucrezia
e Maria,
in seconde nozze, nel 1595, sposò Giustina Cavalcanti ed ebbero per
figli:
Valerio
(n. 1616), battezzato il 13 giugno dello stesso anno, ebbe per
padrino Cesare Firrao, principe di Sant'Agata, e per madrina
Isabella d'Aloe moglie di Maurizio Cavalcanti, fu ammesso nei
Cavalieri di Malta nel 1634;
Giulia
(1603 † 1653);
Felice
(1599 † 1680), sposata a Scipione
de Matera;
Tommaso;
Orazio,
Sindaco dei Nobili di Cosenza nel 1617; e
Bernardino
(† 1633),
acquistò per ducati 38.000 la
baronia di Malvito
da Laudomia de Paola, baronessa di Buonvicino e Malvito con Regio
Assenso del 25 febbraio 1650; per gelosia di stato uccise suo
fratello Valerio, per questo delitto fu costretto ad allontanarsi da
Cosenza, morì Roma; i suoi figli (citati di seguito) vendettero il
feudo di Malvito con le seconde e terze cause, portulanìa e zecca a
Giovanni
de Cardenas, U.J.D., per ducati 27.000 con Regio Assenso del 18
aprile 1667 registrato nel Quinternione 121, f. 207.
Bernardino aveva sposato Virginia Muti ed ebbero per figli:
Ignazio
(n. 1646);
Domenico
(1640 † 1666); e
Pietro
(n. 1639), sposò
Cassandra
Caselli, e generarono:
Francesco Saverio,
Antonio,
Carmine
e Giovanni
(Gustavo Valente
lo riporta come Giuseppe),
quest'ultimi due morirono
calpestati
nel 1704 durante la rappresentazione d'una commedia
che si fece
nell'appartamento sottano alle case della famiglia
Badolato,
in quanto il governo di Napoli non prevedeva di presentare alcuna
garanzia per l'incolumità degli spettatori, quando gli spettacoli
erano privati, che restavano esposti a tutto loro danno senza
responsabilità di nessuno.
Francesco Saverio sposò Belluccia Sambiase,
di Antonio ed Innocenza de Filippis dei baroni di Carfizzi, ebbero
per figli:
Francesco Saverio;
Pietro,
ed il primogenito
Giovan Battista,
che sposò in prime nozze donna di casa Sambiase del ramo di Ignazio,
non ebbero prole, in seconde nozze sposò donna di casa Cavalcanti,
che gli diede:
Pietro Michele
ed il primogenito
Francesco Saverio,
il quale ebbe per figlio
Giovan Battista
che a sua volta ebbe
Francesco.
Orazio
(n. 1652), figlio
del citato Bernardino e fratello
d'Ignazio, Domenico e Pietro, fu
eletto tra i Nobili del Sedile di Cosenza nel 1696, dal 1694 al 1706
ricoprì l'ufficio di Partitario dell'Università (oggi comune) di San
Pietro in Guarano (curava l'amministrazione finanziaria, il servizio
veniva appaltato in un'apposita riunione del Parlamento, oggi
consiglio comunale, attraverso un'asta col sistema delle offerte
pubbliche ad alta voce, per la durata di un anno, l'altro servizio
che veniva appaltato era l'ufficio di Esattore), il Partitario
s'impegnava a pagare a tempo debito i mandati firmati dal sindaco e
le somme dovute alla Regia Corte. Sposò Nonna Cavalcanti dei baroni
di Torano, e generarono:
Ignazio
e Tommaso,
canonici a Cosenza;
Nicola;
Domenico;
Giuseppe Maria
ed Antonio.
|
|
 |
 |
|
Uno dei tanti elogi a Fabrizio
Castiglione Morelli.
A destra: Corigliano, stemma Sollazzo Castriota.
Si
ringrazia il
Prof. Giovanni Scorzafave per averci inviato la foto. |
|
Paterno Calabro (Cosenza), Santuario, lapide. A destra:
Paterno Calabro, Santuario di San Francesco di Paola del 1444 |
|
Il citato Antonio sposò Corinda Spiriti,
ebbe delle figlie femmine le quali presero i voti tranne Chiara che
sposò Edoardo Giannuzzi Savelli, barone di Pietramala; per figli
maschi ebbe: Raffaele; Vincenzo (1728
† 1802) filantropo, è ricordato per aver alleviato con opere di
beneficenza i danneggiati dal terremoto del 1783 in Calabria e
durante la guerra della Repubblica
Napoletana del 1799, più volte eletto amministratore
dell'Ospedale Civile di Cosenza, fondò un orfanotrofio nell’ex
monastero dei Teresiani; Orazio; Domenico; Giuseppe; Valerio,
sposato con Nicoletta Sambiase, figlia di Luigi, ebbe come figli: Orazio; ed Antonio,
sposato con Maria Antonia Ventura
ebbe come figli: Nicoletta (†Cosenza, 5
giugno 1856 all'età di 76 anni), sposata con Francesco Bombini; Valerio; Luigi (1770
† 1845), conseguiti i primi studi a Cosenza, li proseguì a Napoli,
dove maturò la sua vocazione religiosa ed entrò nella Congregazione
dell'Oratorio di Napoli, successivamente venne prescelto come
maestro di filosofia nel Regio Liceo del Salvatore ma rifiutò, fu
scrittore in latino ed autore di diverse opere letterarie (6);
Tommaso ed Orazio,
benedettini in Napoli, furono ardenti repubblicani del 1799,
cooperarono per l'ingresso dei Francesi a Napoli e subito dopo si
recarono nella loro città natale di Cosenza per propugnare i valori
repubblican, caduta la Repubblica furono arrestati e riportati a
Napoli e, nelle fosse de' Granili e della Vicaria furono torturati (7); Giovanni; Fortunato,
sposato a Giuseppina Roger di Francesco e Brigitta Mauro Toscano,
ebbe un figlio di nome Francesco;
e Bernardino (†
Cosenza, 18 agosto 1839 all'età di 70 anni), sposato il 6 giugno
1802 con Teresa Ferrari, figlia di Gaetano, barone di Roseto, e d'Ignazia
d'Amato dei patrizi di Amantea, ebbe come figli: Gaetano; Valerio (n.
1806); Vincenzo (1805
† 1849) sposato con Berenice Colucci-Latilla ebbe per figlia Antonietta che
sposerà suo cugino Bernardino Francesco Maria (1821 †
1863); ed Antonio (1804
†1878), sposato con Isabella Sollazzo Castriota (1802
† 1864) di Corigliano Calabro, figlia di Baldassarre e di Maria
Antonia Messia
de Prado, sorella del botanico Domenico Sollazzo, ebbe per
figli: Maria (n. Cosenza 1841); Maria Teresa Francesca
Filomena (1836 † 1890), sposata a Pasquale Abbati; Maria
Filomena (1835 † 1873), sposata al barone Luigi Lupinacci; Giuseppe
Maria Costantino (n. Cosenza, 1834); Alfonso
Maria Francesco (n. Cosenza, 1832); Giuseppe
Michele Francesco (n. Cosenza, 1831); Marianna
Elisabetta (n. Cosenza 1828); Filippina Maria (n.
Cosenza, 1827); Maria Teresa (n. Cosenza, 1824); Baldassarre
Maurizio Francesco (1822 † 1883); ed il
primogenito Bernardino Francesco
Maria (1821 † 1863), sposato in prime nozze con sua cugina Antonietta Telesio
(1829 † 1852), ebbe come figli: Teresa (n.
1851), sposata il 6 giugno 1868 a Vito dell'Erba; Filomena (n.
1850), sposata il 28 dicembre 1868 ad Antonio Sgobba; Giovanna
(1845 † 1862); e Vincenzo (1846
† 1917), sposato a Beatrice Antonacci, padre di Bernardino (1869
† 1949) il quale diede origine al ramo dei duchi di Toritto
sposando donna Enrichetta Caravita,
dal 1889 5^ duchessa di Toritto, con Decreto Ministeriale del 1899
il titolo venne confermato ed autorizzata la successione ai figli
(di questo ramo seguirà descrizione).
In seconde nozze Bernardino Francesco Maria (1821 †
1863) sposò Filomena Cenci ed ebbe come figlia Rosaria (n.
19 maggio 1854).
Figlio secondogenito di Antonio ed Isabella Sollazzo Castriota fu Baldassarre
Maurizio Francesco (1822 † 1883), sposato in prime
nozze, a Cosenza il 7 maggio 1746, con Vincenza Passalacqua (†
Paola, 26 luglio 1851), ebbe come figli: Antonio
Maria Francesco Alfonso (Cosenza, 1847 † ivi,
1912); Maria
Carolina detta Marietta (Cosenza, 7 giugno 1849 †
1913), il 12 ottobre 1871 sposata con Francesco Ricciulli di
Rogliano. |
|

Vincenzo Telesio (1728 † 1802).
Immagine tratta da: https://catalogo.beniculturali.it. |
|
.gif)
Teresa Telesio (1836 † 1890), di Antonio ed Isabella
Sollazzi Castriota, sposata a Pasquale Abbati
Archivio
Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona |
|
Baldassarre Telesio (1822 † 1883) e
Vincenza Passalacqua, prima moglie di
Baldassarre Telesio
Archivio
Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona |
|
Antonio Telesio di Baldassarre e
Vincenza Passalacqua. A destra: Bernardino Telesio di Filippo e Irene
Passalacqua
Archivio
Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona |
|
Baldassarre Maurizio Francesco (1822
† 1883) in
seconde nozze sposò Antonia Albani (1834
† 1900), ebbe come figli: Maria Anna Francesca Giuseppa
(n. Cosenza, 4 agosto 1863); Alfonso Maria Francesco Salvatore (n.
Cosenza, 3 luglio 1860); Isabella Maria Carmela (n. Cosenza,
10 luglio 1857); ed il primogenito Filippo Carlo Giuseppe
Francesco (Cosenza, 10 luglio 1856 † 1920), maggiore di
cavalleria nella riserva, sindaco di Cosenza dal 1° maggio 1904 al
24 luglio 1906, nel 1890 sposato con Irene Passalacqua (1868
† 1937) ebbe
come figli: Baldassarre (n. Cosenza, 23 marzo 1891); Bernardino (Cosenza,
18 marzo 1892 † 1915), caduto in guerra il 2 novembre del 1915 nella
battaglia dell'Isonzo; Maurizio (27 giugno 1893 † 1928); Antonietta (14
luglio 1894 † 1931); Guglielmo (9 luglio 1895 † 1924),
tenente d'aviazione, prigioniero di guerra e deportato in Austria,
morì nei cieli di Novara presso l'aeroporto di Cameri; Roberto (1897
† 1970), sposato a Maria Magliari (1900 † 1991); Luigi (13
agosto 1901 † 1958); Francesco (22 maggio 1907 † 1947),
sposato ad Anna Passalacqua ha avuto per figlia Irene (n.
1945), sposata a Paolo Pratesi. Su richiesta dei coniugi Paolo
Pratesi ed Irene Telesio, ai figli Roberto (n. Firenze, 17 gennaio
1974), e Francesco (n. Firenze, 12 giugno 1977), è stato concesso,
con decreto presidenziale del 6 aprile 1987, di poter aggiungere al
proprio cognome Pratesi anche quello della madre Telesio. Il
primogenito Roberto Pratesi Telesio è deceduto a Firenze il
6 aprile 2011 senza prole; Francesco Pratesi Telesio ha
sposato Enrica Bolognesi e dalla loro unione sono nati, a Firenze, Linda il
3 agosto 2010, e Luca il 30 dicembre 2016. |
|
 |
 |
|
Filippo Telesio,
patrizio di Cosenza, e la consorte Irene nobile dei baroni
Passalacqua.
Dall'esposizione permanente presso la Casa delle Culture di Cosenza.
Archivio Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona |
|

Casino Telesio in Contrada Feudo Telesio ricadente
nel comune di Castrolibero nel circondario di Cosenza,
a sinistra Antonia, nata Albani, a destra la penultima Irene, nata
Passalacqua e Carolina.
Dall'esposizione permanente presso la Casa delle Culture di Cosenza
Archivio Roberto Bilotti Ruggi
d'Aragona |
|

La famiglia Telesio, al centro Antonia, nata Albani
seconda moglie di Baldassarre Telesio
Dall'esposizione permanente presso la Casa delle Culture di Cosenza
Archivio Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona |
|

Bernardino Telesio (di Filippo e
Irene Passalacqua) - tenuta Feudo
Per gentile concessione del nobile Roberto
Bilotti Ruggi d'Aragona |
|
Irene
Telesio nata Passalacqua, in abiti tradizionali
Dall'esposizione permanente presso la Casa delle Culture di Cosenza
Archivio Roberto
Bilotti Ruggi d'Aragona |
|

Irene Telesio e Roberto Bilotti Ruggi
d'Aragona |
|
Ramo
dei duchi di Toritto |
|
Nel centro di Trani vi è il monumentale palazzo Antonacci – Telesio.
La costruzione del palazzo, che presenta una facciata neoclassica
della metà dell’800, si può collocare ai primi dell’800, dopo che un
numero di case appartenenti alla famiglia Antonacci vennero date
alle fiamme durante
i
moti del 1799. Il nuovo palazzo, costruito sul sito delle
case distrutte, si appoggiava alle mura di cinta federiciane di
Trani ed era perciò non molto profondo rispetto alle dimensioni
della facciata. Quando nel 1845 le mura vennero abbattute per
ampliare la città, Giuseppe Antonacci (Trani, 4/7/1810
†
Castellammare di Stabia, 20/9/1877, poi nominato Senatore del Regno
dal 1863 fino alla sua morte nel 1877) diede incarico all’architetto
Luigi Castellucci di estendere il palazzo sul retro fino alla nuova
Via Cavour e di adeguare la facciata su piazza Quercia allo stile
neoclassico. |
|

Trani (BT), Palazzo
Telesio
Per gentile concessione del Dr. Piero
Telesio di Toritto. |

Trani (BT), Palazzo
Telesio,ingresso
Per gentile concessione del Dr. Piero
Telesio di Toritto. |
|
La data del 1761 viene riportata su vari siti come l’anno di
costruzione del palazzo, ma così non è. L’equivoco sorge perché
nell’androne del palazzo si trova uno stemma in pietra della
famiglia Antonacci che porta la data del 1761. Però questo stemma fu
messo lì, da Vincenzo Telesio, negli anni ’50, trasferendolo da
un palazzotto confinate, pure di proprietà. |
|
Trani (BT), Palazzo Antonacci Telesio, stemma
Telesio. A destra: Trani (BT), Palazzo Antonacci Telesio, stemma
Antonacci
Per gentile concessione del Dr. Piero Telesio di Toritto |
|
La famiglia Antonacci innalzava l'arma:
troncato, nel primo d'argento alla croce di rosso; nel
secondo di verde al leone d'argento.
Il senatore Giuseppe Antonacci sposò in Napoli la
nobildonna Chiara della Valle dei Marchesi di Casanova.
|
Scalone
con in alto, tra i due finestroni con affaccio
su
Via Cavour, lo stemma Antonacci in marmo. A
destra:
Trani (BT), Palazzo Antonacci Telesio,
stemma
Antonacci e della Valle |
|
Trani, anticche
foto dell'interno di Palazzo Antonacci - Telesio |
Il palazzo e gli attigui fabbricati furono acquisiti dai
Telesio in parte per acquisto e, per la rimanente parte,
in eredità a seguito di matrimonio celebrato tra
Vincenzo Telesio (Napoli, 17/7/1846
†
2/7/1917), patrizio di Cosenza, e Beatrice Antonacci (†
Napoli, 19/8/1898), figlia del Senatore Giuseppe
(8);
entrambi riposano in pace nella cappella gentilizia
Telesio al cimitero di Poggio Reale a Napoli. |
|
 |
 |
|
Albero genealogico della famiglia Telesio con gli
stemmi della famiglia e di Cosenza. A destra:
Vincenzo Telesio
(1846
†
1917),
marito di Beatrice Antonacci |
|
Ritratti di donna
Beatrice Antonacci, moglie del nobile Vincenzo Telesio |
|
 |

Museo delle Carrozze Telesio a Trani
|
|
Bernardino Telesio (Napoli, 4/8/1869
†
Trani, 16/11/1949), qui trasferitosi da Napoli durante l’ultima
guerra, poco dopo aver compito 80 anni di età, figlio di Vincenzo e
di Beatrice Antonacci, patrizio di Cosenza, duca di Toritto per
maritali nomime, a seguito di matrimonio celebrato a Napoli il
6/6/1892 con donna Enrichetta
Caravita
(Napoli, 7/9/1871
†
Trani, 10/2/1960), duchessa di Toritto, figlia ed erede di Giuseppe
(1824
†
1889) 4° duca di Toritto e di donna Maria
d’Aquino dei
principi di Caramanico. Succedettero al titolo ducale portato da
Enrica Caravita suo figlio Vincenzo, poi il figlio di
Vincenzo, Bernardino, ed infine il figlio di quest’ultimo,
Maurizio (n. a Roma, 4/2/1950). |
|
Napoli, galoppatoio di
Villa Comunale, Bernardino Telesio,
duca
di Toritto. Foto del 1900. A destra: Napoli, la
duchessa
Enrichetta Caravita, moglie di Bernardino,
in carrozza alla Riviera di Chiaia |
|
Il Palazzo di Trani ospita il Museo delle Carrozze che
fu costruito nei primi anni del 1950 da Vincenzo
Telesio (Napoli, 11/9/1893
†
Roma, 16/2/1968), figlio di Bernardino e di Enrica
Caravita, 6° duca di Toritto, colonnello di Cavalleria,
abile e grande appassionato di cavali e carrozze. |
|

Trani, interno giardino
Antonacci - Telesio, alla guida di una Lorraine-Dietrich
de Luneville
il duca Vincenzo Telesio
(1893
†
1968), all'età di 21, abilitato alla guida, con la
famiglia. Anno 1914. |
|

Vincenzo
Telesio (Napoli, 11/9/1893 † Roma, 16/2/1968), figlio di Bernardino
e di Enrica Caravita, 6° duca di Toritto,
colonnello di Cavalleria, in uniforme. |
|
Bernardino (Napoli, 13/4/1922
†
Roma, 2/10/1992), 7° duca di Toritto, figlio del citato Vincenzo,
curò il museo sino alla sua morte nel 1922; fu avvocato della Sacra
Romana Rota.
Beatrice Telesio (Napoli, 27/12/1894
†
Breganzona, 24/10/1970), figlia di Bernardino (1869
†
1949) e sorella di Vincenzo
(1893 † 1968), sposò nel 1916
Alfredo Reichlin, di una famiglia dell’alta e benestante borghesia
napoletana di origine svizzera, insediata a Napoli da varie
generazioni. Alfredo cambiò il cognome in Reichlin Kraft onde
evitare ogni confusione con il cugino, anche lui Alfredo Reichlin e
alto esponente del Partito Comunista, un tempo direttore dell’Unità. |
|

Napoli, museo del Maschio Angioino,
busto di Beatrice Telesio,
moglie di Alfredo Reichlin. |

Foto di Beatrice Telesio,
da giovane |
|
Giuseppe Telesio (Napoli, 2/7/1896
†
Terracina, 8/7/1969), patrizio di Cosenza, figlio
secondogenito di Bernardino e di Enrica Caravita,
perseguì la carriera diplomatica fino al grado
d’ambasciatore; sposò nel 1941 Maria Francesca Grossi. |
|

Giuseppe Telesio (1896
†
1969), patrizio di Cosenza. |
|

Giuseppe Telesio (in piedi a destra nella foto),
allora capo dell’Ufficio Trattati del Ministero degli Affari Esteri
per la firma il 10
febbraio 1947 del Trattato di Parigi fra l'Italia e le potenze
alleate vincitrici della seconda guerra mondiale. A firmare il
trattato
fu l’ambasciatore marchese Antonio Meli Lupi di Soragna Tarasconi
(nella foto seduto al centro). |
|
_________________
Note:
1) - Altri
storici sostengono che le radici della famiglia Telesio sono da
ricercarsi in Figline, paese vicino Cosenza.
2)
- Riccardo Gilardi, "Il popolo cosentino e il suo territorio", pagg.
31-32. Pellegrini Editore, 2003. E' doveroso ricordare che altri
storici sostengono sia stato Sannita.
3) -
Eugenio Arnoni, "La Calabria illustrata Vol. III Cosenza", pag. 109.
Edizioni Orizzonti Meridionali, 1992.
4) -
Ponzio Telesino (ca. 88 a.C.) e Cajo Tilesio (ca. 37 a.C.) non si
possono ricollegare con certezza alla famiglia Telesio. Il
capostipite sicuro sarebbe piuttosto Pietro. Il prilegio è riportato
da Vincenzo Maria Egidi - Mario Borretti in "I Telesio Regesto dei
documenti del sec. XVI", a cura di Raffaele Borretti, pag. 146.
4bis) - Vincenzo Maria Egidi -
Mario Borretti, op. cit, pagg 12-13 e pag. 146.
4ter) – Ibidem.
5) -
L'individuazione e l'esatta attribuzione dello stemma
Maria Greco, finora travisato dalla storiogriafia locale, è di Luca
Irwin Fragale (si veda Microstoria e araldica di Calabria Citeriore
e di Cosenza. Da fonti documentarie inedite, Milano, Banca CARIME,
2016, pp. 297 e 173)
6) -
Eugenio Arnoni, "La Calabria illustrata Vol. III Cosenza", pagg.
147-148
Edizioni Orizzonti Meridionali, 1992.
7) - Op.
Cit. pag. 143.
8) -
Giuseppe Antonacci e Chiara della Valle ebbero tre
figlie: una, Beatrice, sposò Vincenzo Telesio, un’altra il Marchese
Cutinelli, e la terza il Conte Romano. Bernardino Telesio, pur
risiedendo stabilmente a Napoli, successivamente acquistò le quote
Cutinelli e Romano per integrare il palazzo.
_________________________
Bibliografia:
- Archivio privato del nobile Dr. Piero Telesio di Toritto.
- Mario Pellicano Castagna “Storia dei Feudi e dei
Titoli Nobiliari della Calabria” Vol. I, pagg.251-252, Vol.III
pag.80; Frama Sud. 1984.
- Luca Covino “Governare il feudo, quadri
territoriali, amministrazione, giustizia. Calabria Citra
(1650-1800)”, pag. 80; Franco Angeli editore, 2013.
- Luigi Palmieri “Cosenza e le sue famiglie
attraverso testi atti e manoscritti”,Voll.II; Pellegrini, 1999.
- Giovannino Engels “Bonifati un Principato di
Calabria Citra (Notizie Storiche)”; A.C. Grafiche, 1980.
- Vittorio Spreti “Enciclopedia storico-nobiliare
italiana”; Arnaldo Forni Editore.
- Francesco Bonazzi di Sannicandro“Famiglie nobili e
titolate del Napolitano”; Napoli 1902
- Frà Girolamo Sambiasi “Ragguaglio di Cosenza e di trent'una sue
famiglie nobili” - Napoli MDCXXXIX.
- Fabrizio Castiglione Morelli "De Patricia
Consentina Nobilitate Monimentorum Epitome”, Venezia 1713.
- Frà Bartolomeo dal Pozzo e Frà Roberto Solaro di
Govone “Ruolo generale dei Cavalieri Gerosolimitani della veneranda
lingua d' Italia”, pag 162; Torino 1715.
- Luigi de Franco “Introduzione a Bernardino Telesio”,
pagg. 54-55 e 77-78; Rubbettino, 1995.
- Documenti “Breve memoria per D.Giuseppe Catalani
Gonzaga”; Napoli 1771.
- L’esplorazione botanica in Calabria nell’ottocento
e la figura di Domenico Sollazzo Castriota (1810-1860). -
Corigliano
Calabro.
- Bartelli Francesco "Note biografiche: Bernardino
Telesio, Galeazzo di Tarsia"; Trippa, 1906.
- AA.VV. "MILLE ANNI DI STORIA" (col patrocinio dell'Amministrazione
Comunale di San Pietro in Guarano), CIC EDIZIONI INTERNAZIONALI -
ROMA 1999.
- Gustavo Valente, “Storia della Calabria nell'età
moderna”, Vol. II, Frama Sud 1980.
-
Libro d'Oro della Nobiltà Mediterranea.
- L'Araldo "Almanacco Nobiliare del Napolitano 1914",
Enrico Detken, libraio editore, Napoli
1914.
-https://www.storiadigitale.it/portale-della-storia-degli-italiani/#:~:text=realizza%20la%20duplice%20finalit%C3%A0%20di,%2C%20
Archivi%20parrocchiali%2C%20Archivi%20diocesan |
|