|
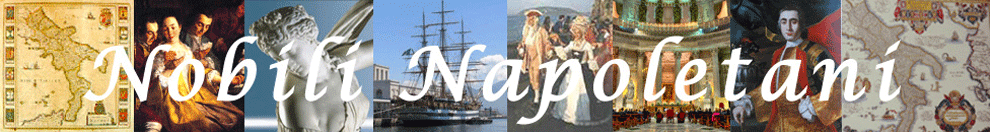
Ovvero delle Famiglie
Nobili e titolate del Napolitano, ascritte ai Sedili
di Napoli, al Libro d'Oro Napolitano, appartenenti
alle Piazze delle città del Napolitano dichiarate
chiuse, all'Elenco Regionale Napolitano o che
abbiano avuto un ruolo nelle vicende del Sud Italia.
|
|
A cura del dr. Giuseppe Pizzuti |
|
Arma più
antica:
d'azzurro, al leone d'oro con la testa rivolta mirante una
stella (6) del medesimo posta nel secondo cantone.
Altra:
d'azzurro, all'albero sdradicato al naturale accompagnato a
sinistra da un leone d'oro affrontato al tronco, a destra da una
stella (6) dello stesso.
Altra:
d'azzurro, all'albero sdradicato al naturale fruttato di rosso
accostato da due leoni d'oro affrontati e controrampanti al
tronco
(1).
Altra:
d'azzurro, all'albero al naturale nodrito sopra un monte di tre
cime movente dalla punta accostato da due leoni d'oro
affrontati e controrampanti al tronco, col capo da una fascia
diminuita d'oro sostenente sette rose di rosso accompagnate da
una stella d'oro (5). Rinserrano lo scudo dal basso due fronde
di lauro poste in decusse con due crocette patenti.
Altra di
Sicilia:
d'oro, al grifo di verde linguato di rosso.
Titoli:
patrizio napoletano,
patrizio di Rossano,
nobile di Taverna,
nobile di Crotone,
barone di Ciriciglia,
barone di Unfiatico,
barone di Madama Callipo,
barone di Cerisicchia,
barone di Quartieri,
barone di Pantane,
barone di Cotura. |
|

Taverna, stemma Blasco |
|
La Famiglia
Blasco di origine Aragonese, ebbe come capostipite
Blasco Fernandez Velasco, figlio naturale di
Giovanni di Velasco,
signore di
Medina e di Pomar.
Fernandez passò in Sicilia sotto
re Pietro I d'Aragona (1282-1285)
nel 1282.
Enrico,
figlio di Fernandez, ottenne la
Castellania di Castroreale
e prese a nomarsi, secondo l'uso del luogo,
Enrico Blasco, suo figlio ebbe il nome di Blasco
Blasco, ed il nome restò come cognome di tutti i
posteri.
Pietro Antonio fu
Governatore di
Santa Lucia nel 1422.
In Sicilia ebbero il possesso di più feudi e l'esercizio
di vari uffici.
Dalla
Sicilia passarono in Calabria radicandosi a Taverna, in
Calabria Ultra,
nel cui territorio possedettero dei feudi,
successivamente si diramarono a Crotone e Rossano dove
godettero la nobiltà, e Reggio.
Riccardo
fu milite e servì
re Alfonso I
d'Aragona, il quale nel 1444, lo rimunerò con
i feudi di Ciriciglia
detto poi Donna Cubitosa,
Unfiatico,
e Madama Callipo
in territorio di Taverna, nel privilegio di concessione
venne appellato uomo
nobile.
Pedro,
fu dottore in legge nel 1536.
Pietro
e Galieno Blasco, vengono annoverati come
feudatari nei Cedolari per i feudi di Unfiatico e
di Donna Cubitosa. In alcune provvisioni della Camera di
Santa Chiara (ACS, Fondo Notarile, Atti di G.A.
Veraldi,
Taverna 25 giugno 1791, f. 46 ss) si apprende che nel
1549 il feudo Donna Cubitosa seu Ciriciglia era
posseduto da Marcantonio, Fredio, e
Petruccio Blasco, ciascuno per una terza parte. Dopo
due secoli, il 16 aprile 1740 Alfonso
Veraldi
s'intestò (Cedolario 84, f. 182 t) la terza parte
del feudo di Donna Cubitosa in Taverna, e
Cerisicchia, poi
denominato Fichicello,
presso Cosenza, che prima appartenevano a Marcantonio
Blasco, e ciò per transazione col Regio Fisco. |
|

Taverna, Palazzo Blasco,
portale con Stemmi |
|
Tornando alle origini, il citato Riccardo, fu
figlio di Baldassarre, ebbe per fratello
Michele, monaco cisterciense morto in Spagna nel
Monastero dei SS. Arcangeli. Riccardo, nel 1467 aveva
sposato Gusmana
Blanch,
ed ebbero per figli: Giacinta, sposata a Domenico
Schipani
di Catanzaro, e Giovanni, medico, che
sposando Ernesta Battiloro generarono Pietro e
Donato Vincenzo il quale ebbe per figli:
Franchisina; Mario; Sblandiano, ebbe
due figli Giulio e Lelio; e Grandonio,
medico, al quale Girolamo Madotto dedicò l'epigramma
Alcides postquan Ditis descendit ad ima.., ebbe per
figli Galeno, Orazio, e Nicola Antonio,
dottore in legge esercitò la professione di avvocato a
Napoli, si dedicò alla poesia, nel 1587 a Napoli
pubblicò Sylva memorabilium juris. Sposò
in prime nozze Porzia Susanna e non ebbero prole, in
seconde nozze Porzia
Capece,
dama napoletana, con la quale generarono Paolo,
sommo giureconsulto in Napoli.
Orazio,
fratello di Nicola Antonio, sposando Laura
Monizio ebbero per figlio Pietro Antonio che
sposò Belluccia Pantuso di Cosenza e generarono
Domenico, sposato con Antonia
Poerio
di Catanzaro ebbero per figli: Orazio,
diffinitore dei PP. Riformati; Antonio; e
Paolo, che con Caterina Marotta ebbero per per figli
Marcello, e Riccardo, sposato a Maria
Calabrese generarono: Ludovico, Michelangelo,
Giovan Battista (ebbero un fine funesto per un
fatto d'arme fazioso con i
Marincola
di Taverna), frà Antonio, Domenico, e
Paolo, il quale fu il primo che si portò a Rossano;
per volere del principe Nicola
Sanseverino
sposò Vittoria Foggia ed ebbero per figli: Francesco,
arcidiacono nella chiesa di Montalto (oggi Montalto
Uffugo); Orazio, Protonotario Apostolico;
Isabella, sposata a Nilo Crispaldi; Maria,
sposata ad Ottavio Colluccio; Ippolito Lucio o Lucio,
il quale fece ritorno a Taverna ed ivi sposò Elisabetta
Baratta ed ebbero per figlio Paolo che generò
Galeno, il quale generò Laumedia, sposata a
Paolo Schipani di Catanzaro, e Faustino, che con
Maria Elisabetta Poerio generarono Orazio,
Cavaliere
Gerosolimitano, Mario, e Giovan
Battista, la cui discendenza continuò a fiorire in
Taverna; e Cesare, il quale fece continuare la
sua discendenza in Rossano, fu poeta, i suoi
componimenti non ci sono pervenuti, sposò Giulia
Barricelli e non ebbero prole, in seconde nozze, nel
1606, sposò Lucrezia Amarelli ed ebbero per figli:
Domenico, sposato a Sigismina Seglia non ebbero
prole, e Carlo (Rossano, 13 dicembre 1635 †
ivi, 19 ottobre 1706), fatti i primi studi nel
Seminario di Rossano, approfondì a Napoli quelli di
lettere e filosofia. Entrato nella vita religiosa passò
a Roma ove conseguì, alla Sapienza, la laurea in legge,
esercitò la professione di avvocato, coltivò la poesia
ottenendo dei riconoscimenti tanto da essere nominato
socio dell'Accademia degli Umoristi. Papa
Alessandro VII gli conferì la Badia di Sant'Angelo
Mitilino, non stette molto nella carica, in quanto
sopravvenuta la morte del padre dovette far ritorno a
Rossano dove si dedicò anche alle attività culturali, fu
nominato socio dell'Accademia degli Spensierati,
della quale, alla morte di Francesco
de Lauro
fu chiamato a succedergli nella Presidenza. Olimpia
Aldobrandini, 3^ principessa di Rossano, lo pregò di
assumere la carica di erario generale, di vice
segretario e vice mastro portolano del fondaco della
città, cariche che gli vennero ampliate da Giovan
Battista
Borghese,
4° principe di Rossano, figlio ed erede della
principessa Olimpia, con quelle di soprintendente della
corte e con la facoltà di nominare Governatori e
Ministri.
Durante i
moti del 1647, Carlo con un gruppo di soldati da lui
condotti con Gian Battista Mannarino e dal notaio
Francesco Greco, dovettero portarsi nella marina di
Strongoli, colà chiamato dal Sindaco del paese. Una
notte, soggiornando nel Convento dei Cappuccini, ebbero
una brutta sorpresa, perchè la cittadina fu assaltata
dai pirati che riuscirono a penetrare nel Convento,
Carlo si salvò gettandosi da una finestra, mentre i suoi
due amici assieme ad un frate venivano presi e fatti
schiavi. Venduti poi al mercato, dopo tre anni di
cattività, per interessamento di Pirro Malena, che era
esule in Roma dopo il fallimento del moto di Rossano, a
mezzo di alcuni cardinali, certi mercanti veneziani
poterono riscattare il Mannarino che nel frattempo era
stato trasportato a Corfù. Il suo rientro in casa, però,
segnò la morte della madre, giacchè la signora, per la
gioia di rivederlo, venne fulminata da paralisi.
Dopo diciassette anni dovette lasciare le cariche in
quanto afflitto dalla podagra. Pubblicò: Opuscoli
canonici storici critici di Carlo Blasco dedicati
all'Em. Rev. Principe Giuseppe Cardinale Spinelli,
Vescovo di Palestrina e Prefetto della Sagra
Congregazione di Propaganda Fide - Napoli, Abbaziana,
1758-1761; Diatriba intorno alla Papessa Giovanna
- Napoli, 1777; Lettera al Signor Canonico D.
Salvatore Felucci, sull'origine, e progresso
dell'odierno probabilismo - 1779.
Lasciò dei manoscritti: Lagrime di Pindo, poesie,
in lode di illustri rossanesi scomparsi; Historie
della città di Rossano, etc. . |
|

Pubblicazione di Carlo
Blasco |
|

Ritratto di Carlo Blasco |
|
Essendo morto Domenico, l'unico suo fratello senza
lasciar prole, aveva ottenuto le dovute licenze per
passare a nozze, e nel 1671 sposò Fabrizia Laura
Berlingieri
di Crotone, sorella di Carlo, Arcivescovo di
Santa Severina, ed ebbero per figlia Francesca
sposata a Giuseppe
Labonia;
rimasto vedovo nel 1694 si risposò con Anna
Ajerbe d'Aragona
di Crotone, ed ebbero per figli: Teresa, Maria,
Agnese, Illuminata, monaca in Santa
Chiara, Carlo juniore († Rossano, 15
agosto 1797) nato postumo, dimorò molti anni a Roma,
teologo, celebre canonista, segretario della
congregazione dei vescovi, ebbe lunga corrispondenza con
papa Pio VI il quale gli offrì la nomina ad arcivescovo
di Rossano, ma rifiutò, non si riteneva degno del
sacerdozio, lasciò tutti i suoi averi ai poveri,
esecutore testamentario fu don Giuseppe Toscano, e
Domenico, oratore, sposò Lucia Ajerbe d'Aragona di
Crotone e non ebbero prole, in seconde nozze sposò
Marianna
Dattilo e
generarono: Anna e Teresa, gemelle,
sposarono rispettivamente Muzio
Montalto
e Giovan Battista della Cananea di Montalto; Maria,
sposata a Vincenzo
Bernaudo
di Montalto; Gabriella; Cesare, morì a
Napoli; ed Orazio il quale sposando Aurelia
Ferrari
ebbero per figli:
Marianna, sposata a Diego de Russis;
Teresa, sposata a Giuseppe Accattatis; e Domenico,
sposato a Rosanna Montalto generarono Sofia,
Carlo, ed Orazio. |
|

Sicilia, stemma Blasco |
|
I Blasco ed il Feudo di Riccio |
|
Feudo composto da due corpi, territorialmente non
contigui, di Cutura e di Pantane, ubicato nella Sila in
territorio di Taverna di cui Pantane è una frazione
abitata.
Il feudo di Riccio o
Ricca nel Quattrocento apparteneva alla
famiglia Morano, retto jure langobardorum, nella
seconda metà del Quatrrocento fu ereditato dai due
fratelli: Bamonte Morano, che ereditò la
sezione denominata Cotura,
e Giovanni Morano, che ereditò la
sezione
denominata Pantane, e ne ottennero regolare
intestazione così come i loro rispettivi eredi, nel
corso dei secoli da tale divisione ne sono derivati due
feudi (Cotura e Pantane) posseduti da feudatari diversi,
confermata (questa suddivisione) dalle loro altrettanto
distinte ed autonome iscrizioni nei Quinternioni
ed intestazioni nei Cedolari. |
|
Sezione di Pantane
Donato Vincenzo Blasco
(† intorno al 1562), nobile
di Taverna, , unitamente ai suoi familiari, nel 1550 si
trovava notato per il pagamento dell'adoa di Pantane (Cedolario
82, f. 45).
Sblandiano
e Grandonio, figli di Donato Vincenzo, ottennero
intestazione del feudo di Pantane, Grandonio ebbe per
figlio, tra gli altri, Galeno, sposato a Clarice
Piccolo,
premorì al padre, e nel feudo gli successe suo figlio
Mario. Con Regio Assenso del 23 novembre 1583,
registrato nel (Quinternione 107, f. 179),
Sblandiano Blasco con i suoi figli, Mario Blasco e la
zia di questi Franchisina Blasco vendettero il
feudo di Pantane a Giovan Paolo
Ricca,
nobile di Taverna (Cedolario 82, f. 45
t.), sposato a Porzia Blasco, nobile di Taverna. |
|
Sezione di
Cotura
Francesco
Blasco, nobile di Taverna, il 24 maggio 1851 sposò a
Catanzaro Saveria
Stocco,
di Ferdinando, barone di
Riccio (sezione Cotura), e di Delfina
Marincola
Cattaneo, morto celibe suo fratello Filippo
Stocco, portò in casa Blasco le prerogative araldiche
della sua Famiglia.
Francesco e
Saveria ebbero per figlio Luigi Blasco (1852 †
1921), sposato nel 1882 a Giuseppina
Ricca, nobile di
Taverna, ebbero per figli: Ferdinando (1899 †
1951), sposato nel 1927 a Maria
Perrone
dei baroni di Sellia (ebbero solo figlie femmine);
Francesco (1893 †
1962), sposato nel 1922 a Beatrice
Schipani, nobile di
Taverna, ebbero oltre le figlie femmine, Ferdinando
(n. 1938), sposato nel 1966 a Teresa Sciacca (ebbero
solo figlie femmine); Rosario (1887 † 1928),
sposato nel 1922 a Concetta Valentino (ebbero solo
figlie femmine); Riccardo (1889 † 1945),
sposato nel 1914 con Armida Schipani, nobile di Taverna,
ebbero per figli, tra gli altri: Luigi (n. 1920),
sposato nel 1958 a Bruna Azzano (ebbero solo figlie
femmine); Ubaldo (n. 1931), sposato nel 1961 a
Vincenza Staglianò; Vincenzo (n. 1923), sposato
nel 1952 a Letizia Riccioppo hanno avuto per figlio
Riccardo (n. 1953), sposato nel 1975 con Anna Maria
Riccioppo hanno per figlio Vincenzo (n. 1975). |
|
 |
 |
|
Taverna, Palazzo Blasco in una cartolina d'epoca e come
si presenta oggi |
|
I Blasco ed il Feudo di Quartieri |
|
Feudo sito
in territorio di Magisano presso Taverna, denominato
anche Maldotto,
in quanto posseduto dalla Famiglia Madotto di Taverna
sin dal Cinquecento. Il feudo era retto jure
langobardorum.
Maria Poerio (Taverna, 1642), successe nel
feudo di Quartieri (quarta
parte) come erede per la morte di suo
fratello Giovan Battista (Taverna, 1638
† ivi, 1683).
Il 17 agoso 1668 sposò Francesco Blasco, nobile
di Taverna.
Giovanni Angelo (Taverna, 2 febbraio 1674 † ivi
celibe, 5 aprile 1737) e Domenico Blasco
(Taverna, 28 marzo 1682 † ivi, 6 marzo 1728), il 14
maggio 1714 presero intestazione della quarta parte del
feudo di Quartieri come eredi per la morte della
baronessa Maria, loro madre.
Domenico, il 10 maggio 1714 sposò Giulia
Spadafora
dei patrizi di Cosenza, vedova di Bernardino Sansosti,
ebbero per figlio Francesco (Taverna, 9 luglio
1716 † ivi, 4 ottobre 1775), il 5 marzo 1739 si intestò
la quarta parte del feudo di Quartieri come erede per la
morte di suo padre barone Domenico. Fu Sindaco dei
Nobili di Taverna nel 1743.
Marcello,
figlio del barone Francesco, il 27 marzo 1776 si intestò
la quarta parte del feudo di Quartieri come erede per la
morte di suo padre.
Vendette il
feudo al sacerdote Tommaso
Catizone,
nobile di Taverna.
Sposò a Taverna, il 20 luglio 1786 Caterina Melina. |
|
Altri personaggi di Famiglia |
|
Paolo
Francesco
o Paolo, nato a Rossano, avvocato, andò come
ambasciatore in Spagna presso
re Filippo IV
d'Asburgo-Spagna
(1621-1665)
per perorare la causa affinchè la città fosse
demanializzata, Cesare Monizio
(2),
nobile di Taverna, medico, poliglotta, ne fa lode nella
sua opera La Talia pubblicata in Napoli nel 1647.
Cesare fu zio materno di Ferdinando
Stocco (Taverna, 1611 † Cosenza, 1662), poeta, filosofo,
e matematico, in quanto sua sorella Eleonora sposò Paolo
Stocco. |
|

Stemma Monizza |
|
Arma Monizio
(Monizia, Monizzi, Monizza, Munizza):
d'azzurro,
al cipresso al naturale nodrito sopra un monte di tre
cime di verde movente dalla punta accostato da due rose
di rosso e da due stelle d'oro, alternate e poste in
palo nei fianchi. |
|
Domenico,
nel 1722 fu Sindaco dei Nobili di Taverna.
Gaetano,
nel 1730 fu Sindaco dei Nobili di Taverna
(3).
Salvatore
(Catanzaro, 30 settembre 1857 †
Reggio, 18 novembre 1938), da genitore della nobile
Famiglia di Taverna. Terminati gli studi, nel settembre
del 1879 entrava quale aiutante di Raffaele
Ciaccio
nell'Archivio di Stato, distintosi per la sua competenza
venne nominato archiviario in Tuta d'Otranto, nel 1882
per vincita di concorso passò a dirigere l'Archivio di
Stato di Reggio, ove rimase quarantasette anni. Ebbe
l'incarico governativo di studiare i documenti relativi
alla concessione delle ferriere di Calabria a Cesare
Fieramosca,
fratello di Ettore, per una causa di rivendicazione
iniziata nel 1620 e conclusa nel 1924 con una sentenza
della Corte di Cassazione in favore dell'Erario.
Pubblicò alcuni studi, restano altri manoscritti
custoditi nell'Archivio di Stato di Reggio.
I Blasco furono presenti anche a Policastro, nel 1572 la
Famiglia cercò di procurare una parrocchia a
Sebastiano Blasco, previo pagamento di una somma di
50 scudi al parroco Battista Venturino, affinchè
rassegnasse le dimissioni in favore di Sebastiano, non
essendo riuscito il tentativo di corruzione il capo
Famiglia, Mario Blasco, organizzò una sommossa a
cui parteciparono chierici e laici. Accusati di Simonia
(volontà di comprare o vendere un bene di ordine
spirituale, o una cosa di questo mondo connessa con la
sfera spirituale) successivamente furono perdonati
(4).
Si ha
notizia della presenza della Famiglia anche a Cropani in
quanto don Gaetano Blasco e don Francesco Colucci
convennero in giudizio quali generi di don Pasquale
Toscano di Belcastro, originario di Rogliano, essendo
ridotto in miseria, a suo tempo aveva assegnato 800
ducati di dote per le figlie
(5). |
|
_________________
Note:
(1) -
Blasonature come da stemmario manoscritto custodito
nella Biblioteca Universitaria di Napoli.
(2)
- Godette la nobiltà a
Taverna oltre che con la Famiglia Blasco, come riporta
Giovanni Fiore, facevano parte del Sedile Nobile:
Anania,
Caraffa, Carpanzano, Catizone, Cirillo, Ferrari,
Filante, Iozolino, Madotto, Mandella,
Marincola, Masella, Mazza, Morrone, Pistoia,
Poerio,
Ricca, Rocca, Rotella,
Schipani, Teutonica, Veraldi. La Famiglia possedette
il
feudo
di Cucinà,
sito nel territorio della baronia di Zagarise in
Calabria Ultra,
Fulvio
Monizio, nobile di Taverna, sposò Isabella Nicoletta,
figlia di Ottavio, la quale possedeva il feudo di Cucinà;
Scipione
Monizio, nobile di Taverna, acquistò il feudo per la
somma di ducati 2.000 per vendita fattagli da Isabella
Nicoletta, con Regio Assenso del 21 giugno 1706
registrato el
Quinternione
199, f. 231t., vendette il feudo ad Annibale Poerio,
barone di Montibus, figlio di Geronimo (di Carlo), per
la somma di ducati 1.625, con Regio Assenso del 4 giugno
1608.
(3) - Franz von Lobstein,
“Settecento Calabrese”, Vol. II, pagg. 162-163.
(4) -
Alberto Fico,
“Policastro, documenti e ricerche dall'antichità ai
nostri giorni”, Book Sprint Edizioni, pag. 305.
(5) - Franz von Lobstein,
op. cit., Vol. II, pag 171.
_________________
Bibliografia:
- Giovanni
Fiore
da Cropani, “Della Calabria Illustrata” Tomo I, a cura
di Padre Giovanni da Castelvetere, Napoli 1691; Tomo II,
a cura di Frà Domenico da Badolato, Napoli 1743; Tomo
III, a cura di Umberto
Ferrari,
Chiaravalle Centrale 1977.
- Mario Pellicano Castagna, “La Storia dei Feudi e dei
Titoli Nobiliari della Calabria”, Voll.II-IV, Editrice
C.B.C. 1984-2002.
- Gustavo Valente, “Dizionario
bibliografico biografico geografico storico della
Calabria”, Frama Sud 1989.
- Gustavo Valente, “Storia della Calabria
nell'età moderna”, Voll. I-II, Frama Sud, 1980.
- Cav. barone Luca de Rosis, “Cenno storico della città
di Rossano e delle sue nobili famiglie” - Napoli, 1838.
- G.B. di Crollalanza, “Dizionario storico-blasonico
delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e
fiorenti”, Pisa 1896.
|
|