|
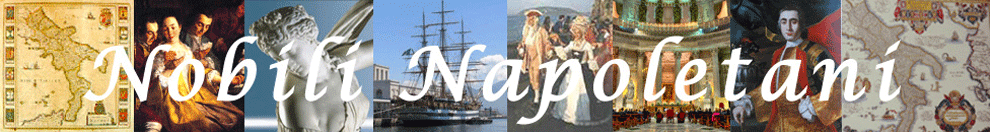
Ovvero delle Famiglie
Nobili e titolate del Napolitano, ascritte ai Sedili
di Napoli, al Libro d'Oro Napolitano, appartenenti
alle Piazze delle città del Napolitano dichiarate
chiuse, all'Elenco Regionale Napolitano o che
abbiano avuto un ruolo nelle vicende del Sud Italia.
|
|
 |
Famiglia
di Sangro |
|
Arma:
d'oro,
a tre bande azzurre(1).
Dimora: Napoli
Motto:
comune a tutte le linee della
casata sia principali che secondarie:
Unicum militiae fulmen. |
|

© Napoli - Stemma della Famiglia de Sangro,
principi di Sansevero |
|
Le origini della famiglia di o de Sangro si perdono
nella notte dei tempi; di certo, le prime notizie risalgono
all’anno 856 con BERENGARIO, primo
conte dei Marsi.
La contea dei Marsi era vastissima in quanto comprendeva la
valle Spoletana, la regione Marina, la Salina, la Valeria e
buona parte degli Abruzzi.
Nel 1093 ODERISIO ottenne la contea di
Sangro, dalla quale il casato prese il nome e tutti i
discendenti potettero fregiarsi del titolo di
conte concesso secondo le usanze
longobarde.
La famiglia fu insignita di numerosi titoli tra i quali:
barone di:
Bugnara,
Casignano, Casoria,
Itri, Locorotondo,
Mottola, Oppido,
San Giovanni in Fiore.
conte di: Marsi, sul nome, Brianza (1424), Buccino
(1408), Rodiano.
marchese di: Santo Stefano di Itri
(per successione Casa
Gesualdo), Castelnuovo
(1572), S. Lucido
(per successione Casa
Carafa della Stadera), Genzano (per
successione Casa
de Marino), del Finale, Campo di
Mele, Lenola, Monticelli,
Torremaggiore (1500), Sperlonga,
duca di: Vietri, sul nome
(1760), Casacalenda (1601), Torremaggiore (1572), Martina
(1507), Cagiano (1498), Telese (1728), Campolieto(1608).
principe di: Viggiano, del S.R.I., Sansevero (1587), Fondi (1720), Castelfranco
(1708), Gesualdo (per successione Casa
Gesualdo),
Striano (per successione
Casa de Marino), Palazzo S. Gervasio
(per successione
Casa de Marino), sul nome
(1911), Chiusano (1637 per successione Casa
Carafa della Stadera). |
|

© Napoli - stemma della regione dei
Marsi |
|
La linea dei Conti dei Marsi si estinse con Beatrice che nel
1152 sposò re
Ruggiero
il Normanno (3^ moglie); il ramo dei
principi di Viggiano si estinse in casa
Loffredo; il ramo dei
duchi di Vietri si estinse in casa
Caracciolo Rossi di Forino.
Il feudo di Civitella Alfedena, sito in
Abruzzo Citra,
appartenuto alla famiglia
di Sangro
dal 1154 a 1400, passò ai
Cantelmo
dal 1400 al 1579, poi ai Ciorla dal 1579 al 1697 ed
infine ai
della Posta dal
1697 al 1850.
I titoli di marchese del Finale e principe del S.R.I. passarono
dalla famiglia del Carretto ai di Sangro e poi ai
Pignone.
Sin dal 1424 vestì l’abito di Malta ed ottenne il Grandato di
Spagna di prima classe; fu decorata degli Ordini del Toson
d’oro, di S. Gennaro, di S. Ferdinando e del Merito e della
Concessione di Spagna.
Dal 1507 tutte le linee allora esistenti dei di Sangro furono
ascritte al Patriziato Napoletano del
Seggio di Nido e, dopo
l’abolizione dei sedili (1800), il casato fu iscritto nel Libro
d’Oro napoletano. |
|

© Napoli - Palazzo di Sangro dei principi di Sansevero e duchi di Torremaggiore - secolo XVI
|
|
Principali personaggi di casa di Sangro:
Nel 1121 ODERISIO fu Cardinale e abate di
Montecassino.
NICOLO’, ai tempi di re
Carlo II d’Angiò,
ricoprì la carica di
Gran Siniscalco del Regno.
BERARDO fu capitano generale di Capitanata e giustiziere
d’Abruzzo ai tempi di re Roberto.
RICCARDO, intrepido capitano, partecipò alla presa di Roma sotto
le insegne di re
Ladislao di
Durazzo e fu nominato castellano di Castel S. Angelo.
PAOLO di Sangro (†
1455 circa), sposato con Abenante Attendolo
Sforza, zia
di Francesco Sforza, duca di Milano, fu uno dei capitani di
ventura più importanti del Quattrocento; partecipò
attivamente alla vittoriosa battaglia di Sessano del 1442 contro
Antonio Caldora, duca di Bari e Carbonara e marchese del Vasto,
figlio del condottiero Giacomo Caldora, che parteggiava
con Renato d'Angiò.
In compenso, per i servigi resi, Paolo ottenne da
Alfonso I
d’Aragona nel 1443 il feudo di Civitacampomarano, in
Contado di
Molise, insieme a quello di Torremaggiore, in provincia di
Capitanata.
Sulla facciata orientale del castello di Civitacampomarano vi è
lo stemma di Paolo di Sangro avente come cimiero un grifone
(simbolo degli Aragonesi) che stringe due gigli capovolti
(simbolo della sconfitta degli Angioini).
|
 |
 |
|
Castello
di Civitacampomarano
Per gentile concessione di Aniello Gatta |
|
Il feudo di Lucito, in
Contado di Molise,
nel 1455 apparteneva a Salvatore
di Sangro, Signore di Calcabottaccio, Liceto, Dragonara
e Montazzolo; il figlio Antonio (†
1528), patrizio napoletano del
Seggio di Nido,
sposò Vittoria
Loffredo.
Il feudo di Lucito passò alla famiglia
Piscicelli. |
|

Lucito (Campobasso),
stemma partito di Sangro e Loffredo - Anno 1502 |
Il feudo di Civitacampomaramo fu venduto
da Gianfrancesco di Sangro, 1° principe di Sansevero,
verso la metà del XVI secolo ai
Carafa della Spina, cui
era legato da legami di parentela; successivamente passò
ai
Ferri, poi ai Marchese, quindi ai
d’Avalos e infine
nel 1742 a Pasquale
Mirelli, duca di Sant’Andrea. Il
figlio di quest’ultimo, Carlo Maria Mirelli, nel 1777
divenne l’ultimo duca di Civitacampomarano.
Nel 1495
Nicolò di Sangro fu
tra gli Ambasciatori dei Sedili di Napoli, fra cui Giulio Cesare
Caracciolo, Filippo Capece, Carlo
Dentice, Scipione
Loffredo,
Girolamo Carafa, Tomaso Pignatelli, Angelo
d’Anna,
Marcello Ruffo, Cesare
Agnese, Angelo
d’Alessandro,
Scipione
Moccia, Paolo
Brancaccio ed altri, che i Sedili
mandarono ad Aversa al Re Carlo VIII per dichiarare la
disponibilità dei napoletani ad accoglierlo come Re di
Napoli, come sarebbe avvenuto al suo ingresso a Napoli il
21 febbraio dello stesso anno.
SIGISMUNDO fu consigliere di Stato e maestro di campo
dell’esercito; nel 1503 partecipò alla
disfida di Barletta come
testimone.
Don Pedro
Alvarez de Toledo, marchese
di Villafranca e vicerè di Napoli dal 1532 al 1553, tentò di
instaurare anche a Napoli il famigerato Tribunale
dell’inquisizione; il popolo si ribellò, scoppiarono tumulti che
costrinsero i soldati spagnoli a rifugiarsi in Castel Nuovo.
I nobili napoletani si schierarono col popolo e si opposero
tenacemente all’editto del vicerè ma a nulla valse l’abile
dialettica di don Antonio
Grifone del seggio di Nilo e,
successivamente, il tentativo di Ferrante
Sanseverino, principe di Salerno,
recatosi in Spagna con la speranza di convincere l’imperatore
Carlo V d’Asburgo-Spagna
a revocare l’editto emesso dal vicerè. |
|
 |
 |
|
© Napoli -
Nel Cappellone del Crocifisso, oltre
alla
Cappella della Natività, vi sono varie sepolture e
gli splendidi
monumenti funebri di Placido e Nicolò de Sangro,
marchese di San Lucido
|
|
PLACIDO di Sangro, uomo eruditissimo, principe dell’Accademia
dei Sereni frequentata da illustri aristocratici quali Troiano
Cavaniglia, conte di Montalto, e
don Francesco
Muscettola, ottenne
di essere ricevuto da Carlo V, in qualità di Ambasciatore del
popolo napoletano.
Dopo il colloquio, l’imperatore, temendo di perdere il Regno di
Napoli per il moltiplicarsi delle sommosse che causarono non
poche perdite nelle file dell’esercito spagnolo, proclamò
l’indulto per i ribelli e decise che nel Napoletano non si
sarebbe istituito il Tribunale dell’inquisizione.
Il Regno di Napoli diventò un posto felice e sicuro per i
perseguitati della Chiesa; anche la famiglia di
Eleonora
Pimentel de Fonseca, a distanza di due secoli, fuggita dal
Portogallo e poi da Roma, si stabilì serenamente a Napoli.
|
|

© Napoli - Sulla volta
d'ingresso del palazzo fatto costruire nel 1506
da Giovanni de Sangro
duca di Vietri per sè e per la moglie
donna Andreanna Dentice, è dipinto lo
stemma
di Giovanni Battista de' Sangro, patrizio Napolitano,
figlio di Luzio, marchese di S. Lucido, e di Alivina Frangipane
della Tolfa; questi sposò Beatrice d'Afflitto acquistando il
palazzo poco prima del matrimonio.
Tale stemma, con le insegne delle famiglie d'Afflitto,
della Tolfa e de Sangro, fu creato in
occasione dell'unione tra le famiglie d'Afflitto e di Sangro |
|
Nel 1534 GIOVANNI
FRANCESCO, duca di Torremaggiore, fu al comando di 34 navi
napoletane, facenti parte della flotta di cento galere comandate
da don
Giovanni d’Austria e Ferrante
d’Avalos,
marchese del Vasto. Fu inflitta una umiliante sconfitta alla
squadra navale del sultano Solimeno; Tunisi fu conquistata e
assoggettata a un cospicuo tributo da versare annualmente alla
corona spagnola.
ALESSANDRO fu cameriere
segreto di papa Gregorio XIV, patriarca di Alessandria ed
arcivescovo di Benevento; nel 1600 in Napoli fece erigere la
cappella di famiglia detta della Pietà per la presenza di una
prodigiosa immagine della Vergine della Pietà.
La cappella fu arricchita di opere straordinarie da Raimondo di
Sangro, principe di Sansevero nel 1706.
Nel
1638
Scipione di Sangro duca di Casacalenda,
Giovan
Battista di Sangro principe di Viggiano e
Giovan
Francesco di Sangro principe di Sansevero parteciparono
alla fondazione,
insieme ad altri 35 cavalieri Napoletani, tra cui
Carlo Onero
Cavaniglia, Scipione
Filomarino,
Carlo
Dentice delle Stelle,
Goffredo
Morra, Placido
Dentice del Pesce, del MONTE GRANDE DE’ MARITAGGI
di Napoli,
istituzione benefica con lo scopo di assicurare una
cospicua dote alle fanciulle aristocratiche che si sposavano(2).
|
|
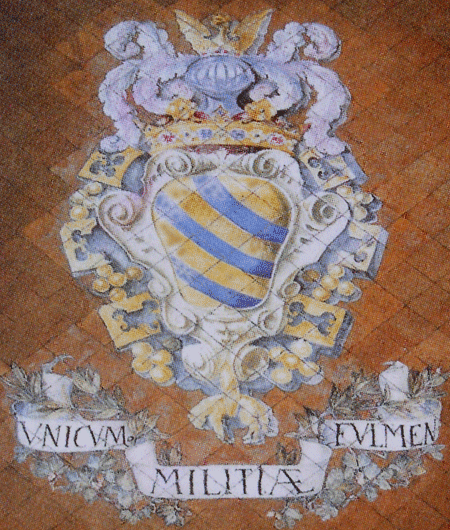
© Stemma Famiglia di Sangro |
|
Carlo Domenico di Sangro nacque il 13.10.1658,
figlio di Scipione duca di Casacalenda e di Laura di Sangro
duchessa di Vietri, studiò a Napoli nel Collegio dei Nobili
governato dai Padri Gesuiti. Sposò donna Vittoria Caracciolo
Rossi dei duchi di Belcastro; nel 1695 ricevette il titolo di
Principe dell’Accademia degli Uniti di Napoli, nelle cui
assemblee fu sovente ammirato per le sue lezioni accademiche e,
per la sua fama, fu ammesso all’Accademia degli Spensierati e in
quella dei Pellegrini a Roma, col nome Albauro del Melandro.
Alla morte della madre ereditò il titolo di
duca di Vietri. |
|
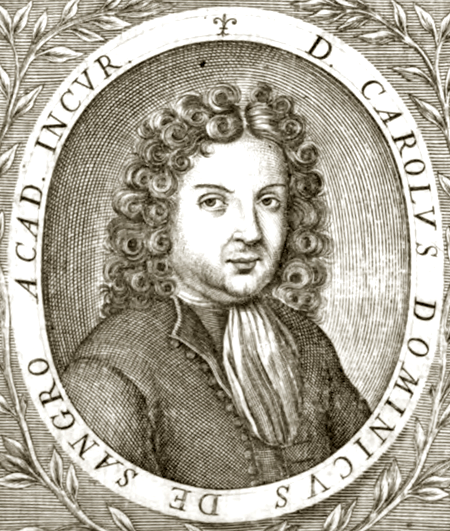
Carlo Domenico de Sangro duca di
Vietri |
|
PAOLO, valente combattente, partecipò alla battaglia di Norlinghen; re Filippo III lo nominò grande di Spagna e
cavaliere del Toson d’Oro.
Domenico, terzogenito di Giovan Battista e
di Beatrice d’Afflitto dei principi di Scanno, fu
Maresciallo di Filippo V di Spagna, accompagnò l’Infante Don
Carlo alla spedizione di Napoli e più tardi quando questi
divenne re, ricoprì numerosissimi incarichi alla sua corte. Nel
1759, con il Ministro Tanucci ed altri nobili napoletani fu
reggente al trono di
Ferdinando IV,
dopo la partenza del padre di quest’ultimo per l’ascesa al trono
di Spagna. Fu nominato Tenente Generale della Guardia Reale il
12 aprile 1737 e Maresciallo di Campo il 22 gennaio 1758.
Nominato Governatore della Piazza di Gaeta, Comandante Generale
della Cavalleria e Comandante della Guarnigione di Napoli,
ricoprì le cariche di Capitano Generale dell’esercito,
Consigliere di Stato, Presidente della Giunta di Fortificazione;
fu inoltre Gentiluomo di Camera di Sua Maestà, decorato del
titolo di Cavaliere del Real Ordine di San Gennaro; per le sue
eroiche gesta nel 1760 fu decorato del
titolo di 1° duca di Sangro.
Fu, altresì, autore di molte opere e, per questo, fu decorato
del titolo di principe dell’Accademia degli Uniti di Napoli. Nel
1751, in tarda età, impalmò Maria Teresa
Montalto dei
duchi di Fragnito, il matrimonio fu celebrato nella
chiesa di S. Anna di Palazzo.
RAIMONDO (Torremaggiore, 30.1.1710 † Napoli, 22.3.1771) è certamente il personaggio
più famoso del Casato; 7°
principe di Sansevero e di Castelgrande, Grande di Spagna,
cavaliere dell’Ordine di San Gennaro, di elevata cultura, fu uno
dei grandi geni del settecento napoletano.
I suoi studi spaziarono in tutti i campi, dalla
filosofia alla matematica, dalla fisica alle lingue straniere,
dall’arte della guerra alla letteratura, dalla medicina alla
chimica.
Già da studente, sbalordì gli ingegneri
dell’epoca inventando, con una serie di argani e ruote, un palco
teatrale che si poteva smontare in pochi minuti dando spazio ai
giochi di equitazione. Nel 1726 ereditò, alla morte del nonno(3)
il titolo di principe di Sansevero e nel 1730 si stabili a
Napoli, ove fece stupire il popolo che per la prima volta vide
una carrozza avanzare nel mare senza affondare. |
|

Raimondo di Sangro, principe di
Sansevero (1710
† 1771) |
|
Nel
1736 sposò donna Carlotta
Gaetani
d’Aragona, già promessa all’età di quattordici anni.
Scrisse vari trattati sulle fortificazioni, il Vocabolario
dell’arte militare di Terra, un manuale di esercizi militari per
la fanteria; per difendere Napoli dalla flotta inglese, costruì
in pochi giorni un cannone a lunga gittata in grado di colpire
le navi ancorate al largo.
Costruì una macchina tipografia in grado di stampare con una
sola passata più colori, prima macchina del genere in Europa.
Nel 1744 col grado di Colonnello del reggimento di
Capitanata
liberò la città di
Velletri occupata dagli austriaci.
Alcuni anni dopo cercò di curare Luigi
Sanseverino, principe di Bisignano, affetto da un male
implacabile; notò che la pelle del paziente acquistava lo stesso
colore delle sostanze mediche che gli fece prendere. Capì che il
veicolo non poteva essere che il sangue; pagò uno dei migliori
medici del Regno, Giuseppe Salerno, e costruì le cosiddette
“macchine anatomiche” che riproducevano, per la prima volta in
Italia, l’intero apparato circolatorio di un uomo e di una donna
in stato di gravidanza.
Nel 1750 entrò a far parte della Massoneria e in pochi mesi
divenne Gran Maestro della loggia Rosacroce di Napoli. Il conte Cagliostro
(1743 † 1795) venne a Napoli e frequentò gli ambienti massonici;
quando fu processato dal Tribunale dell'Inquisizione a Roma nel
1790 dichiarò
che tutte le sue
conoscenze alchemiche gli furono insegnate anni addietro a
Napoli da un principe molto amante della chimica. Probabilmente
"il principe" era Raimondo de Sangro.
Si
dedicò ai lavori della cappella gentilizia di famiglia in
Napoli, oggi Museo Cappella Sansevero visitabile tutti i
giorni ad eccezione del martedì (per info:
http://www.museosansevero.it/),
creando pitture impermeabilizzanti, con effetti
tridimensionali e che non hanno mai avuto bisogno di restauro
nel corso dei secoli, rimanendo i colori brillanti. |
|
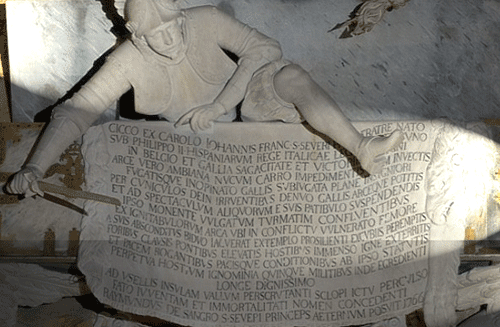
©
Napoli - Museo Cappella Sansevero
"Il
Monumento a Cecco di Sangro
rappresenta un evento
storico realmente accaduto: Cecco è ritratto
nell’atto di uscir fuori da una cassa nella
quale era rimasto nascosto per due giorni, stratagemma grazie al
quale colse di sorpresa e sgominò i nemici, impadronendosi della
rocca di Amiens." Come tutte le altre opere ha un valore
simbolo, posto all'ingresso, rappresenta il Guardiano del Tempio
Massonico, colui che non fa entrare nessuno. |
|
 |
 |
|
Stupore e meraviglia
sollevano le statue conservate nella Cappella ed ancora
tutt’oggi non si è riusciti a scoprire il segreto di come sia
riuscito a cementare in un unico blocco due strati di marmo:
nel “Il Cristo Velato” si vede la figura scolpita
del Figlio di Dio al di sotto del velo di marmo trasparente; lo
stesso dicasi per il “Disinganno”, il braccio del pescatore è
scolpito al sotto della rete di marmo.
In una lettera del 1763 indirizzata
al barone H. Theodor Tschudy, esponente
massonico al servizio di
Ferdinando IV di
Borbone nel reggimento degli svizzeri, scritta in codice, si
è venuti a conoscenza che Raimondo studiò un minerale (pechbenda)
che di notte era luminoso; lo depurò dal sicilio, rame, piombo
ed altre impurità. Scoprì l’effetto mortale che aveva sugli
animali di laboratorio e il modo di proteggerli con lastre di
piombo; egli stesso fu contagiato e un tremore lo accompagnò per
il resto dei giorni: aveva scoperto la radiottavità che chiamava
“raggio attivo”. Solo un secolo e mezzo dopo da detto materiale
si riuscì ad isolare il radio.
Numerosissime furono le sue invenzioni, dall’epigrafia al
negativo all’impermeabilizzazione dei tessuti, dalle gemme
artificiali al sistema per dissalare e potabilizzare l'acqua di
mare, dalla carta ignifuga al lume eterno, dal
fucile a retrocarica
alla stampa simultanea a più colori, ecc.
Nel 1765 il principe
si ritirò a vita privata, dedicandosi esclusivamente alle sue
ricerche; trasmise titoli e beni al figlio VINCENZO che sposò Gaetana
Mirelli, figlia di Giuseppe principe di Teora. |
|

© Vincenzo di Sangro, figlio primogenito di Raimondo,
nato nel 1743 |
|
Altro personaggio che merita di essere ricordato è il duca
RICCARDO de Sangro (Napoli, 1803 † Gaeta, 1861), figlio
del duca Nicola, tenente generale e gentiluomo di Corte; nel 1837 fu nominato tenente
colonnello del primo reggimento dei Lancieri, nel 1843 divenne
cavaliere dell’Ordine di San Gennaro, nel 1848 partecipò alla
campagna nello Stato Pontificio, nel 1849 fu promosso generale.
Sposò donna Argentina
Caracciolo, duchessa di Martina. Partecipò alla
difesa di
Gaeta nel 1860 e stette sempre al fianco di re
Francesco II di
Borbone sino alla sua morte avvenuta nel febbraio del 1861.
|
|
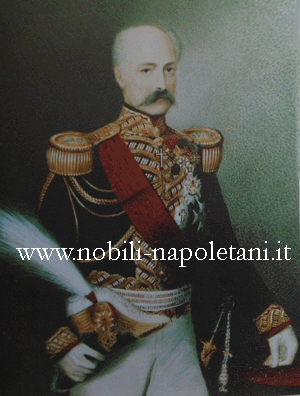
Duca Riccardo de Sangro, tenente
generale |
|
Il
titolo di duca di Martina venne
trasmesso, in successione materna, ai loro due figli maschi,
Placido
(1829
†
1891), cavaliere dell'Ordine
Costantiniano di San Giorgio, e
Nicola
(1827
†
1901), quindi, ai discendenti di
quest'ultimo. |
|
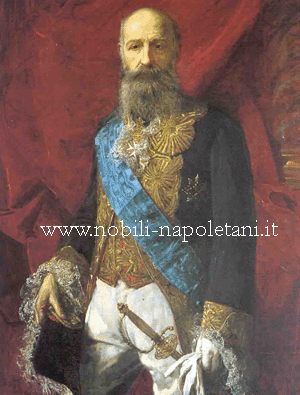
Placido de Sangro (1829
† 1891), duca di
Martina |
|
Michele di Sangro (1824
†
1890) fu l'11° ed ultimo principe di Sansevero, 5° principe di
Castelfranco, 11° duca di Torremaggiore, 14° marchese di
Castelnuovo, Grande di Spagna di Prima Classe, ecc.; era
fratello di Teresa di Sangro (1827
†
1887) che andò in sposa (1844) a Tommaso Enrico d’Aquino (1820
†
1868). Alla sua morte, non avendo discendenza diretta, tutti i
titoli di questo ramo dei di Sangro passarono a Michele
d’Aquino,
suo nipote. |
|

Il principe Michele di Sangro (1824
†
1890).
Per gentile concessione del Dr. Piero
Telesio di Toritto |
|
© Ercolano (NA) - Villa Campolieto,
a pochi passi dagli Scavi di Ercolano, fatta costruire nel 1755
da
Luzio de Sangro, principe di Campolieto e duca di Casacalenda |
|
Verso la metà dell'Ottocento
Placido di Sangro
(1829 † Napoli, 1891), duca di Martina, conte di Buccino e di
Brienza,
patrizio napoletano,
che abitava nel palazzo
Caravita di
Sirignano in Napoli, amante del bello e dell'arte, entrò in
contatto con i migliori collezionisti di Parigi e Londra ed
acquistò numerosi oggetti d'arte applicata. Nel 1911 il nipote,
anch'egli di nome Placido
(Parigi, 1866 † Castellammare di Stabia, 1911), patrizio
napoletano, donò a Napoli l'intera collezione
dello zio, composta di oltre seimila pezzi, che trovò
collocazione nella Villa Floridiana, appartenuta alla duchessa
Migliaccio.
Il Museo Duca di Martina fu arricchito dal lascito di Maria
Spinelli di Scalea
(n. 1867),
figlia di
Carlo dei principi di Scalea e di Felicita Nolli dei baroni di
Tolla
moglie del
di Sangro. |
|
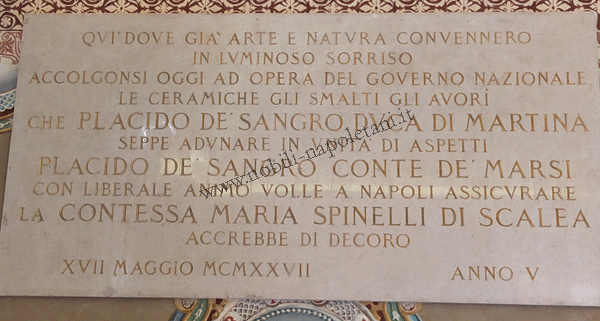
© Napoli - Museo Duca di Martina |
|
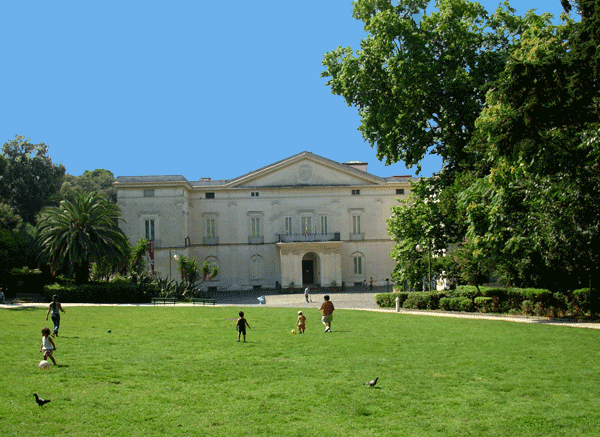
© Napoli - Museo Duca di Martina |
|
Napoli, Museo Duca di Martina,
una delle sale e stemma di Sangro |
|
Il
Museo è composto da tre piani: al piano terra sono esposti
oggetti in avorio, smalto e bronzo di epoca medioevale,
maioliche rinascimentali e barocche e vetri di Murano dei secoli
XV- XVIII; al primo piano è collocata la raccolta di porcellane
europee del XVIII secolo il cui nucleo più cospicuo è costituito
da quelle delle fabbriche di Meissen, Napoli e Capodimonte;
infine al piano seminterrato, vi è la sezione di oggetti d’arte
orientale, tra cui notevole è la collezione di porcellane cinesi
di epoca Ming (1368 -1644) e Qing (1644 -1911).
Per espressa volontà di
RICCARDO de Sangro (1889
†
1978), nipote ex
filio Giuseppe
(1861
†
1897) del citato Nicola ed ultimo maschio di questo ramo
della famiglia de Sangro, il titolo di duca di Martina non fu
attribuito ad alcuno dei suoi eredi. Proprio l'ultimo duca donò,
con atto testamentario nel 1978, la parte più consistente e
storicamente rilevante del grande archivio Caracciolo - de Sangro al comune di Martina Franca.
|
|
Famiglie imparentate con Casa di Sangro |
|
AFFLITTO d’: Francesco di Sangro di
Sansevero (n. Napoli, 1874) sposò Girolama
d’Afflitto dei principi di Scanno.
AQUINO d’: Teresa († 1887), ultima
erede della linea della linea primogenita dei principi di
Sansevero, sposò Enrico Tommaso
d’Aquino,
principe di Caramanico.
CARRETTO del: Giovanni Francesco,
principe di Sansevero, sposò, in prime nozze, Ippolita del
Carretto, marchesa del Finale.
COLONNA: Giovanni
Andrea (1851 † 1890), principe di Fondi, sposò donna Bianca
Colonna dei principi di Paliano.
DENTICE:
Lucido di Sangro, terzogenito di
Nicolò, da cui discese Giovanni, duca di Vietri, sposò
Adriana
Dentice che portò
in dote Ischitella, Peschici e Barano.
DORIA: don Giuseppe dei principi di
Fondi (1825 † 1909) sposò donna Eugenia
Doria
dei principi di Angri.
LOFFREDO:
Violante, figlia di Girolamo, principe di Viggiano,
sposò Carlo
Loffredo († Potenza,
1699), marchese di Trevico e di Sant’Agata.
MARINO de: Giuseppe de Sangro,
principe di Fondi,
sposò Maria Costanza
de
Marino, principessa di Satriano e di Palazzo San Gervasio e
marchesa di Genzano.
MENDASTI: Giovanni Scipione
(Napoli, 1844 † ivi,1930), duca di Casacalenda, di Campolieto e di
Telese, sposò Gaetana Mendasti.
MILANO:
Giovanni Francesco II
di Sangro,
principe di Sansevero, sposò nel 1619
Laudomia
Milano (1587
†
1643), figlia di Giacomo marchese di San Giorgio e di Isabella
del Tufo. |
|

© Napoli - Monumento funebre di
Nicola di Sangro
(1816
†
1863), figlio primogenito di Luigi, marchese di Santo Stefano
dei principi di Fondi |
|
PEREZ NAVARRETE: Luigi di Sangro, marchese di Santo
Stefano, sposò Anna Maria
Perez dei marchesi di La Terza.
della TOLFA:
Luzio de Sangro, marchese di S. Lucido sposò
Alivina Frangipane della Tolfa.
VITI: Oderisio (Napoli,1876 † 1910),
principe di Fondi, di Striano e Palazzo San Gervasio, sposò a
Napoli nel 1907 donna Giuseppina dei conti
Viti. |
|
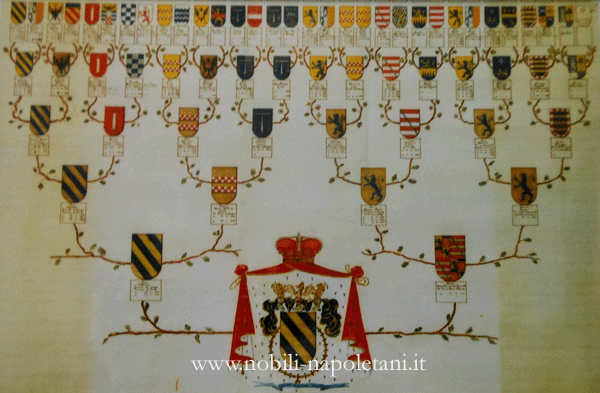
Stralcio dell'albero
genealogico con gli stemmi delle famiglie imparentate di
Don Ugone dei Principi di Sangro e dei Principi di Fondi
(n. 26.5.1945) |
|
____________________
Note:
1)
- Libro d'Oro Napoletano - Archivio di Stato di Napoli -
Sezione Diplomatica.
2)
-
Il padre Antonio prese i voti e si ritirò in un convento
di Roma.
3)
-
Istituirono il Monte Grande de’ Maritaggi
38 nobili, essi furono: Tommaso (detto anche Giovan
Tommaso) Filangieri figlio di Luigi barone di San
Lorenzo e Filetto dei duchi di Laurino, Scipione
Filomarino Mastro di Campo, Carlo Dentice delle Stelle,
Pacido Dentice del Pesce, Carlo Cavaniglia marchese di
San Marco, Landolfo d'Aquino, Giovanni d'Aquino, Alfonso
del Doce duca di Cufriano, Giulio Caracciolo, Carlo
Andrea Caracciolo marchese di Torrecuso, Ettore
Caracciolo marchese di Barasciano, Giovan Francesco
Caracciolo, Giuseppe Caracciolo principe di Torella,
Marcantonio Carafa, Carlo della Leonessa principe di
Sepino, Donato Coppola duca di Cassano, Fabrizio de
Silva, Federico Pappacoda marchese di Pisciotta, Orazio
di Gennaro, Francesco Galluccio, Ottavio Guindazzo,
Giovan Battista Brancaccio di Cesare, Ferrante
Brancaccio di Rinaldo principe di Ruffano, Paolo
Marchese marchese di Camarota, Giovan Francesco di
Sangro principe di Sansevero, Scipione di Sangro duca di
Casacalenda, Giovan Battista di Sangro principe di
Viggiano, Goffredo Morra marchese di Monterocchetta e
Principe di Morra, Vincenzo Mora, Ottavio Monaco, il
Consigliere Tommaso de Franchis, Andrea de Franchis
marchese di Taviano, Francesco Maria di Somma, Carlo
Spinello principe di Tarsia, Giovan Battista Pisanello,
Antonio Castigliar marchese di Grumo, Orazio Suardo e
Vincenzo del Tufo.
___________________
Alcune fonti bibliografiche:
-
Lucia Lopriore, "L'aristocrazia
napoletana tra Capitanata e Valle d'Itria, i duchi di
Sangro, storia della famiglia dalle origini ad oggi".
- Antonio Emanuele Piedimonte, "Raimondo di Sangro
Principe di Sansevero", Edizioni Intra Mpenia.
- Berardo Candida Gonzaga, “Memorie delle famiglie
nobili delle Province Meridionali d’Italia”, Napoli,
1875.
- Vittorio Spreti, “Enciclopedia storico-nobiliare
Italiana”, Arnaldo Forni Editore.
- G.B. di Crollalanza, “Dizionario storico-blasonico
delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e
fiorenti”, Pisa 1896.
- Francesco Bonazzi di Sannicandro, “Famiglie nobili e
titolate del Napolitano”, Arnaldo Forni Editore, 2005.
- Carlo Padiglione, “Trenta centurie di Armi
Gentilizie”, Napoli, 1914.
- Roberto M. Selvaggi, “Nomi e volti di un esercito
dimenticato”, Grimaldi & C. Editori, Napoli 1990.
- Lorenzo Giustiniani , “Dizionario geografico-ragionato
del Regno di Napoli”.
- Giuseppe Lumaga, “Teatro della nobiltà dell'Europa
ovvero Notizie delle famiglie nobili, che in Europa
vivono di presente, e che in lei vissero prima ...”,
Napoli 1725. |
|