|
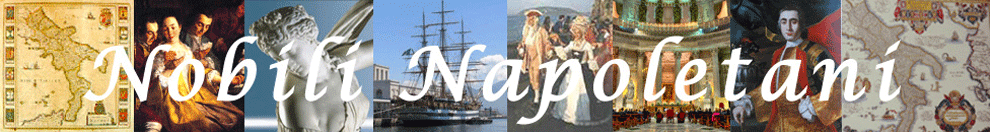
Ovvero delle Famiglie
Nobili e titolate del Napolitano, ascritte ai Sedili
di Napoli, al Libro d'Oro Napolitano, appartenenti
alle Piazze delle città del Napolitano dichiarate
chiuse, all'Elenco Regionale Napolitano o che
abbiano avuto un ruolo nelle vicende del Sud Italia.
|
|
Arma: d'oro all'aquila
spiegata d'azzurro imbeccata ed armata di rosso.
Alias: d'azzurro alla fascia di oro accompagnata nel capo
da una stella dello stesso e nella punta da una ghianda al
naturale.
Alias: di rosso al levriere al naturale collarinato d'oro
attraversato da una freccia d'oro.
Motto: Flectar non frangar |
|

© Capua - stemma di Bartolomeo Prignano,
eletto Papa col nome di Urbano VI |
|
L'antichissima famiglia Prignano si ritiene originaria di Pisa
in quanto Nicolò, appartenente al ceto artigianale si trasferì a
Napoli e sposò Margherita
Brancaccio appartenente ad una delle
più importanti famiglie nobili della città partenopea;
di certo la famiglia prese il nome Prignano da una terra che
possedevano in
Principato citra.
Nel 1266 quando re
Carlo I d'Angiò salì sul trono di Napoli,
Antonello Prignano ebbe in dono dal sovrano il castello di
Finocchio.
Il Casato possedette numerosi feudi tra i quali: Acquarola,
Altamura, Aversa, Baiano, Capri, Castellammare, Cricignano,
Gaeta, Minervino, Nocera, Pagliara, Scafati, Sorrento, Somma,
Vatolla.
Fu investita dei titoli di:
conti di Fondi
duchi di: Amalfi (1381),
Durazzo (1381)
principi di Capua (1381). |
|
Il
feudo di Vatolla, piccolo insediamento
fortificato in una posizione strategica per il controllo
della via di Lauriana, oggi frazione di Pedifumo in
Principato Citra,
appartenne ai
Sanseverino, ai
di Costanzo, ai Prignano, ai Griso baroni di Celso e
Galdo, ai
del Pezzo, al marchese Domenico Rocca, e infine nel 1767 fu
acquistato dalla famiglia Vargas
Machuca, conservando il feudo fino
all’abolizione della feudalità (1806).
Francesco Prignano, barone di Acquarola, feudo in
Principato citra, sposò Beatrice
Gagliardi, figlia di
Camillo Uditore della Provincia di Capitanata e del
Contado di Molise dal 1534, e di Orsola Campana.
I Prignano godevano di nobiltà in Napoli fuori Seggio;
nel 1549 Carlo Prignano trasferì la sua famiglia a
Salerno dove furono ascritti ai Seggi di Campo e Portaretese. Nel 1600 i Prignano si diramarono in
Lucera, Teano e Sanseverino.
Il ramo dei Sanseverino si estinse con Alessandro
Prignano.
I Prignano si imparentarono con nobilissime famiglie:
d'Afflitto,
Brancaccio,
Candida,
Capuano,
Cavalcante,
del Giudice,
Longo,
Salerno,
del
Tufo, Rendina ed altre.
Nel
1383 una nobildonna di casa
Prignano,
nipote di Papa Urbano VI, sposò Giovanni
d’Artus,
conte di San’Agata e di Monteodorisio; il matrimonio fu
celebrato solennemente dallo stesso Pontefice in Napoli
nella sede arcivescovile. Le sorelle
e nipoti del fu Bartolo barone di Licignano, Francesca e
Geronima Rendina, baronessa di Licignano, sposarono
rispettivamente Giovanni Antonio Prignano e
Carlo Prignano. |
|
 |
 |
|
Napoli - Monumento funebre di Francesco
Prignano e Geronima Funicella - Anno 1589
A destra: cudo troncato con le armi dei
Prignano e Funicella, famiglie imparentate |
|
I
Prignano, patrizi di Salerno, vestirono l'abito di Malta
nel 1578 come quarto della famiglia
Strambone e nel 1730 come quarto del Comm.
Gennaro
Salerno; i Prignano di Sanseverino nel 1598
come quarto della famiglia
Ruggi.
La famiglia risulta iscritta
nel Registro delle Piazze Chiuse del
Regno di Napoli e
nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1922 nella
persona di Girolamo Prignano (Lucera, 9.6.1853
†
ivi, 11.12.1933), Patrizio di
Salerno e di Lucera. |
|
Bartolomeo Prignano (Napoli, 1318
†
Roma, 1389), figlio dei già citati Nicolò e Margherita
Brancaccio, si laureò in diritto canonico all'Università
di Napoli e intraprese la carriera ecclesiastica. Fu
nominato vescovo di Acerenza il 22 marzo del 1363 e
arcivescovo di Bari nel 1377.
Nel 1378 morì Gregorio XI e il 7 aprile il Collegio
cardinalizio elesse nuovo pontefice Bartolomeo Prignano;
un secondo scrutinio riconfermò il Prignano; il 18
aprile Giacomo
Orsini pose la tiara sul capo di Urbano VI.
Il nuovo papa, desideroso di portare avanti la riforma
ecclesiastica già avviata dal suo precedessore, dimostrò
subito un temperamento forte e rigido entrando in
contrasto con numerosi cardinali che erano contrari allo
spirito di rinnovamento sul modo di essere cardinali.
Ben presto si scatenò una campagna denigratoria contro
Urbano VI, mettendo in discussione anche la sua
elezione, la stessa Caterina da Siena dovette
intervenire in sua difesa affermando che i cardinali
pensavano più alle cose materiali che spirituali.
|
|
 |
 |
|
Napoli - Busto di Urbano VI e stampa |
|
Il 20 luglio 1378 i cardinali
dissidenti, riunitisi ad Anagni, forti anche della
vittoria delle truppe mercenarie al loro servizio che
avevano sconfitto i Romani sul ponte Salario,
dichiararono all'unanimità la nullità dell'elezione
papale.
Il 20 settembre si trasferirono a Fondi, nel castello di
Onorato
Gaetani, seguendo il suggerimento di Niccolò
Spinelli, conte di Giovinazzo a Ambasciatore
della regina
Giovanna I d’Angiò, e il giorno dopo venne
eletto Roberto di Ginevra che prese il nome di Clemente
VII, oggi noto come l'antipapa; questi con la sua Curia
si stabilì ad Avignone.
Iniziò così lo scisma d'Occidente che si concluderà solo
trentanove anni più tardi dopo varie battaglie.
Urbano VI dovette nominare nuovi cardinali, tra i quali
Marino
Vulcano e Rinaldo Brancaccio; nel 1380
dichiarava eretica Giovanna I d’Angiò, la scomunicò e la
sostituì con il cugino, Carlo di Durazzo, della linea
ungherese degli Angiò, che venne incoronato a Roma nel
1381.
Entrato a Napoli, Carlo III di Durazzo, con l'aiuto del
cardinale Gentile
de Sangro, fece prigioniera la regina
Giovanna, che morirà in carcere nel 1382.
L'Europa cristiana si trovò ad un certo punto costretta
a scegliere tra Urbano VI e Clemente VII; i due
pontefici cercarono l’appoggio di sovrani e città.
Urbano VI nel 1384 si rifugiò a Nocera, temendo che il
re di Napoli, insieme ad alcuni cardinali, stesse
cospirando contro di lui, fece imprigionare i porporati
sospetti tra i quali il cardinale Marino
del Giudice, scomunicò Carlo III e lo
dichiarò decaduto; il sovrano fece assediare il papa a
Nocera dalle sue truppe; il 5 luglio del 1385 Raimondo
del Balzo Orsini, passato dalla parte degli
Angioini, al comando di settemila militi, con l’aiuto
del principe
Sanseverino, liberò il papa che si imbarcò
alla volta di Genova.
Nel settembre del 1388 il Prignano tornò a Roma dove
l’anno dopo rese l’anima a Dio.
Suo successore fu Bonifacio IX. |
|
Continua nel sesto
volume in preparazione di "LA STORIA DIETRO
GLI SCUDI"
Copyright © 2007 www.nobili-napoletani.it
-
All rights reserved
|
|