|
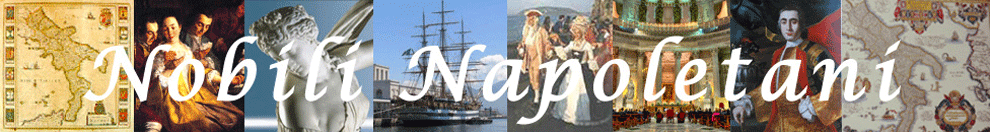
Ovvero delle Famiglie Nobili e titolate del Napolitano,
ascritte ai Sedili di Napoli, al Libro d'Oro Napolitano,
appartenenti alle Piazze delle città del Napolitano
dichiarate chiuse, all'Elenco Regionale Napolitano o che
abbiano avuto un ruolo nelle vicende del Sud Italia.
|
|
Le principali
battaglie svoltesi nel Mezzogiorno d’Italia
con la collaborazione del
dr. Fabio Di Fede
|
|
Battaglia di Canne
Luogo: Canne, sulla riva destra dell’Ofanto,
a 9 km dal mar Adriatico
Data: 1
ottobre 1018
Contendenti: Bizantini al comando del Catepano Basilio Bojoannes vs ribelli Longobardi guidati
da Melo da Bari e mercenari Normanni
Esito: sconfitta totale degli insorti
da parte delle forze imperiali.
|
Battaglia del fiume Olivento
Luogo: fiume Olivento presso Melfi
Data: 17 marzo
1041
Contendenti: Normanni d’altavilla
guidati da Guglielmo Braccio di Ferro vs Bizantini guidati dal
Catapano Michele Dokeianos
Forze in campo: Normanni: 700 cavalieri
e 500 fanti, Bizantini forze imprecisate ma superiori di numero
Esito: Attacco ad ondate successive dei
Bizantini, che verranno respinti e sconfitti nell’attacco finale da
parte dei Normanni
|
|
Battaglia di
Civitate
Luogo: Civitate, lungo
il corso del fiume Fortore, a nord ovest di Foggia
Data: 18 giugno
1053
Contendenti: Coalizione pontificia
composta da italici, longobardi, svevi e bizantini al comando di
Rodolfo di Benevento vs coalizione di vari gruppi normanni comandati
da Umfredo d’Altavilla
Forze in campo: i normanni possiedono
3000 cavalieri e 500 fanti mentre la coalizione pontificia dispone
di circa 6.000 tra fanti e cavalieri.
Esito: disastrosa sconfitta della
coalizione pontificia, finita addirittura con la cattura dello
stesso pontefice Leone IX
|
|
Battaglia di Nocera
Luogo: tra Nocera e Scafati, lungo il
corso del fiume Sarno, a nord di Salerno
Data:
25 luglio 1132
Contendenti:
Normanni fedeli al re di Sicilia guidati da Ruggero II Vs Rainulfo III
di Alife e Roberto II di Capua
Forze in campo: Rainulfo e Roberto
dispongono di circa 4.500 cavalieri e numerosi fanti, Ruggero
dispone di forze superiori e meglio attrezzate, ma se ne sconosce il
numero preciso
Esito: sconfitta totale di Ruggero II
|
|
Battaglia di Benevento:
(vedi storia completa)
Luogo: piana
del fiume Calore nei pressi di Benevento
Data: 26
febbraio 1266
Contendenti: Carlo I d’Angiò vs
Manfredi di Sicilia
Forze in campo: Angioini: 3.000
cavalieri Manfredi: 3500 cavalieri e alcune migliaia di arcieri
saraceni
Esito: sconfitta e morte
in battaglia di Manfredi e di gran parte delle sue truppe.
|
|
Battaglia di Melito
Luogo: Melito, alle porte di Napoli
Data: 6
giugno 1349
Contendenti: Angioini vs Ungheresi
Forze in campo: 1600 cavalieri pesanti
Ungheresi e Tedeschi Angioini: 800 cavalieri e un numero imprecisato
di fanti.
Esito: sconfitta angioina, che perdono
circa 1.000 uomini tra morti e feriti. Gli Ungheresi avranno solo
alcuni feriti, grazie alle pesanti armature indossate.
|
Battaglia di Sarno
Luogo: Sarno (Sa)
Data: 7 luglio
1460
Contendenti: Angioini guidati da Giovanni I d’Angiò contro Aragonesi guidati da Ferdinando I d’Aragona
Esito: Sconfitta aragonese dovuta allo
sbandarsi dell’esercito, che dopo un iniziale vantaggio aveva
iniziato a saccheggiare l’accampamento nemico, permettendo così agli
angioini di riorganizzarsi e tornare all’attacco.
Note:
Giovanni Grimaldi detto "Giovannello",
nel 1460 si distinse come abile comandante e, per i suoi meriti, nel 1484 fu riconosciuto Nobile
da re Ferrante I d’Aragona , come "...originario di Genova ed
abitante in Cava…".
Giovanni Piscicelli,
fratello di Nicolò(†1471)
arcivescovo di Salerno, Signore di Sant’Angelo e di Rocca Piemonte,
partecipò con grande maestria alla battaglia e fu nominato Capitano
di gente d’Arme.
Il Capitano di ventura Marino
Longo, condottiero di
Ferdinando I d'Aragona, divenne famoso per averlo
salvato nella
battaglia di Sarno e dal cui Re ottenne diversi
privilegi.
Il titolo di Patrizio
Cavense, di cui si fregia Matteo
Tajani (1557†1626), fu
concesso probabilmente dal giovane re
Ferrante
d’Aragona ad un suo antenato che aveva
partecipato alla
battaglia di Sarno
essendo rimasto fedele, come tutti i cittadini di Cava de’
Tirreni, al sovrano aragonese. Il monarca fu tanto grato ai
cavesi, che con il loro valido aiuto salvarono la sua vita e il
trono, che il 4 Settembre 1460 concesse la famosa Pergamena
Bianca con la quale l’Università della città di Cava avrebbe
potuto ottenere quanto si potesse concedere. I cavesi non
ritennero di avanzare alcuna richiesta e per tale motivo Re
Ferrante il 22 Settembre 1460 consegnò un diploma di privilegi e
franchigie agli inviati dell’Università di Cava.
|
|
Battaglia di San Flaviano
Luogo: sulla foce del fiume Tordino,
nei pressi di Giulianova (Te)
Data: 27
luglio 1460
Contendenti: Angioini comandati da Jacopo Piccinino contro Aragonesi, Stato Pontificio e Ducato di Milano
comandati da Federico da Montefeltro
Forze in campo: Angioini 5.000
cavalieri e 3.000 fanti, coalizione 5.000 cavalieri e 150 fanti.
Esito: Con un attacco aragonese alla
cavalleria angioina, ferma ad abbeverarsi al fiume inizia lo scontro
durissimo, durato 7 ore con perdite di circa 800 cavalieri e 1.000
fanti tra i due schieramenti. Non si può comunque parlare di un
vincitore ben definito della battaglia.
|
|
Battaglia di Troia
Luogo: Troia (Fg)
Data:
18 agosto 1462
Contendenti: Aragonesi comandati da Ferdinando d’Aragona
contro gli
Angioini di Giovanni d’Angiò e Jacopo Piccinino
Forze in campo: Aragonesi 50 compagnie di cavalli e 2000 fanti
Angioini 2.500 fanti e un numero imprecisato di cavalieri.
Esito: sconfitta angioina e cattura di 150 cavalieri angioini.
Parteciparono alla presa di Troia:
Lombardo,
Cossa,
Imperato,
Piccolomini.
|
|
Battaglia di
Otranto
Luogo: Otranto, penisola Salentina
Data: 27 luglio
1480
Contendenti: flotta navale turca di
Maometto II contro Don Alfonso Duca di Calabria
Forze in campo: tra i 18.000 e i
100.000 turchi imbarcati su un numero di navi compreso tra le 70 e
le 200 e 6.000 abitanti della città, di cui 400 combattenti.
Esito: resa dei turchi
il 10 settembre, ma solo
300
abitanti di Otranto sopravvissero all’occupazione turca.
|
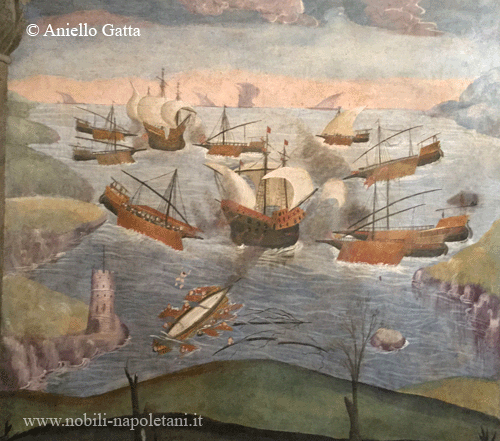
Castello di Gambatesa,
rappresentazione di battaglia navale di Otranto nel 1481 |
Gli abitanti di Otranto, splendida città della
Puglia all’epoca in Provincia di
Terra di Otranto, cessarono di
vivere tranquillamente quando il 28 luglio 1480 l’esercito comandato
da Akmet Pascià, inviato da Maometto II per estendere il suo regno
in Italia, cinse d’assedio la città.
I cittadini con una sparuto numero di soldati, circa
quattrocento comandati dal Capitano Francesco
Zurlo
(† 1480), resistettero
valorosamente per 15 giorni in attesa che da Napoli arrivassero i
rinforzi; i Turchi assaltarono le mura ripetutamente sino a quando i
numerosi colpi di cannone riuscirono ad aprire un varco che permise
agli ottomani di penetrare all’interno.
Metro dopo metro, la città fu conquistata e gli ultimi superstiti si
barricarono invano nella Cattedrale.
L’arcivescovo Stefano Agricoli fu trucidato, insieme ai suoi
sacerdoti, sull’altare.
Il Pascià fece radunare i superstiti, quasi tutti giovani dai 15
anni in su, promettendo la salvezza per tutti coloro che avrebbero
rinnegato Gesù Cristo. Il primo a rispondere fu un cimatore di
panni, Antonio Pezzulla detto Primaldo:” Preferiamo morire per
Cristo con qualsiasi genere di morte anziché rinnegarlo”; tutti gli
altri sventurati gridarono la frase del cimatore di panni.
Ottocento persone furono portate sul Colle della Minerva ove ebbe
inizio il massacro; Antonio Pezzulla fu il primi ad essere
decapitato; il suo tronco restò in piedi sino alla termine
dell’eccidio e ciò provocò la conversione di un turco di nome
Berlabei, condannato poi alla pena di morte tramite impalazione.
|

© Rappresentazione dell'eccidio di
Otranto con il tronco di
Antonio Pezzulla che resta
in piedi senza testa. |
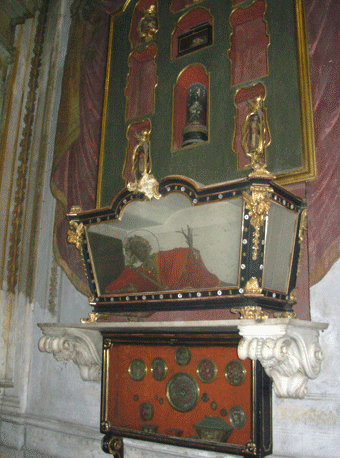
© Napoli - una delle due urna che
racchiudono le salme dei
martiri di Otranto |
Giulio Antonio
Acquaviva, duca di Atri e conte di Giulianova e
Conversano, in attesa dell’esercito aragonese, con i suoi militi
formati prevalentemente da cavalieri meridionali, fermò l’avanzata
dei nemici verso Lecce e Brindisi; il duca d’Atri nel 1481, nelle
vicinanze di Serrano, durante una ricognizione, cadde in
un’imboscata tesa dai Turchi. Il suo corpo decapitato rimase in
arcione al cavallo che lo riportò indietro. Re
Ferdinando I
d’Aragona, per ricompensa, investì gli Acquavia dell'attributo
reale d’Aragona, ereditato dal figlio Andrea Matteo, il quale fu
impegnato nel maggio 1481 nella liberazione di Otranto.
A luglio dello stesso anno salpò da Napoli la flotta del reame,
comandata dal condottiero Galeazzo
Caracciolo, mentre da terra
Alfonso di Calabria, futuro re di Napoli, con il suo esercito marciò
verso Otranto.
Tredici mesi dopo l’eccidio, il 13 ottobre 1481
Otranto venne liberata e i corpi dei martiri, trovati incorrotti,
furono portati nella Cattedrale ed alcuni a Napoli nella chiesa di
Santa Caterina a Formiello.
Va ricordato che Venezia rifiutò di aiutare i pugliesi e che Lorenzo
il Magnifico fece coniare una medaglia in ricordo della vittoria di
Akmet Pascià.
Il Pontefice Papa Clemente XIV dichiarò Beati i martiri di Otranto
il 14 dicembre 1771.
Note:
Ciro e Matteo
Mastrilli
parteciparono alla battaglia; il primo al comando di duemila fanti
col grado di Maestro di Campo, il secondo (figlio di Ciro) cadde sul
campo di battaglia.
Giulio Antonio
Acquaviva
mori in battaglia. Gatto
della Gatta,
abile condottiero di gente d’arme, partecipò valorosamente alla
battaglia. Francesco
Capece Zurlo
(†1480), Signore di
Pietragalla e Oppido, difese invano Otranto dall’assedio dei Turchi;
morì eroicamente con i cittadini pur di non rinnegare la Fede in
Cristo.
Giovanni e Tiberio
del Tufo parteciparono
alla campagna militare per la liberazione di Otranto dai Turchi.
Francesco
Firrao fu
valoroso combattente durante l'assedio.
Girolamo
Milano partecipò alla
guerra nel 1481 al comando di suoi numerosi cavalieri.
Don Diego
Cavaniglia (1453 † 1481, figlio di Garzia, conte di Montella, raggiunse
nell’agosto del 1481, con un propria compagnia di soldati, Otranto
che verrà liberata il successivo 10 settembre.
Durante uno degli ultimi assalti, Don Diego venne
colpito alla gamba da una freccia, probabilmente avvelenata, e pochi
giorni dopo morì. Fu trasportato a Montella e sepolto nella Chiesa
di S. Francesco a Folloni, ove sua moglie Margherita Orsini dei duchi di Gravina gli innalzò nel
1492 un monumento sepolcrale.
Tommaso
Filomarino,
comandante di fanteria, e Giovanni Filomarino,
con sei cavalieri ai suoi ordini, parteciparono alla
guerra.
Matteo di
Capua, conte di Palena, morì in battaglia nel 1480.
Luigi
Castromediano, governatore di Rossano, comandante di 300 fanti, per il valore
dimostrato ottenne dal re Ferrante I d’Aragona l’ esenzione
delle tasse.
Ferdinando
Quaranta partecipò alla guerra
d'Otranto con sei propri Cavalieri e sconfisse più volte i
Turchi.
Troiano
de Curtis,
comandante di cavalleria, morì durante la battaglia.
Francesco
Coppola,
conte di Sarno,
inviò le sue galee contro i Turchi ad Otranto e nel 1484 cacciò i
veneziani che avevano occupato Gallipoli.
Nel 1480
il
consigliere Giovanni
Albino seguì il duca
Alfonso di Calabria alla
guerra di Otranto.
Filippo Anzani partecipò alla battaglia con 3 cavalli;
partirono da Napoli insieme a lui Alberico
Caracciolo con 6 cavalli, Aldasso d'Aiello con 5
cavalli, Alfonso
d'Alagno, Andrea Caffarelli, Federico Boccalino
con 3 cavalli, Galderisio de Rinaldo con 5 cavalli, Florio
Gizzio con 5 cavalli, Filippo Mareri con 6 cavalli, Andrea
Brusca regio Cortigiano, Galiotto
Pagano con
6 cavalli, Giovanni Azzia con 12 cavalli, Giovanni
Capano con 6
cavalli, Carlo
Gesualdo, Ausio Apicella, Antonio
Gentile,
Michele
Barrile, Giacomo Palagano, Battaglino
Sanseverino con 20
cavalli, Baldassarre
di Costanzo ed altri.
Carlo
Pandone, ambasciatore di re Ferdinando I
d’Aragona, partecipò alla guerra al comando di
trecento cavalli.
Giuseppe Leonardo
Arditi, Regio Squadrerio, partecipò
alla battaglia.
Nicola
Venusio,
dottore in legge di Matera, nel 1481 con una compagnia di soldati
arruolati a sue spese, partecipò alla liberazione di Otranto,
combattendo valorosamente.
Il barone Giovanni
Salazar, con
propri cavalli, partecipò alla guerra di Otranto nel 1481.
Pascasio Diaz
Garlon fu un dei finanziatori della spedizione.
Evellino o
Avellino I
Marincola,
capitano, morì in battaglia.
Oddone
Quarto, capitano di una galera, fu un valoroso
combattente alla guerra
d’Otranto.
Francesco e Fabio
Grassi, figli di
Giovanni e di Angela Cesia, il 14 agosto 1480 morirono in battaglia.
Ferrante
di Gennaro combattè con sette cavalli.
Giovan Battista
Manso
(†
Napoli, 1566), comandante le avanguardie di Carlo
Loffredo,
marchese di S. Agata.
Furono massacrati, tra gli altri:
Angelo
Pasca, Francesco
Zurlo
governatore di Otranto, Francesco
d’Alessandro,
Marino
Brancaccio,
Ciccarello
Loffredo,
Francesco
Pappacoda,
Gio: Francesco
Caracciolo,
Alessandro
Carafa,
Raimondo
del Balzo
conte di Ugento, Matteo
Mastrilli,
Filippo
Guindazzo,
Carlo
Pandone,
Carlo
Gesualdo,
Trojano
Pagano,
Matteo
di Capua
conte di Palena, Trojano
Spinelli,
Iacopo Boccapianola, Giovanni
del Tufo,
Carlo
della Tolfa,
Giulio
Acquaviva
conte di Conversano, e tanti altri.
|
|
Battaglia di Seminara
Luogo:
Seminara a sud ovest di Reggio Calabria, nella piana di Gioia Tauro,
lungo il corso del Metauro
Data:
28 giugno 1495
Contendenti: Regno di Francia vs Regno
di Napoli e Spagna
Forze in campo: 600 lancieri di
cavalleria spagnoli, 1500 fanti, 3.500 soldati della flotta spagnola
e 6.000 volontari calabresi contro 400 gendarmi della cavalleria
pesante, 800 cavalieri leggeri ed altrettanti picchieri elvetici,
più un numero imprecisato di fanti.
Esito: sconfitta del Regno di Napoli e Spagna,
con l’uccisione di oltre 3.000 fanti.
|

Battaglia di Seminara |
Note: re Ferdinando II d'Aragona fu disarcionato, Giovanni
di Capua,
fratello di Andrea 1° duca di Termoli, accorse in aiuto dandogli il
suo cavallo; rimasto a piedi, Giovanni morì in battaglia.
|
Battaglia di Seminara
Luogo: piana di Gioia Tauro
Data: 30
novembre 1502
Contendenti: Regno di Francia contro Regno
di Spagna
Forze in campo: per i Francesi
cavalleria pesante francese, scozzese e italiana, cavalleria
leggera, fanteria svizzera ed arcieri della Guascogna, per gli
Spagnoli 400 cavalieri pesanti, 300 cavalieri siciliani, cavalleria
leggera spagnola e 3.000 fanti siciliani.
Esito: Vittoria
francese, con cattura di molti prigionieri e bagagli.
|
|
Disfida di
Barletta
Vedi storia completa
Luogo:
Contrada S. Elia,
tra Andria e Corato.
Data:
13 FEBBRAIO 1503
Contendenti:
13 cavalieri italiani contro 13 cavalieri francesi
Esito: Vittoria
italiana.
|
Battaglia di Seminara
Luogo: Piana di Gioia Tauro
Data: 21 aprile
1503
Contendenti: Regno di Francia contro Regno
di Spagna
Forze in campo: 400 cavalieri pesanti
spagnoli, 500 cavalieri leggeri, 5000 fanti delle Asturie, per i
francesi 300 cavalieri pesanti scozzesi, 600 cavalieri leggeri,
1.500 fanti svizzeri, 700 balestrieri francesi, 800 fanti italiani.
Esito: sconfitta totale dei francesi
|
|
Battaglia di Cerignola
Luogo: Cerignola, Foggia 30 km.
all’interno della costa adriatica
Data:
28 Aprile 1503
Contendenti: regno di Francia con l’ausilio di mercenari
svizzeri contro Regno di Napoli
Forze in campo: Spagnoli: 700 uomini
d’arme italiani e spagnoli, 800 cavalli leggeri, 5000 archibugieri e
balestrieri, 2000 lanzichenecchi. Francesi: 700 uomini d’arme, 1100
cavalli leggeri, 3500 fanti svizzeri, 3000/3500 fanti francesi ed
italiani
Esito: sconfitta francese. Fra i
francesi sono uccisi 50 uomini d’arme e più di 3000 fanti; sono
inoltre fatti prigionieri 600 uomini. Gli spagnoli non devono
lamentare in tutto che la perdita di un centinaio di uomini, fra
morti e feriti.
|
|
La battaglia di Cerignola, del
28 aprile 1503, si inquadra nel
conflitto intercorrente tra Francia e Spagna per la suddivisione del
Regno di Napoli e nello specifico le due potenze si contendevano la
Capitanata, l’attuale territorio della provincia di Foggia, che i
francesi volevano accomunare all’Abruzzo e gli spagnoli ritenevano
invece facente parte della Puglia. Il destino dell’Italia
Meridionale era stato deciso con il trattato di Granada, stipulato
nel 1500 tra Luigi XII da parte francese e Ferdinando il Cattolico
da parte spagnola, in detto trattato si prevedeva la suddivisione
del Regno di Napoli in quattro province: Campania, Abruzzo, Puglia e
Calabria ed assegnando Campania ed Abruzzo alla Francia e Puglia e
Calabria alla Spagna, non si tenne però conto della provincia di
Basilicata e Capitanata, create da Alfonso I. Per il suo
collegamento naturale con l’Abruzzo e per il fatto che vi si
praticasse la transumanza, ossia il far svernare le greggi dal
freddo e appeninico Abruzzo alla ben più mite Capitanata, la Francia
voleva che questa provincia fosse inquadrata sotto l’Abruzzo, sotto
il loro dominio e accomunato dalla questione della pastorizia,
mentre per gli Spagnoli la Capitanata era inquadrata a tutti gli
effetti sotto la Puglia e non andava toccata. Erano già in atto
delle scaramucce di confine tra i rispettivi eserciti, quando nel
pomeriggio del 27 aprile 1503 l’esercito spagnolo parte dalla
fortezza di Barletta e si dirige verso Cerignola, passando la notte
a Canne. Il giorno successivo iniziò ad un cruentissimo scontro con
l’esercito transalpino. L’esercito spagnolo era composto da 700
uomini d’arme italiani e spagnoli, 800 cavalli leggeri, 5000
archibugieri e balestrieri, 2.000 mercenari lanzichenecchi e 20
pezzi d’artiglieria.
Mentre i francesi avevano: 700 uomini d’arme, 1100 cavalli leggeri,
3500 fanti svizzeri, 3000-3500 fanti francesi ed italiani e
circa 40 cannoni.
Nonostante le
forze francesi fossero preponderanti, il comandante spagnolo Gonzalo
Fernandez de Cordoba seppe sfruttare alcuni vantaggi geografici che
il campo gli offriva e seppe utilizzare al meglio la combinazione
offensiva tra picchieri e cavalleria. Gonzalo diede una parte
importante nella gestione della battaglia a Prospero e Fabrizio
Colonna, che erano a capo della cavalleria, ma si occuparono anche
del piano di costruzione di alcune fortificazioni campali, che
ebbero un’importanza fondamentale per la vittoria spagnola. Lo
schieramento francese era composto centralmente dalla cavalleria
pesante e dalla temibile fanteria svizzera, i picchieri, essi erano
talmente temuti che Machiavelli spesso si poneva il problema di come
riuscire a sconfiggerli in campo
aperto. Trovandosi di fronte questo schieramento possente, e
schierato il proprio esercito su una posizione sopraelevata
i fratelli Colonna fecero
anche allargare un lungo fossato e fecero costruire un terrapieno su
di esso, rinforzandolo con piccole opere in muratura e ponendo pali
acuminati nel fondo. Dietro di esso fu posta la fanteria, con i
lanzichenecchi in posizione centrale, e grossi contingenti di
archibugieri e balestrieri sui lati.
Inoltre sui lati dello schieramento fu posta la cavalleria leggera,
mentre Prospero Colonna, al comando della cavalleria pesante,
attendeva dietro, con funzione di riserva. I francesi, sicuri di
riuscire a sfondare la sottile linea difensiva spagnola,
effettuarono un attacco frontale insieme agli svizzeri, ma non
avevano valutato con attenzione il
complesso dispositivo iberico. Iniziato l’attacco, la cavalleria
pesante francese e poi gli svizzeri rimasero bloccati nel fossato e
sottoposti al tiro incrociato degli archibugi che, sparando a
distanza tanto ravvicinata risultarono devastanti, tanto che vi morì
anche il comandante francese, il duca di Nemours. Una volta
scompaginato il temuto quadrato di picche svizzero e posto nel caos
lo schieramento francese, per la morte del loro comandante,
intervennero la cavalleria italiana e spagnola che portarono a
termine la sconfitta totale dei francesi.
La battaglia di Cerignola
rimarrà nella storia, sia perché sarà la prima battaglia campale
vinta da reparti dotati di armi da fuoco, sia perché determinò il
successivo andamento della guerra nel Regno di Napoli. I francesi,
demoralizzati da questa sconfitta, iniziarono a ritirarsi, e furono
nuovamente battuti sul Garigliano alla fine dello stesso anno.
Un’altra particolarità di questa battaglia furono la contribuzione a
segnare la fine del predominio della cavalleria, che non era più la
protagonista del campo di battaglia, e la crescita d’importanza
della fanteria. Combatterono delle unità di fanteria chiamate
Coronelias, armate di picche, spade e archibugi, quindi
diversamente equipaggiate rispetto a quello classico che vedeva un
tipo di arma per ogni reparto. Queste unità sono considerate
precursori del successivo e famoso tercio, l’unità di
fanteria per eccellenza dell’esercito spagnolo. Esso rappresentava
l’unità di base dell’esercito, essendo il prodotto dell’evoluzione
della fanteria sui campi di battaglia del ‘500. Già dalle guerre
d’Italia, i teorici della guerra studiavano un’integrazione
dell’unita di fanteria che potesse rispondere a determinati bisogni
quali: una potenza di fuoco elevata, da affidare agli archibugi, una
protezione elevata in caso di assalto all’arma bianca, da affidare
ai picchieri e infine una rapida versatilità della squadra, che
doveva passare dalla difesa all’attacco in poco tempo.
Il
tercio era in grado di soddisfare a
tutti questi bisogni.
Esso comprendeva, oltre ad un distaccamento di cavalleria leggera ed
una dotazione di artiglieria, circa 3.000 fanti suddivisi in dieci
compagnie. All’inizio il tercio era composto da metà di
uomini dotati di archibugio e metà di picche, ma successivamente gli
archibugieri raggiunsero i due terzi
del totale.
La fanteria
spagnola stava evolvendosi, già in vantaggio per quanto riguarda
l’abilità nell’attacco e nella difesa di fortificazioni, in seguito
ottenendo una superiorità rispetto a quella di altre nazioni in una
serie di operazioni, valutate poco nobili ma indispensabili nella
condotta di una guerra quali: imboscate, attacchi improvvisi o
incursioni di piccoli reparti che erano impossibili da effettuare
per un reparto pesante e poco maneggevole quale il quadrato di
picche elvetico. I combattenti della fanteria non erano colpiti da
quel senso di inferiorità che poteva avere il fante plebeo rispetto
all’aristocratico cavaliere. Il mestiere delle armi, con
l’arruolamento nella fanteria, poteva essere anche occasione di
riscatto sociale, infatti i contadini che servivano il re
imbracciando un archibugio sviluppavano un giusto orgoglio
professionale che li rendeva agli occhi del popolo degli specialisti
della guerra, con prospettive di carriera e di onore all’interno
dell’esercito e non dei combattenti di seconda scelta. Questa
visione doveva essere generale e non solo spagnola, se addirittura
Francois de La Noue, uno dei maggiori esperti militari ugonotti,
consigliava ai giovani francesi come esempio di virtuosa e austera
vita comunitaria, di onorevoli costumi e di valore che poteva
provenire dall’organizzazione dei famosi “tercios” di
Spagna. |
|
|
Battaglia del Garigliano
Luogo: nei pressi del fiume Garigliano,
tra Gaeta e Suio
Data:
29 dicembre 1503
Contendenti: regno di Francia contro
Spagna.
Forze in campo: Spagnoli: 900 uomini
d’arme, 1000 cavalli leggeri, 8500/9000 fanti spagnoli, 100 schioppettieri, 2000 picchieri tedeschi. 25.000 uomini da parte
francese.
Esito: vittoria riportata dai fanti
spagnoli/tedeschi e dalla cavalleria leggera sulla fanteria
svizzera. La sconfitta francese è dovuta alla scarsa unità di
intenti fra i condottieri italiani e francesi. Tale sconfitta aprirà
alla Spagna le porte per la conquista totale dell’Italia meridionale.
Francesco
Sorrentino olim Molignani
si distinse nella
battaglia tanto da ricevere diploma dal
re Ferdinando il Cattolico
nel 1507, fu riconosciuto, creato e dichiarato nobile per sé e per i
suoi discendenti.
|
|
**
Copyright © 2007
www.nobili-napoletani.it
-
All rights reserved
|
|