|
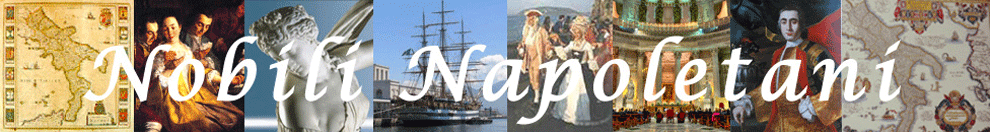
Ovvero delle Famiglie
Nobili e titolate del Napolitano, ascritte ai Sedili
di Napoli, al Libro d'Oro Napolitano, appartenenti
alle Piazze delle città del Napolitano dichiarate
chiuse, all'Elenco Regionale Napolitano o che
abbiano avuto un ruolo nelle vicende del Sud Italia.
|
|
Arma:
degli Angelo o de Angelis di Napoli:
d’azzurro, alla fascia d’oro accompagnata da due stelle ad otto
punte dello stesso;
degli Angelo o de Angelis di Trani, Bari, Matera e Tropea:
d’azzurro, a tre fasce d’argento:
de Angelis Effrem: partito, nel 1° d'azzurro, a tre fasce
d'Argento (de Angelis), nel 2° d'azzurro, al leone d'oro
accompagnato in capo da un lambello a 5 pendenti di rosso ed
attraversato da una banda del medesimo caricata da tre foglie di
palma d'oro (Effrem).
Cimiero:
un angelo.
Motto:
IN HOC SIGNO VINCES.
Titoli italiani:
baroni di: Campomarino, Carbonara, La Rocchetta sul
Volturno, Castel Astruso, Finocchieto;
marchesi di: Bertolino, Ceglie 1633, Paupisi, S. Agapito 1680,
Torre Ruggiero 1797, Trentanara 1710;
duchi di: Garona, San Donato 1711, sul cognome.
principi di: Bitetto 1649, Mesagne 1647. |
|
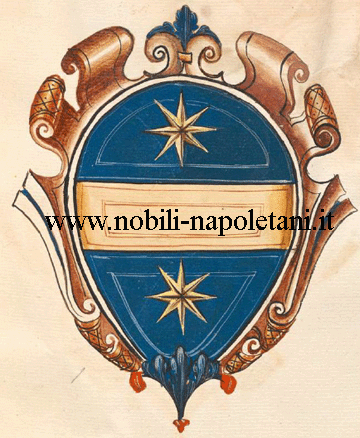
Stemma famiglia Angelo |
|
L’antichissima e nobilissima famiglia Angelo o Angelo
Comneno, di origine greca, della stirpe di Isacco
Angelo, proclamato imperatore d’Oriente nella Chiesa di
Santa Sofia a Costantinopoli il 31 agosto 1057, si
diramò in Italia dove innalzarono piu’ armi e furono
chiamati Angelo, d’Angelo, Angiolo, Angeli, degli
Angeli, o piu’ comunemente de Angelis.
In Italia ha goduto di nobiltà in Napoli nel
Seggio di Porto,
in Trani nel Seggio del Campo dei Longobardi, in Bari,
in Tropea nel Seggio di Portercole, e nelle città di
Amalfi, Foggia, Catanzaro, Ancona, Como, Teano,
Avellino, Aquila, nel Cilento ed in diverse altre città.
Ha posseduto numerosi feudi tra i quali: Albano, Alveto,
Aprigliano, Mitetto, Campomarino, Campora, Capriglia,
Carbonara, Castel Astruso, Cellino, Colledimacine,
Convincenti, Cosentino, Crepacore o Allegrocore,
Dogliola, Erchie, Fontana, Friano o Priano, Galesano,
Giordano del Tufo, Guarazzano, La Balzana, Lo Godio,
Lucugnano, Luzzi, Macchiagodena, Macile, Monterone,
Muro, Piesolo, Porcili, Portolania del Piano di
Sorrento, Rocchetta sul Volturno, San Benedetto, San
Donato Val di Comino, San Giorgio, San Martino,
Santangelo, Santarcangelo, Santattanasio, Sillirari,
Suborli, Tiriolo, Tobiano, Torre S. Susanna, Vaglio. |
|
Altre
varianti delle armi dei d'Angelo, Angelo e de Angelis: |
|
La
famiglia de Angelis fiorì anche in
Calabria Citra,
a Terranova (oggi comune di
Terranova da Sibari in provincia di Cosenza) con le
famiglie: Musitano, Ferraris, Falconieri, Greco, de
Corrado, de Rosis, de Leo,
de Simone,
de Stasio, Scaramuzza. |
|
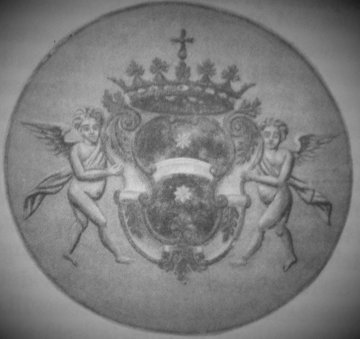
Terranova, stemma de Angelo.
Foto di A. Manna, tratta da “I
Sanseverino
e il feudo di Terranova” a cura di Antonello Savaglio |
|
,%20lastra%20tombale%20della%20Famiglia%20De%20Angelis.gif)
Diocesi di
Rossano-Cariati (Cosenza), lastra tombale della Famiglia
de Angelis |
|
,%20lastra%20tombale%20della%20Famiglia%20De%20Angelis%20-.gif) |
|
La famiglia ha vestito l’abito
di Malta ed ha avuto gli ordini di Calatrava
di S. Stefano e quello
Costantiniano.
Si ha memoria in Amalfi di un Landolfo Angelo al
quale l'imperatore
Federico II di
Svevia aveva concesso, per sé e i suoi
fratelli, alcuni privilegi e l'immunità dal pagamento di
tributi, da ogni contribuzione e da ogni servizio. In
quel tempo molte famiglie amalfitane che per ragioni di
commercio vivevano in Costantinopoli, per sfuggire l'ira
dei Crociati, i quali, dopo ostinata resistenza, si
erano impadroniti della imperiale città depredandola e
saccheggiandola, abbandonando il loro fondaco e la
Chiesa di Sant'Andrea, si rifugiarono in Amalfi traendo
seco più famiglie greche. Da Amalfi il casato si diramò
in molte città d’Italia; un ramo passò in Napoli e
stabilì il domicilio nella Ottina Sinoca presso una
delle quattro Parrocchie greche detta di S. Maria in
Cosmodin, oggi S. Maria di Portanova, ritenendo il cognome
d’Angelo. |
|
 |
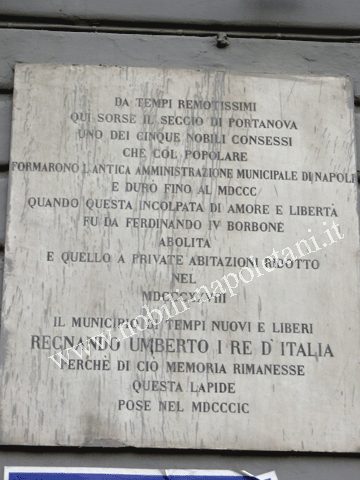 |
|
Napoli, l'antichissima
Chiesa di
S. Maria in Cosmodin, accanto al Seggio
di Portanova |
|
L’Imperatore Isacco II
Angelo Comneno
(1) fu il primo a chiamarsi Angelo-Comneno, perché
si considerò erede anche per matrimonio della grande
famiglia dei Comneno.
Dopo la caduta dell’Impero Latino d’Oriente, si
costituirono vari Despotati, vale a dire regni
indipendenti, ai quali accedettero le antiche Famiglie
Regnanti sul Trono Imperiale di Bisanzio. Ma, senza
dubbio, di tutti i Despotati uno dei più grandi fu
quello di Epiro e di Tessaglia, anch’esso degli
Angelo-Comneno.
Il generale Michele
Paleologo,
abilissimo politico, il 1° gennaio 1259, grazie ad una
congiura di palazzo, si fece eleggere Imperatore e
Grande Correttore di Nicea con l’impegno solenne di
rendere il potere imperiale a Giovanni IV Lascaris al
momento del raggiungimento della maggiore età.
Il Despota (sovrano) Michele II Angelo-Comneno,
appreso della morte del piccolo Giovanni IV Luscaris ad
opera del Paleologo, diede una svolta nella sua
politica, avendo compreso fin dal 1255 che il Paleologo
non avrebbe arrestato la sua spinta in avanti se non
quando avesse completato la conquista di tutta la Grecia
e occupato il trono di Costantino il Grande, di cui si
consideravano eredi legittimi solo gli Angelo-Comneno.
Così, per proteggere il suo Despotato, giudicò prudente
concludere alleanze con sovrani e capitani celebri. A
tal fine nel 1255 diede in sposa la sua figliola
Elena o Eleonora
(2), allora di appena tredici
anni, a Manfredi figlio naturale dell’Imperatore di
Germania Federico II e Re di Sicilia. Nel 1259 fu la
volta della seconda figliola di Michele II, cioè Anna,
ad andare sposa a Guglielmo di Villehardouin, principe
di Acaia, uno dei più potenti feudatari latini in
Oriente.
Michele Paleologo inviò contro Michele
II Angelo-Comneno un’armata sotto gli ordini di suo
fratello Giovanni; occupò Vodena, s’impadronì di quasi
tutta la Macedonia Occidentale, prese la città di Devoli
in Albania e di là avanzò minacciando Berati. La marcia
dei soldati di Nicea fu arrestata dalle armate di Re
Manfredi, giunte dalle Puglie d’Italia, e dai soldati
della Morea agli ordini di Guglielmo di Villehardhouin
di Acaia.
Nell’ottobre del 1259 fu combattuta una battaglia
decisiva nella piana di Pelagonia nella regione
superiore della Cerna (Erigon), nella quale tutto quello
che restava dell’armata di Michele II Angelo-Comneno
venne pressoché annientato. Con tale vittoria il
Paleologo consolidò la propria posizione sul trono di
Nicea, il che gli ritornò utile per tentare la
successiva conquista del resto dei domini di Michele II
Angelo-Comneno. Nel 1261, dopo la caduta degli
Imperatori Latini di Oriente, quando Alessio Melisseno
ebbe conquistato Costantinopoli, il Paleologo si
proclamò Imperatore assumendo il nome di Michele VIII. La
lunga lotta tra i Niceani e gli Epiroti terminò con la
pace del 1263, ratificata nel 1264 tra Michele VIII
Paleologo, Michele II Angelo-Comneno di Epiro e di
Tessaglia, e Guglielmo II Villeharhouin.
Con il suddetto trattato Michele II Angelo-Comneno
riconobbe i diritti del Paleologo sul Trono di
Costantinopoli ma ottenne però, a sua volta, il
riconoscimento completo della sovranità sui domini di
Oriente, appartenenti al proprio Regno (Despotato), per
lui e per tutti i suoi eredi e successori “lato verbo”,
e, nella più completa accezione della parola, i diritti
e i privilegi pertinenti ai discendenti degli Imperatori
di Oriente. Tra l’altro, il Paleologo riconobbe agli
Angelo-Comneno del Despotato di Epiro e di Tessaglia,
oltre i diritti sovrani generali, anche la facoltà in
perpetuo, per sé e per tutti i suoi eredi e successori
all’infinito “lato verbo”, di nominare “ …duchi e altri
signori inferiori”
(3). |
|
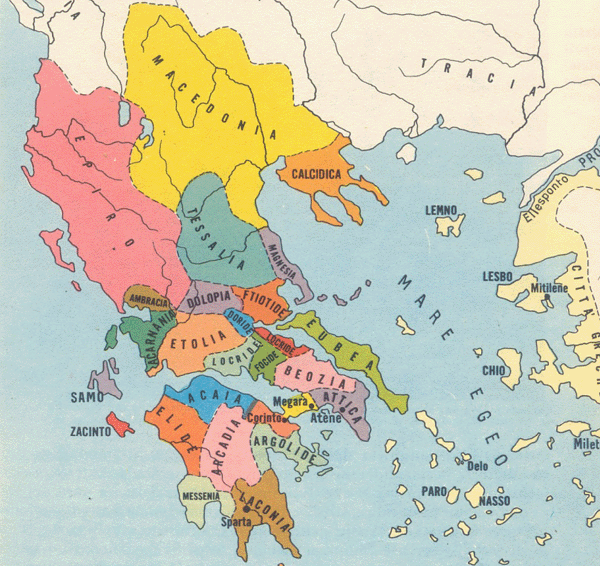
Cartina geografica della
Grecia dell'anno 1200 circa |
|
Michele II Angelo-Comneno (†
1271), visse per lunghi e alternati periodi in Italia. E
fu in Italia che gli nacque il maschio, di nome
Giovanni, probabilmente verso il 1233 o 1235. Un
altro figlio Giovanni detto Il bastardo lo aveva
avuto in precedenza da una concubina. Michele II aveva
avuto parecchi figli: Niceforo I, il primogenito,
divenne Despota alla morte del padre; Giovanni,
principe di Tessaglia; Elena o Eleonora;
Anna, maritata a Guglielmo II Villebardhouin e,
in seconde nozze (1280) a Nicolas Saint Omer;
Demetrio Catuli, detto Michele, sposò Anna Paleologo,
figlia di Michele VIII, e, in seconde nozze, la figlia
di Terteros, re dei Bulgari; un’altra figlia (di cui non
si conosce il nome), passò a nozze con il principe dei
Bulgari Alessio Raoul; Teodoro, detto “il
Bastardo”, deceduto nel 1267; infine, Giovanni
“il Bastardo”, grande condottiero.
Il summenzionato Giovanni, principe di Tessaglia,
secondo figlio di Michele II, dopo aver combattuto in
giovanissima età sotto le bandiere del padre, seguì la
sorella Elena o Eleonora in Italia, in occasione del
matrimonio di questa con Re
Manfredi di Svevia
(4).
Il 4 aprile 1252, contrasse nozze con Beatrice
Ruffo di Calabria,
figlia di Pietro conte di Catanzaro, la quale gli portò
in dote la signoria di Rocchetta sul Volturno per rogito
notar Nicola di Brindisi. Da dette nozze nacque nel
1254 Bartolomeo, sposo di Giulia Comneno, sua
prossima parente. Nel 1256 suo cognato Re Manfredi gli
concesse il feudo di Campo Marino. Nei diplomi re
Manfredi chiama Giovanni Angelo-Comneno “nostro
amatissimo consanguineo“ e “ nostro cognato bene amato”.
Re Manfredi morì nella battaglia svoltasi a Santa Maria
della Gradella contro
Carlo d’Agiò.
La moglie di Manfredi, Elena o Eleonora (†
Napoli, 1271), fu imprigionata nel Castel dell’Ovo a
Napoli insieme ai quattro figli. Scampò alla morte solo
uno dei figli di Eleonora, vale a dire la piccola
Beatrice, per l’intercessione di Giovanni
Angelo-Comneno, fratello di Elena o Eleonora, sfuggito
all’arresto durante la prima repressione. La fanciulla
venne ricevuta e protetta da Costanza, nata dal primo
matrimonio di Manfredi. Nel 1286 la giovane sposò
Manfredi IV, marchese di Saluzzo.
Il già citato Giovanni Angelo-Comneno entrò nei
favori di Carlo Angiò per aver prestato al sovrano un
ingente somma di denaro. Anche Tommaso d’Angelo
prestò una forte somma di denaro al predetto sovrano
insieme a Falcone
Spina e
Filippo
Rocco.
L’illustrissimo Bartolomeo
Angelo-Comneno (1254 † 1321), figlio di Giovanni e di Beatrice
Ruffo di Calabria, fu cinto cavaliere ossia ebbe il
cingolo militare nel giorno della Pentecoste del 1272
per la venuta a Napoli della seconda moglie di Carlo I
d’Angiò
(5).
Nel 1289 il principe Bartolomeo fondò l’Abbazia di San
Benedetto nei pressi di Capua, elevata da Papa Nicolò IV
a beneficio e patronato della Casa Angelo-Comneno, e ad
“Abbatia nullius”. Con atto per notar Dionisio di Sarno
del 5 ottobre 1289, il principe Bartolomeo nominò Abate
di San Benedetto di Capua il suo secondo figliuolo
Benedetto, nomina confermata dalla Santa Sede.
|
|
Guglielmo (1285 † 1349), primogenito di Bartolomeo, nel
1309 venne aggregato al
Seggio di Porto
in Napoli; ricevette solennemente in Napoli, quale
delegato e sindaco,
Roberto II d'Angiò
re di Napoli. Nel 1325 sposò Angela
Dukagina. Il 17
maggio 1326 accompagnò Walter, duca di Atene e conte di
Brienne, a Firenze in rappresentanza di Carlo Senza
Terra, duca di Calabria, figlio di Re Roberto II,
chiamato dalla Signoria di Firenze a governare la città
quale “Signore nominale e Protettore”. |
|
|

Guglielmo Angelo Comneno,
principe di Tessaglia - 1329
Per gentile concessione dell'avv.
Alessio Ferrari Angelo Comneno |
|

Stemma di Pietro Angelo -
Anno 1699
Per gentile concessione dell'avv.
Alessio Ferrari Angelo Comneno |
|
Guido
(1329 †
1407), figlio di Guglielmo, sposò una nobile donna della
Casa Thopia. Fu consigliere militare di
Re Carlo III di
Durazzo dal quale ottenne il comando di “400
Lance”. Scortò poi il Re in Ungheria, dove questi cinse
la corona di Santo Stefano. Durante la lotta tra i
“durazziani”, fedeli a Ladislao di Re Carlo III, e gli
“angioini”, fedeli a Luigi d’Angiò, il principe Guido
Angelo-Comneno si schierò, con i suoi armati a fianco di
Ladislao, che, vincitore, fu coronato Re a Gaeta nel
1390.
Angelo (n. 1386 †
6-10-1480), figlio di Guido, sposò Agnese Span. Nel 1435
fu segretario e uomo di fiducia della
Regina Giovanna II
di Napoli, che lo nominò anche Signore di Pirano. Il
Mazzella, parlando di questo Principe, scrive: “Egli
godè di una grande reputazione presso la regina Giovanna
II. Fu Signore prudente, colto, e, per la sua capacità e
dolcezza naturale, la regina lo nominò suo segretario
donandogli molte rendite”. Più tardi, il suddetto Angelo
fu segretario anche del
Re Alfonso d’Aragona,
dal quale ricevette la donazione di “36 once annue sulla
bagliva e fiscalità di Guardia Grele, con il pagamento
di una spada del valore di un’oncia”. Nel 1463 il
principe Angelo de Angelo-Comneno designò come abate di
San Benedetto a Capua il suo Consanguineo Paolo,
arcivescovo di Durazzo, poi Cardinale di Santa Romana
Chiesa. La designazione venne ratificata da Papa PIO II,
al secolo Enea Silvio Bartolomeo
Piccolomini
il 4 agosto 1463. Il cardinale Paolo Angelo-Comneno ebbe
una grande influenza sul Papa Pio II, che egli insieme
al Despota Tornmaso Paleologo esiliato in quel tempo a
Roma spinse a una crociata contro i Turchi. Sempre il
suddetto cardinale fu inviato poi dal Pontefice quale
ambasciatore presso Giorgio
Skanderbeg,
il quale simpatizzò tanto con lui da affidargli, quale
precettore, suo figlio Giovanni. IL principe Angelo
venne sepolto nella Chiesa di Santa Maria della Nova a
Napoli. La tomba fu fatta erigere da uno dei figlioli,
Battista Antonio, divenuto abate di San
Benedetto a Capua al posto dell’arcivescovo Paolo che
aveva dovuto lasciare la carica essendo stato eletto
cardinale. La cappella,
dove sono sepolti la maggior parte degli Angelo Comneno
del ramo napoletano e tutti i componenti delle
principali famiglie con le quali i d'Angelo
s'imparentarono
andò distrutta a causa del terremoto del 1538. |
|

Napoli, stemma partito
con le insegne Severino e Angelo, famiglie imparentate |
|
Bartolomeo
(1436 †
1511), figlio di Angelo, sposò Eleonora
Carafa il
3 settembre 1461. Da tali nozze nacque 1’8 giugno 1463 Benedetto
che sposò il 17 gennaio 1484 Isabella
Coppola,
figlia di Francesco, conte di Sarno, e di Eleonora
Caracciolo.
Benedetto ricevette in dote “ La Balzana”, una terra
presso Capua. Ebbe due figli: Andrea, nato nel
1485, e Geronimo, nato nel 1487. Andrea sposò il
9 marzo 1538 Giovannotta
Piccolomini,
figlia di Roberto (discendente dei Papi Pio II e Pio III);
il 4 gennaio 1541 ottenne una compagnia di 300 lance da
Alfonso
Avalos,
marchese del Vasto e capo supremo dell’armata di
Carlo V;
morì con il grado di colonnello alla
presa della Goletta.
L’imperatore stesso, di suo pugno, scrisse alla vedova
Giovannotta Piccolomini esaltando l’eroismo del
principe.
IL figlio primogenito di Andrea, Fabrizio, nato nel
1539, permutò il 15 settembre 1571 “La Balzana” con
“Castel Petruso” nel Molise
(6);
sposò il 4 ottobre 1543 Eleonora
Macedonio,
figlia di Giovanni Vincenzo e di donna Camilla
Pappacoda,
ed ebbe in dote “Ducati 10.000 sopra il nuovo imposto
della seta di Calabria, che li doveva il
principe di
Bisignano”.
Fabrizio nominò Abate di San Benedetto a Capua un suo
parente, Domenico, nomina confermata da Papa
Gregorio XIII il 13 maggio 1574. Il figlio di Fabrizio,
cioè Giovanni Battista, sposò il 12 dicembre 1569
Eleonora Sansovino, figlia di Gaspare e di Ippolita
Guindazza,
discendente di Antonio o Cecco Antonio, ambasciatore del
re Federico III. Questo Giovanni ebbe a sua volta due
figli: Geronimo e Fabrizio; quest’ultimo
divenne Abate di San Benedetto a Capua, mentre il primo
sposò Isabella Cifola o Sifola, dal quale matrimonio
nacque Francesco, andato sposo nel 1602 ad Anna
Strambone,
figlia di Orazio e di Lucrezia
da Gaeta.
Per mezzo di questo matrimonio Francesco entrò in
possesso dei feudi di Fontana, di Piesolo, di Godio
ecc.,. Uscito di senno
(7),
fece uccidere lo zio Fabrizio, “Abbate Nullius”
di San Benedetto. IL Papa Paolo V, non potendo procedere
contro di lui perchè dichiarato demente, lo esiliò e da
quel momento avocò alla Santa Sede la nomina degli
Abati di San Benedetto a Capua.
Geronimo (Napoli, 1487 †
ivi,1582), figlio di
Benedetto, già citato, sposò Maria de Bucchis
(8);
contro di lui, il 3 aprile 1529, fu elevata la terribile
accusa di lesa maestà
(9), perdendo tutte le sue terre e
feudi, ad eccezione della “Rocchetta sul Volturno”.
Fuggì a Roma, ospite del Papa, dove gli venne concesso
il titolo di “patrizio
romano” e il diritto di
cittadinanza
(10). Riabilitato, tornò a Napoli dove il
principe Geronimo insieme ad altre personalità ricevette
l’incarico di decidere l’ammissione dei nobili nei Seggi
di Napoli
(11).
Francesco (1510 † 1581), figlio di Geronimo,
venne ricevuto nel Seggio di Porto nel 1526. Il 7
febbraio 1531 sposò Rosa
Pisanelli.
Bartolomeo (7-3-1532 † 1598), figlio del principe
Francesco, sposò, in prime nozze, Lucrezia
Salimbeni il
3 aprile 1550, e, in seconde nozze, Maria Garagnani,1’8
luglio 1571.
Benedetto (4-1-1552 † 2-7-1612), figlio di
Bartolomeo, contrasse prime nozze con Marulla di Bari
nel 1589 e seconde nozze con Rosa de’ Tocci, detta “del
Piano” († 8-8-1610), discendente dalla famiglia sovrana
d’Oriente Tocco. Acquistò una rendita in perpetuo sui
“fiscali” di Scalea e di Verbicaro con atto in data 3
gennaio 1610 del notaio Bartolo Giordano di Napoli; con
testamento datato 10 giugno 1611 nominò erede universale
il figlio Giovanni Battista (n. 28-12-1609), ma
dispose un legato di 800 ducati in favore del parente
Antonio de’ Tocci (o
de Tocco), di 300 ducati in favore
di Annibale Bianchi, e una di 150 ducati in favore di
Francesco
de Gennaro.
Giovanni Battista nacque nelle Marche dando origine al
ramo della Marche Anconetane. |
|
La famiglia de Angelis
nobile di Teano,
ottenne da Carlo II il titolo di
marchese di S. Agapito,
feudo in
Terra di Molise,
si estinse nella famiglia
Caracciolo Pisquizi,
a seguito di matrimonio celebrato nel 1731 tra
Lucrezia de’ Angelis (†
24/04/1758), figlia ed erede di Ignazio marchese di
Sant’Agapito e di Giulia de Renzis, e Eustacchio
Caracciolo (1714 †
1793), patrizio napoletano, principe di Pettoranello.
|
|
I de
Angelis nel 1620 acquistarono il palazzo-fortezza di
Altamura (BA) che apparteneva alla famiglia
Orsini de Balzo;
successivamente passò alla famiglia
Viti. |
|

Altamura (BA) - Palazzo de Angelis
© foto: Carlo Longo de Bellis |

Altamura (BA) - Palazzo de Angelis
© foto: Carlo Longo de Bellis |
|
Pirro
de Angelis,
patrizio di Trani,
diede origine a tre diversi rami:
1) - la città di
Bitetto, in
Terra di Bari,
nel 1629 fu venduta dal Sacro Consiglio, ad istanza dei
creditori di Alfonso Caracciolo, per ducati 40.200 a
Flaminio de Angelis,
marchese di Ceglie,
piccola terra in Provincia di Bari. e vi ebbe poi il
titolo di
principe nel
1649.
Benedetta de Angelis, sorella ed erede di
Carmine (†
1721),
principessa di Mesagne
(feudo in
Terra d’Otranto),
principessa di Bitetto,
marchesa di Ceglie,
marchesa di San
Chirico,
marchesa di Paupisi,
baronessa di Finocchieto,
sposò Giovanni Lorenzo
Pappacoda (†
1715), patrizio napoletano, 2° principe di Triggiano e
7° marchese di Capurso. Il loro figlio, Nicola (†
1741), marito di Porzia
Tuttavilla,
figlia di Orazio duca di Calabritto, ereditò beni e
titoli dalla madre.
2)
- Il titolo di
marchese di
Trentinara,
feudo in
Principato Citra,
fu concesso il 4 marzo 1710 a Leone de
Angelis, patrizio di Trani (21 luglio 1739), che viveva
a Sorrento. Il titolo passò in casa di Goyzneta a
seguito di matrimonio celebrato tra Maria Giuseppa
de Angelis (n. Napoli, 1841), figlia ed erede di
Giuseppe (Napoli, 1809 †
ivi,
1904), e il nobile Ernesto di Goyzneta, dei marchesi di
Taverna.
3) – Giovanniantonio, patrizio di Trani, fratello
del summenzionato Pirro, si stabilì a Foggia verso il
1550; un suo discendente, Girolamo, nel 1700 da
Foggia si stabilì a Bari dove nel 1749 fu ascritto al
patriziato di detta
città. Sposò Anna Teresa Effrem, ultima
discendente di antica famiglia greca; i solo discendenti
aggiunsero al proprio il cognome della famiglia Effrem,
inquartando le armi. |
|

Stemma de Angelis Effrem
Per gentile concessione del dr. Giuseppe Pizzuti |
|

Napoli, stemma de Angelis
Effrem dipinta su mattonella porcellanata |
|
I de
Angelis Effrem ottennero nel 1749 il
titolo di
marchese di Torre Ruggiero e nel 1804 l’ascrizione
al
Registro Piazze Chiuse nella persona di
Girolamo,
il quale ebbe per sorelle:
Teresa,
sposata al Cav. Francesco Olivieri, e
Maria,
sposata al Cav. Giuseppe Bifani.
Il marchese Girolamo sposò Amalia Sava ed ebbero per
figli:
Isabella,
Giulia,
Anna,
Teresa,
Maria,
Angela,
Rachele,
Luigi,
ed il primogenito marchese
Cesare
de Angelis Effrem di Torre Ruggero (Napoli, 1861 † ivi,
1944), patrizio di Bari e patrizio di Trani, sposò a
Napoli nel 1887 Maria Teresa
Giusso dei duchi del Galdo (Napoli, 1868, † ivi,
1944).
|
|
I de Angelis di
Belvedere Marittimo, Bova e Brancaleone
a cura di Vincenzo de Angelis |
|
La famiglia De Angelis, che nel 1699 era presente nella
città di Bova e successivamente nell’ Università di
Brancaleone, originaria di Belvedere Marittimo. Dai
registri notarili presso l’archivio di stato di Cosenza,
notaio d’Aprile, già intorno agli inizi del 1600, la
stessa era presente a Belvedere Marittimo ma, non
sappiamo precedentemente da quale ramo provenisse e da
quale città. |
|
In Belvedere Marittimo la famiglia de Angelis, presente
già nel XVII secolo, era imparentata con le famiglie
Lancellotta,
Grosso,
Gaudiosi
e faceva parte della
nobiltà locale.
Negli atti notarili i vari componenti della famiglia
vengono menzionati come magnifici. Il legame con la
famiglia Gaudiosi ha determinato e dato origine alla
stessa famiglia che ha goduto nobiltà oltre che in
Belvedere, nella città di
Bova e
Brancaleone.
La famiglia de Angelis arrivò a Bova da Belvedere
Marittimo nel 1699 con Giovanbattista, marito
della nobildonna Vittoria Gaudiosi, sorella del vescovo
di Bova, Francesco Antonio. Per alcuni decenni mantenne
rapporti con la terra di Belvedere Marittimo attraverso
la parentela rimasta e a tutelare gli interessi di
famiglia. A Bova fece parte della confraternita del
Santissimo Sacramento, confraternita istituita dalle
nobili famiglie bovesi nel 1574 e da loro in seguito
mantenuta. Uno dei figli di Giovanbattista, Cesare
de Angelis era già sacerdote a Belvedere Marittimo e nel
1702 ebbe un incarico importante, fu nominato vicario
della contea di Bova, diocesi vescovile. Altri figli di
Giovanbattista erano Domenico, il quale sposò la
nobildonna Antonia Caffarelli, figlia del barone
Caffarelli (erario del duca di Bruzzano Vincenzo
Carafa),
che abitava il castello di Bruzzano. Antonia Caffarelli,
dopo aver avuto sei figli rimase vedova e, in seconde
nozze sposò Giuseppe Amodei, sindaco dei nobili di Bova
e, con quest’ultimo ha avuto altri due figli. Un’altra
figlia di Giovanbattista, Lucrezia, sposò
Giuseppe
Marzano
di Bova, fratello del vescovo don Domenico, prima
vescovo di Strongoli e poi di Bova. Lucrezia ebbe
quattro figlie femmine, una delle quali, Venanzia, sposò
il cugino Giuseppe Marzano, duca di Sessa, il quale era
il discendente del ramo principale di Marino Marzano,
marito di Eleonora, figlia di
Alfonso V d’Aragona
e sorella del re Ferdinando II. L’altra figlia
Caterina de Angelis sposò il nobiluomo Giovanni
Fiati di Bova, appartenente a un’antica famiglia Bovese.
I figli di Domenico e Antonia Caffarelli erano
Francesco, primogenito che fu canonico di Bova e in
quel periodo, (come
scrive Antonio Chilà nel libro “diocesi di Bova dalle
origini al 1986” pubblicato dalla Rubbettino)
fare il
canonico, era un ruolo molto importante, pieno di
responsabilità. Vittoria, altra
figlia, sposò Costantino Natoli di Bova. Leo,
Anna e Cecilia Paola morirono giovanissimi.
Antonino, secondogenito maschio, sposò Fortunata,
figlia del barone Giovanbattista de Lorenzo e della
nobildonna messinese Caterina
de Simone,
che vivevano a Brancaleone. Per matrimonio, la famiglia
de Angelis, si sposta a Brancaleone. Nel vecchio borgo
di Brancaleone acquisì da subito il diritto di
tumulazione all’interno della chiesa proto papale
dell’annunziata, in più possedeva una chiesa cappella
nel fondo denominato Martello, di proprietà di don
Vincenzo de Angelis, (con annotazione 6 marzo 1793
archivio di Stato Reggio Calabria) e il festeggiamento,
ogni anno, della Madonna dell’Immacolata. L’urna
cineraria della famiglia, all’interno della chiesa proto
papale, era ricoperta da una lastra marmorea e su di
essa era scolpito lo stemma della famiglia: un’aquila
con due teste a sinistra, una palma a destra e sotto una
torre con sopra una stella. |
|
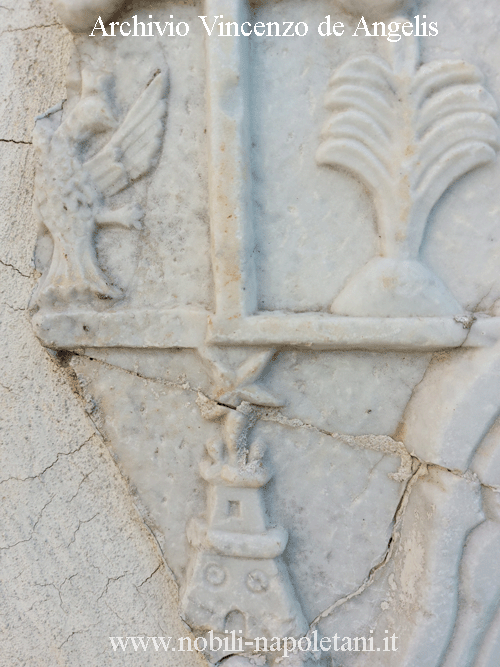
Chiesa proto papale di Brancaleone, stemma de Angelis |
|
Dal loro matrimonio di Antonino e Fortunata nacquero
cinque figli: Francesco che intraprese la
carriera ecclesiastica diventando canonico, Teresa,
Carmosina, Ippolita che sposò il barone
Vincenzo Mesiti di Sant’Agata, territorio di Bianco e
Vincenzo che sposò la nobildonna Teresa Alati di
Montebello, figlia di Bartolomeo e della nobildonna
Isabella Romeo. Nei registri notarili presso l’archivio
di stato di Locri, Vincenzo de Angelis di
Antonino veniva menzionato con il titolo di cavaliere.
Da questo matrimonio sono nati cinque figli: Antonio
nato nel 1797, era un idealista e lottava contro il
sistema dei Borbone per ottenere la costituzione.
Antonio assieme a Vincenzo Mesiani, capo massa, Giovanni
Medici,
martire politico, che morì nelle prigioni di Procida in
seguito alle torture e, altri uomini dei vari paesi del
distretto di Gerace, si riunivano spesso e facevano
parte dell’organizzazione politica per l’insurrezione,
tutti al fianco del martire Rocco Verduci, uno dei capi
del moto insurrezionale del 1847. In “lotta e martirio
del popolo calabrese” scritto dal Visalli, Antonio De
Angelis risulta perseguitato politico. Antonio ha
sposato Anna, figlia del barone Fortunato
Bologna,
(erario della camera marchesale di Brancaleone, feudo
della famiglia
Carafa) e
della nobildonna di Reggio Calabria, Olivia
Miceli.
Dal loro matrimonio nacque Giuseppe il quale
sposò la nobildonna di Brancaleone, Fortunata Medici
figlia di Domenico Antonio e Francesca Ielasi. Altri
figli nati, morirono tutti in giovanissima età. Giuseppe
aveva una figlia che si chiamava Francesca, la
quale aveva sposato Giuseppe Argirò di Gioiosa.
Francesca, dopo il matrimonio, abitava a Gioiosa e
Giuseppe de Angelis padre, di tanto in tanto andava a
trovarla. Per andare a Gioiosa si spostavano con le
barche, via mare. Nelle terre di sua proprietà in
contrada Surbia vi erano due coloni, che pensarono di
gestire per conto proprio le terre ricavandone i
profitti. Escogitarono un piano, cioè il giorno che
Giuseppe doveva partire per Gioiosa, i due coloni
avevano fatto una fossa nel terreno e quando il
proprietario si recò da loro gli è stato chiesto di
valutare la fossa per la piantumazione di un albero.
Giuseppe si è avvicinato alla fossa e in quel momento è
stato colpito in testa e svenuto fu sotterrato vivo.
Dopo qualche giorno alcuni familiari e amici si
chiedevano dove si fosse cacciato, mentre i due coloni
dicevano a tutti che probabilmente il loro padrone era
annegato, mentre si recava dalla figlia a Gioiosa. I
parenti sapevano che in quel periodo non doveva recarsi
dalla figlia e si sono rivolti al maggiore Vitali, che
si era già insospettito e ispezionando il terreno ha
notato della terra smossa da poco in un punto della
proprietà. Il maggiore, proprio in quel punto fece
scavare e lì trovò il corpo di Giuseppe De Angelis,
deceduto nel 1883 per causa violenta. (riportato su
l’eco di Bergamo). |
|
Domenico
figlio di Vincenzo e Teresa Alati, sposò Fortunata,
altra figlia del barone Bologna. Dal loro matrimonio
nacquero Domenicantonio e Vincenzo.
Domenico Antonio ha sposato la nobildonna di Polistena,
Clementina Ierace, appartenente a una antica e nobile
famiglia presente a Polistena già alla fine del 1400.
Nel corso degli anni la famiglia Jerace ha avuto molti
uomini illustri come Fra Bernardino, minore
osservante e guardiano del monastero di Santa Chiara di
Napoli nel 1500. Nel 1800 Michelangelo Jerace,
famoso musicista che faceva parte della carboneria e tra
il 1800 e la metà del 1900 vi furono Francesco,
Vincenzo e Gaetano Ierace, scultori e
pittori famosi. Molti furono uomini ecclesiastici e
molti professionisti. Dalla loro unione è nata una sola
figlia, Fortunata Enrica che sposò il nobiluomo
di Cittanova Antonio Raso. L’altro figlio Vincenzo non
si è sposato. Ha fatto da tutore al cugino minore
Domenico, figlio dello zio Giuseppe. Vincenzo, in
paese era pronto e disponibile per chiunque avesse
bisogno, sempre pronto ad aiutare e sostenere la
popolazione. Era un vero esempio di filantropia e dopo
la sua morte, la gente decantava la sua bontà d’animo da
vero galantuomo. Nel testamento nomina suo erede il
cugino Domenico di Giuseppe. |
|
Giuseppe
de Angelis nato nel 1803, era il patriarca parenterale,
quello che manteneva i rapporti ed era il punto di
riferimento per tutta la famiglia. Si sposò con la
nobildonna Ippolita Bologna, altra figlia del barone. I
tre fratelli de Angelis avevano sposato tre sorelle,
figlie del barone Bologna. Giuseppe era il capo urbano
di Brancaleone, cioè il capo della polizia borbonica
locale, che successe a Carlo Bologna figlio del barone e
cognato suo. Il 26 luglio 1860, mentre era seduto sul
balcone, insieme al suo figlioletto Domenico di 7
anni, fu ferito alle spalle da un colpo di archibugio e
dopo cinque giorni di agonia, perì il primo agosto 1860.
Gli autori di questo omicidio non furono mai trovati,
però le indagini si chiusero considerandolo omicidio
politico per mano ignota. Proprio in quel periodo,
fermentava lo sbarco, nelle vicinanze, di Giuseppe
Garibaldi, che dal sud risaliva conquistando i luoghi
per unire l’Italia. Garibaldi sbarcò a Melito e con
successo ebbe tante adesioni. Domenico figlio di
Giuseppe è l’erede unico e universale della famiglia de
Angelis e della famiglia Bologna, ramo di Brancaleone.
Domenico, oltre alle tante proprietà con ulivi, gelsi ed
altro, era segretario e cancelliere del comune di
Brancaleone. Sposò la nobildonna Gaetana Terminelli,
figlia di Giuseppe e Carolina Del Vecchio. Dal
matrimonio di Domenico con Gaetana Terminelli sono nati
Giuseppe, Vincenzo, Marianna,
Antonia, Carolina e Concettina.
|
|
Vincenzo, nato a Brancaleone nel 1877, è stato un
importante uomo politico, fondatore del partito
socialista in Calabria e più volte deputato provinciale.
Medico e poeta, nel 1909 sposa Giovanna dei marchesi
Stranges di San Luca. |
|

Stemma della famiglia de Angelis
proveniente dalla Cattedrale di Trani ed attualmente
custodito presso il Museo diocesano
di quella città. Foto inviata da Michele Pasculli de
Angelis |
|
_________________
Note:
(1)
- “Historia degli Imperatori Greci”, descritta da NICETA
Acominato da Cone, Gran Segretario dell’Impero, Venezia
Tip. Vincenzo Valgrisi 1562.
(2) - Nella famiglia il nome
di Elena si ripete spesso. Gabriele d’Annunzio fa di
Elena Comneno l’eroina del suo romanzo “La Gloria”.
(3) - I riconoscimenti sono
riportati nei decreti di Michele VIII Paleologo in data
23 aprile 1263 e 1 giugno 1264 - Manoscritto Vaticano
11152 fol. 83.
(4) – Elena o Eleonora fu la
seconda moglie del Re Manfredi; la prima moglie fu
Beatrice, figlia del Duca di Serbia, già vedova del
marchese di Saluzzo; da questa prima moglie il Re ebbe
una figlia, Costanza, che andò in moglie a Pietro
d'Aragona.
(5) - Il Cardinale De Luca narra che il titolo di
“Illustrissimo” era riservato fino al 1300 ai soli
pontefici, imperatori, sovrani, anche se non più
regnanti, ma troviamo tale uso anche nel 1443 alla Corte
del Re Alfonso di Aragona.
(6) - Atto notar Pignatelli di Napoli in data 15
settembre 1572.
(7) - Manoscritto, firmato “Geronimo Angelo Deponj” in
data 1670, conservato nell’archivio del conte Capogrossi
Guarna.
(8) - atto notar Giordano Aniello di Napoli del 5 agosto
1508.
(9) – Camera della Sommaria – Archivio di Stato di
Napoli – vol. 128 c. 4.
(10) - Archivi Capitoli – Roma – f. 107-108 del
1555~1560.
(11) - Padre Placido di Sangro “ Dialogo delle Piazze e
Famiglie Napolitane-Napoli, 1585”.
_________________
Bibliografia:
-
Carlo Padiglione, "Note storiche araldiche e
genealogiche della nobile Famiglia Angeli o d'Angelo",
Napoli, Tipografia di Luigi Gargiulo, 1866".
- Gio. Antonio Summonte, "Historia della Città e Regno
di Napoli”, tomo II.
- J.B. Rietstap, “Armorial General” – Rolland, Paris
1903.
- Vittorio Spreti, “Enciclopedia
storico-nobiliare Italiana”, Arnaldo Forni Editore.
- G.B. di Crollalanza, “Dizionario storico-blasonico
delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e
fiorenti”, Pisa 1896.
- Francesco Bonazzi di Sannicandro, “Famiglie nobili e
titolate del Napolitano”, Arnaldo Forni Editore, 2005.
- Berardo Candida Gonzaga, “Memorie delle famiglie
nobili delle Province Meridionali d’Italia”, Napoli,
1875.
- Biblioteca Universitaria di Napoli, Manoscritto di
Gaetano Montefuscoli.
- Giuseppe Lumaga,
“Teatro della nobiltà dell'Europa ovvero Notizie delle
famiglie nobili, che in Europa vivono di presente, e che
in lei vissero prima ...”, Napoli 1725.
- Lorenzo Giustiniani , “Dizionario geografico-ragionato
del Regno di Napoli”.
- Simonetta Angelo Comneno, "Storia della Imperiale
famiglia Angelo Comneno Ducas o Angelo Flavio Comneno
Ducas", stampato da Rotostampa Group Srl, Roma.
- Mario Pisani Massamormile, “ Compagnia della Santa
Croce, sette secoli di storia a Napoli”, Electra Napoli
SpA, 2007.
|
|