|
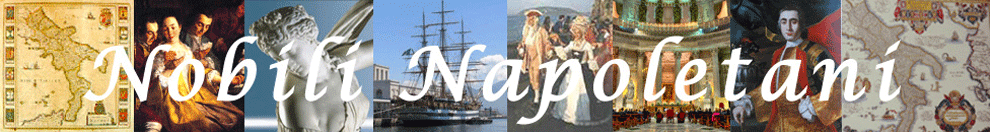
Ovvero delle Famiglie
Nobili e titolate del Napolitano, ascritte ai Sedili
di Napoli, al Libro d'Oro Napolitano, appartenenti
alle Piazze delle città del Napolitano dichiarate
chiuse, all'Elenco Regionale Napolitano o che
abbiano avuto un ruolo nelle vicende del Sud Italia.
|
|
 |
Tarsia o di Tarsia |
|
A cura del dr. Giuseppe Pizzuti |
|
Arma: scaccato d'oro e di rosso.
Patrono: San Francesco di Paola. |
|

Aversa, stemma della
famiglia Tarsia |
|
L’antica e nobilissima famiglia Tarsia o di Tarsia, di
origine normanna, prese il nome dalla terra di Tarsia
edificata in Calabria; godette di nobiltà in: Monopoli,
Conversano, e Cosenza, dove si divise in due rami detti
Tarsia
Dell'Alto
e
Tarsia Del
Basso.
I di Tarsia furono feudatari
di: Bonifati,
Bisignano,
Canna,
Casalnuovo,
Castiglione,
Corigliano,
Crucoli,
Falconara,
Fuscaldo,
Latruca,
Longano,
Nocara,
Regina,
Riccaro,
Santa Barbara,
Sant'Angelo,
Terranova,
Tinga;
patrizi di Cosenza,
baroni di Belmonte,
conti di Rossano,
Sangineto,
Corigliano e
Tarsia.
Tarsia, terra in
Calabria Citra in diocesi di Rossano, fu edificata
ai tempi dei normanni, al loro seguito giunse il
capostipite di questo ramo, il conte
Boemondo
di Tarsia, nel 1160 fu comandante in seconda dei soldati
di re
Guglielmo I, detto il Malo, costretto a fuggire in
Abruzzo, fu condannato al carcere perpetuo dallo stesso
re.
Roberto,
signore di Rossano, donò alcuni terreni alla chiesa di
Santa Caterina, fu castellano
di Barletta per l’Imperatore
Federico II di Svevia.
Matteo,
fu signore di Fuscaldo dal 1200 fino al 1223, Falconara,
e Sant'Angelo. Federico II nel 1204 lo confermò signore
di Fuscaldo e Regina, tutti feudi in Calabria Citra,
nello stesso anno confermò la donazione fatta da Matteo
dei
tenimenti di Cammarelli e Barracchi
al monastero florense di Fonte Laurato per un monastero
da fondare presso Paola.
Nicola
e
Lia
di Tarsia, risultavano dimorare nella Città di Cosenza
per essere menzionati nella platea della Cattedrale del
1223:
Nicolaus et Lia
de Tarsi pro duobus Carolenis, danarios quattuor. |
|

Napoli, Cappella famiglia di Tarsia del
XIV secolo, passata poi ad altra famiglia |
|
Carlo Goffredo
fu inviato da
re Carlo I d'Angiò
al Papa, col duca
del Balzo, Bartolomeo
Pignatelli arcivescovo di Salerno e Roberto di
Lavagna, per ottenere dilazione al pagamento delle
ottomila once d'oro dovute per censo alla Corte di Roma.
Paolo,
al tempo di Carlo I d'Angiò, era feudatario di Canna e
Nocara, terra compresa nel Giustizierato di Basilicata,
poi di Calabria Citra, gli successe nel feudo suo figlio
Federico
che fu feudatario di Casalnuovo, il 23 giugno 1272 sposò
Gaita
della Marra,
gli successe il figlio primogenito
Odoardo,
cavaliere da
re Carlo II
d'Angiò,
assoldò una compagnia di militi per difendere il Regno
ed ottenne il feudo di Terranova, fu Capitano Generale e
Giustiziere della Calabria, Consigliere Reale e Vicerè
di
Principato Citra
e
Ultra
insieme a Pietro
Ruffo conte di Catanzaro. La linea primogenita si
estinse con
Fiordiligi,
figlia di Odoardo, moglie di Guglielmo Bolardo
Dinissiaco, Maresciallo del Regno.
Jacopo,
signore di Tarsia, Canna e Nocara,
Cavaliere del S.M.O.
di Malta, fu Priore
di Messina e nel 1276 di Barletta, Generale della
Repubblica Veneta contro i Pisani; dal padre ereditò la
terra di Riccaro in Basilicata e, avendovi costruito un
castello, la chiamò Rocca Imperiale, successivamente
ricaduta in Calabria Citra. Fu consigliere di re Carlo I
d'Angiò e suo ambasciatore a Tunisi.
Ruggiero,
fu conte di Sangineto e conte di Corigliano.
Tommaso,
nel 1351 fu canonico e tesoriero della cattedrale di
Cosenza.
Odoardo,
fu Governatore di Calabria, signore di Tarsia,
Corigliano, Crucoli, Nocara, e Bonifati, ebbe per figli
Andrea
e
Roberto,
sposato a Tuccia Saraceni, figlia di Riccardo.
|
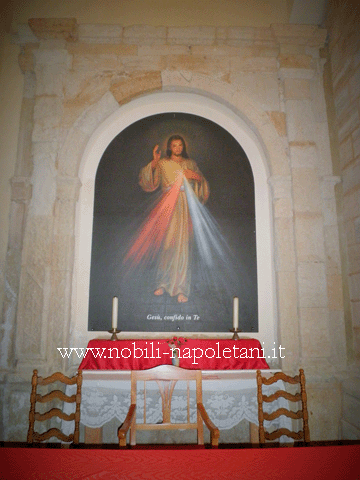 |
 |
|
Cosenza, Chiesa
di San Francesco d'Assisi, cappella di Tarsia;
quadro raffigurante San Francesco di Paola
esposto in sacrestia, un tempo collocato nella
cappella di famiglia
(1) |
Galasso (o Galeazzo)
figlio di
Roberto di Tarsia e Tuccia
Saraceni, patrizio di Cosenza, fu lo stipite
dei baroni di Belmonte; avendo combattuto sotto le
insegne di re Alfonso d’Aragona, ebbe in dono, nel
1443, la baronia di Belmonte con i feudi di Tinga (o
Tenga, o Zinghi) e Santa Barbara; fu nominato Capitano
nei regi Casali di Cosenza. Sposò Caterina
Firrao con la quale ebbero per figli:
Primarosa,
la quale sposò Marco
di Gaeta figlio di Tommaso capostipite del ramo
delle Stelle in Cosenza,
rimasta vedova si risposò con Giovan Paolo
d'Aquino,
patrizio di Cosenza, cancelliere di Bernardino
Sanseverino
principe di Bisignano, dal quale ottenne il feudo di
Vennere presso Castelfranco;
Francesco;
Angelo,
giustiziato dai francesi nel 1495 in quanto partigiano
aragonese;
Giovanni;
Giacomo
ed il primogenito
Nicola
(† 1462 c.a), patrizio di Cosenza, successe a suo padre, fu
costretto a lasciare la baronia a causa dell'invasione
del duca Giovanni d'Angiò andando a prestare servizio
come soldato semplice nel regio esercito, i suoi beni,
dei quali fu spogliata la famiglia, gli vennero
riconsegnati con la riconquista, un po' per volta
(2).
Giacomo (†
1492), patrizio di Cosenza, fratello di Nicola, successe
nel feudo di Belmonte; il 24 settembre del 1463 re
Ferdinando scrisse una lettera al duca di Calabria con
la quale ordinava: "ritornando all'ubbidienza la terra
di Belmonte quale fu del magnifico quondam Galasso de
Tarsia grandissimo parciale del re Alfonso, se ne faccia
de continente la consegna a Giacomo"; l'anno successivo
gli furono restituiti anche i feudi di Tinga e Santa
Barbara. Fu sindaco dei nobili di Cosenza nell'anno
1473, fu inviato a Napoli, con Paolo
di Francia, sindaco degli onorati cittadini,
presso re Ferdinando per chiedere la concessione di
alcuni privilegi per la Città. Si narra che: Giacomo,
affetto da una piaga cancerosa ad una gamba, fu guarito
da un’erba poggiata sulla ferita da San Francesco di
Paola; fu riconosciuto come uno dei grandi benefattori
del nascente Ordine dei Minimi. Sposò Giovanna
Cavalcanti dei baroni di Sartano, con la
quale ebbero quattro figlie femmine, tra di esse:
Sigismonda (o Ghismonda) la quale sposò,
nel 1509, Pietro Paolo
Parisio (1473 †
1545), il quale, rimasto vedovo, avendo perduto
anche l'unico figlio, vestì l'abito ecclesiastico,
divenne prima vescovo e poi cardinale;
Polissena, sposò Nicolò Cavalcanti; per
maschi ebbero:
Francesco
(† 1553
c.a), soprannominato Capodiferro, fu vicerè degli
Abruzzi e cinque volte Reggente della
Gran
Corte della Vicaria, comandò mille fanti in
Lombardia al servizio dell’Imperatore
Carlo V d'Asburgo-Spagna. Ebbe come figli:
Gio.
Pietro,
Caterina,
Eufrosina,
il primogenito fu
Galeazzo. |
|
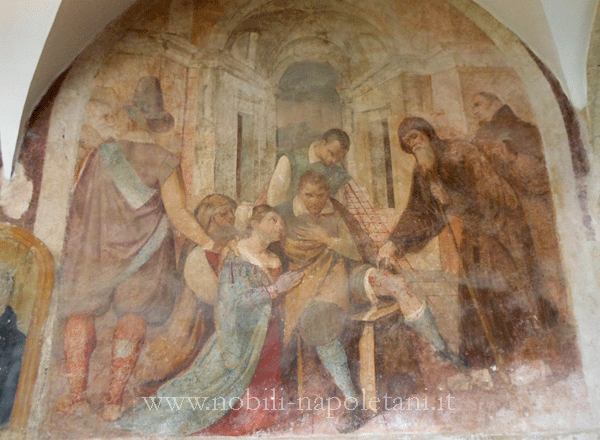
Paola, Santuario di San
Francesco di Paola; il Santo guarisce Giacomo di Tarsia
da una piaga cancerosa |
|
Galeazzo II
(1450 c.a † 1513),
figlio di Giacomo e Giovanna Cavalcanti, patrizio di
Cosenza, barone di Belmonte, Capitano di Guerra, servì
Carlo VIII, due volte Reggente della Gran Corte della
Vicaria, fu consigliere di guerra di re Federico, il
quale nel 1599, gli scrisse di dare aiuto e consiglio a
Traiano
Mormile e ad Alfonso
Caracciolo, inviati in Calabria per reclutare
500 fanti. Il 21 settembre del 1505, re Ferdinando gli
confermava la baronia di Belmonte ed i feudi di Tinga e
Santa Barbara, il 27 dello stesso mese, quello della
capitanìa a guerra dei Casali di Cosenza. Sposò Giovanna
Sanseverino, figlia
del principe di
Bisignano Girolamo, con la quale ebbero dieci figli:
Elisabetta, sposò Alfonso
Firrao
di Cosenza;
Orsolina;
Anna,
sposò Giovanbattista Cavalcanti;
Prospero;
Federico;
Giacomo,
domenicano, cappellano del castello di Cosenza;
Giovanbattista;
Bernardino, cappellano regio;
Gio. Tommaso,
abbate dell'abbazia Florenze di San Giovanni in Fiore;
ed il primogenito
Vincenzo
(1480 c.a † 1530),
patrizio di Cosenza e barone di Belmonte, investito
nello stato ed i feudi di suo padre il 9 maggio del 1513
dal re Cattolico, inoltre, fu investito della capitanìa
dei Casali di Cosenza; uomo molto colto, fu uno dei
primi esponenti dell'Accademia Cosentina fondata da Aulo
Giano Parrasio in quegli stessi anni. Sposò Caterina del
Persico figlia di Broccardo dei conti di Sabbioneta e di
Maria
di Somma; le
nozze furono celebrate a Belmonte, ma, risiedettero tra
Napoli e Cosenza, ebbero sette figli:
Diana,
Livia,
Violante,
Lucrezia,
Cola
Francesco,
Tiberio
ed il primogenito
|
.gif)
Belmonte Calabro
(Cosenza) |
Galeazzo III di Tarsia (Napoli,
1520 c.a † 5 giugno
1553) figlio di Vincenzo, barone di Belmonte, signore di
Santa Barbara ecc...; poeta, Accademico Cosentino. Nel
1547 confinato a Lipari dopo che la Gran Corte della
Vicarìa lo aveva condannato con l'accusa di
violenze a
vergini et coniugate, di percosse, ferite et anche morti
in
persone di
vaxalli...; pare morì ucciso, forse a
Napoli, dai fratelli Giovan Battista e Giovanni Antonio
de Alagno,
come si evince da una procura che le sorelle di
Galeazzo, Diana, Lucrezia e Livia, rilasciarono il 2
novembre 1559 a Giovanni
Monaco,
originario di Cosenza ma dimorante a Napoli, per
rappresentarle nella causa contro gli uccisori di
Galeazzo presso la Magna Curia della Vicarìa e del Sacro
Collegio, notaio Angelo Desideri di Cosenza
(2bis). Sposò Camilla
Carafa che gli premorì giovanissima; scrisse
per lei le sue migliori rime, altre rime le scrisse per
Vittoria
Colonna; ebbero una sola figlia,
Giulia,
la quale a soli dieci anni gli successe nel feudo ma
morì l'anno seguente.
|
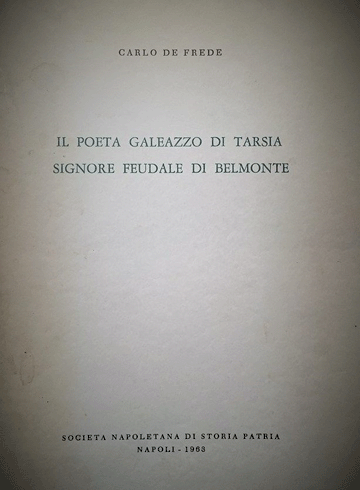
Opera di Carlo De Frede |

Galeazzo di Tarsia |
Tiberio di Tarsia (†
1570) zio di Giulia gli successe come 7° barone di
Belmonte ed ebbe significatoria di rilevio il 20 giugno
del 1554. Si indebitò a tal punto da esser costretto a
vendere il feudo nel 1564 a Camillo
Sersale col patto redimenti, ma, ad istanza dei
creditori dovette intervenire il Regio Fisco
sequestrandolo; sposò in prime nozze Lucrezia
Toraldo di Adamo barone di Badolato vedova di suo
zio
Prospero, ed in seconde nozze Enrichetta
Sanseverino figlia del duca di Somma.
Diana
di Tarsia, sorella di Tiberio, sposata a Pietro Antonio
Firrao, nel 1576 acquistò dal Regio Fisco il
feudo di Belmonte cercando di soddisfare i creditori e
salvare il feudo di famiglia, dopo due anni fu costretta
a venderlo al patrizio genovese Torino
Ravaschieri
(3).
Diana, precedentemente, aveva acquistato il feudo
disabitato di Massanova (in territorio di Cutro) per
ducati 7.000 messo all'asta dal Sacro Regio Consiglio in
danno di Scipione Firrao, suo cognato, nonostante nel
suo testamento lo avesse lasciato alla primogenita
Ippolita sposata con Tommaso Firrao, suo cugino e figlio
di Diana, seguì il Regio Assenso del 1572; lo vendette
ad Ottavio
Lucifero,
nobile di Crotone, per ducati 14.000, con Regio Assenso
del 1584, il quale sposò Porzia Firrao, secondogenita di
Scipione e sorella di Ippolita.
|
|
I di Tarsia ed il Feudo di Longano o Perrotta |
|
Feudo sito in territorio di Crotone, detto anche la
Gabella di Capoferro, da non confondere con il vicino
feudo di Valle Perrotta posseduto dai baroni
Pallone
di Scigliano e da questi acquistato dai
Berlingieri
sul quale ottennero il titolo di marchese.
Galasso di Tarsia,
barone di Belmonte,
possedeva nel 1451 il feudo detto "Lagani
et Li Valli de Perrocta", come risulta da un
privilegio emesso in suo favore dal Viceré di Calabria
Francesco de Siscar il 26 febbraio 1451
(4).
Successe nel feudo suo figlio
Giacomo
(† 1492), barone di
Belmonte, anche questo feudo, come citato sopra per gli
altri beni, la famiglia ne fu spogliata "Magnifico
messer Iacobo di Tarsia quondam Galasso de Tarsia,
restitutione de certe territorij feudali, nominati li
Lagami et la Valle de Perotta"
(Archivio di Stato di Napoli; Regia Camera della
Sommaria, inventario 1468-1688, inventario 5, 28v,
f.155).
Come
per gli altri beni, è da presupporre che anche questo
feudo fu restituito in quanto successivamente ne
risultava in possesso
Beatrice
di Tarsia († marzo 1577), sposata a Giovanni Francesco
di Gaeta,
giureconsulto, figlio di Vincenzo ed Ippolita Mazza di
Taverna, il loro figlio Giovan Paolo di Gaeta († 1596)
il 7 maggio del 1578 ebbe significatoria di rilevio per
il feudo di Longano come erede per la morte di sua
madre, baronessa Beatrice
(5). |
|
Alcune parentele contratte dal casato, oltre quelle già
citate:
Bisantia,
sposò Antonio de Mitio detti
Schinosi,
nel 1401 si trasferirono a Molfetta.
Margherita
di Tarsia sposò Margheritone
Caselli,
signore di Cervicati, cavaliere di Luigi III d'Angiò-Valois,
9° duca di Calabria.
Lucio,
patrizio di Cosenza, nel 1647 aveva affittato il feudo
di Canna e Nocara, già posseduto dai suoi avi, in quanto
era ricaduto alla Regia Corte nel 1644 per la morte
senza eredi del marchese Donato Antonio
Loffredo
sposato ad Emilia, figlia di Giovan Battista
Spinelli,
2° principe di Scalea. Successivamente il feudo fu
venduto dalla Regia Corte, per ducati 29.000, ad
Isabella Merlini, marchesa di Ramonte, con Regio Assenso
del 1653. Lucio sposò Angela
Sanseverino,
ed ebbero per figlia
Laura,
sposata a Pietro Antonio Toscano di Oriolo. Alla
famiglia apparteneva la Cappella di Sant'Antonio Abate,
dell'Ordine
Costantiniano di San Giorgio,
eretta nel 1507.
Tiberio
ed
Alessandro,
vissuti nel Seicento, furono discendenti dei baroni di
Belmonte.
Giuseppe,
vissuto nel Seicento, sposò Flavia
Barracco,
figlia di Francesco Antonio e di Elisabetta
Donato.
Giacomo Maria
(1710 † 1782), patrizio di Cosenza, figlio di
Francesco
e di Vittoria
Castiglione Morelli,
entrò nell'Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola,
fu vescovo di Martirano dal 1770 al 1782, oggi diocesi
soppressa. |
|
Scrive il marchese Salvatore
Spiriti nella riedizione delle rime di Galeazzo di
Tarsia del 1758: "...le magnifiche abitazioni poste a
canto del detto fiume: cioè della Famiglia
Gaeta a man destra del gran ponte, che conduce al
Palagio residenza del Preside della Provincia; e del
Casato di Tarsia a man sinistra dentro la strada detta
de' Cassari... fino agli ultimi nostri tempi si vedeva
nel muro una iscrizione..... Domun hac Tiberius de
Tarsia Belmontis aliorumque oppidorum Dominus
restauravit, Veruis Hermisque decoravit anno D. 1587." |
|

Cosenza, Palazzo di
Tarsia, cortile interno |
|
___________________
Note:
(1)
- Riportiamo uno stralcio dell'articolo
pubblicato sul settimanale di Informazione
dell'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano Parole di
Vita: Il termine "cappella" indica innanzi tutto una
"istituzione". Essa può essere promossa da chiunque
(singola persona, famiglia o comunità di fedeli) per
praticare un culto particolare approvato dalla Chiesa,
ed è canonicamente istituita con decreto del Vescovo del
luogo o del Papa. Come le attuali "fondazioni" civili,
ogni cappella deve essere sostenuta da una fonte di
reddito chiaramente indicata. Il fondatore di una
cappella canonicamente approvata può presentare al
Vescovo o al Papa anche il nome del "cappellano", cioè
del sacerdote al quale affidare il servizio del culto
liturgico. In passato questa presentazione poteva dar
luogo al diritto di "patronato", ovvero all'obbligo
dell'autorità competente di nominare il sacerdote
presentato dal "patrono". Attualmente, il canone 565 del
vigente Codice di Diritto Canonico (promulgato il 25
gennaio 1983) ha riservato il diritto di nomina al
Vescovo del luogo, salvo casi esplicitamente indicati
dalle leggi canoniche o dall'autorità ecclesiastica
competente. La cappella può essere istituita in un
edificio proprio, all'interno di una casa privata oppure
in una chiesa. In quest'ultimo caso deve essere dotata
di un segno visibile (quadro o statua o altare) con o
senza uno spazio proprio intorno.
(2) -
Bartelli Francesco, nell'opera citata in bibliografia,
scrive che Nicola successe al padre; Mario Pellicano
Castagna, nell'opera citata nella nota successiva,
scrive di non aver trovato informazioni riguardo a
Nicola ed in particolare non risulta intestatario del
feudo. Possiamo ragionevolmente supporre che: Nicola, a
causa degli eventi nefasti, non abbia avuto il tempo
d'intestarsi il feudo; altrimenti si potrebbe ipotizzare
che premorì al padre.
(2bis)
- Domenico Puntillo, Cinzia Citraro in "Historia
Brutiorum - Bernardino
Bombini",
pag. 117, Edizioni Prometeo, Castrovillari 2015.
(3)
-
Mario Pellicano Castagna "La Storia dei Feudi e dei
Titoli Nobiliari della Calabria" Vol. I pagg. 195-196; Frama Sud
1984.
(4) - Mario
Pellicano Castagna "La Storia dei Feudi e dei Titoli
Nobiliari della Calabria" Vol. III pag. 22; Editrice
C.B.C. 1999.
(5) - Ibidem.
_________________
Fonti bibliografiche:
- Biagio Aldimari, "Memorie historiche di diverse
famiglie nobili...", Napoli 1691.
- Berardo Candida Gonzaga, " Memorie delle famiglie
nobili", Napoli 1875.
- Luigi Palmieri, "Cosenza e le sue
famiglie attraverso testi atti e manoscritti",
Pellegrini Editore, 1999.
- Lorenzo Giustiniani, "Dizionario geografico-ragionato
del Regno di Napoli", Napoli 1797-1816.
- Francesco Bonazzi di Sannicandro, "Elenco dei
Cavalieri del S.M. Ordine di S. Giovanni di
Gerusalemme", Napoli 1897.
- Sito web
http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/829.
- Bartelli Francesco in " Note biografiche: Bernardino
Telesio, Galeazzo di Tarsia"; Trippa, 1906.
|
|